
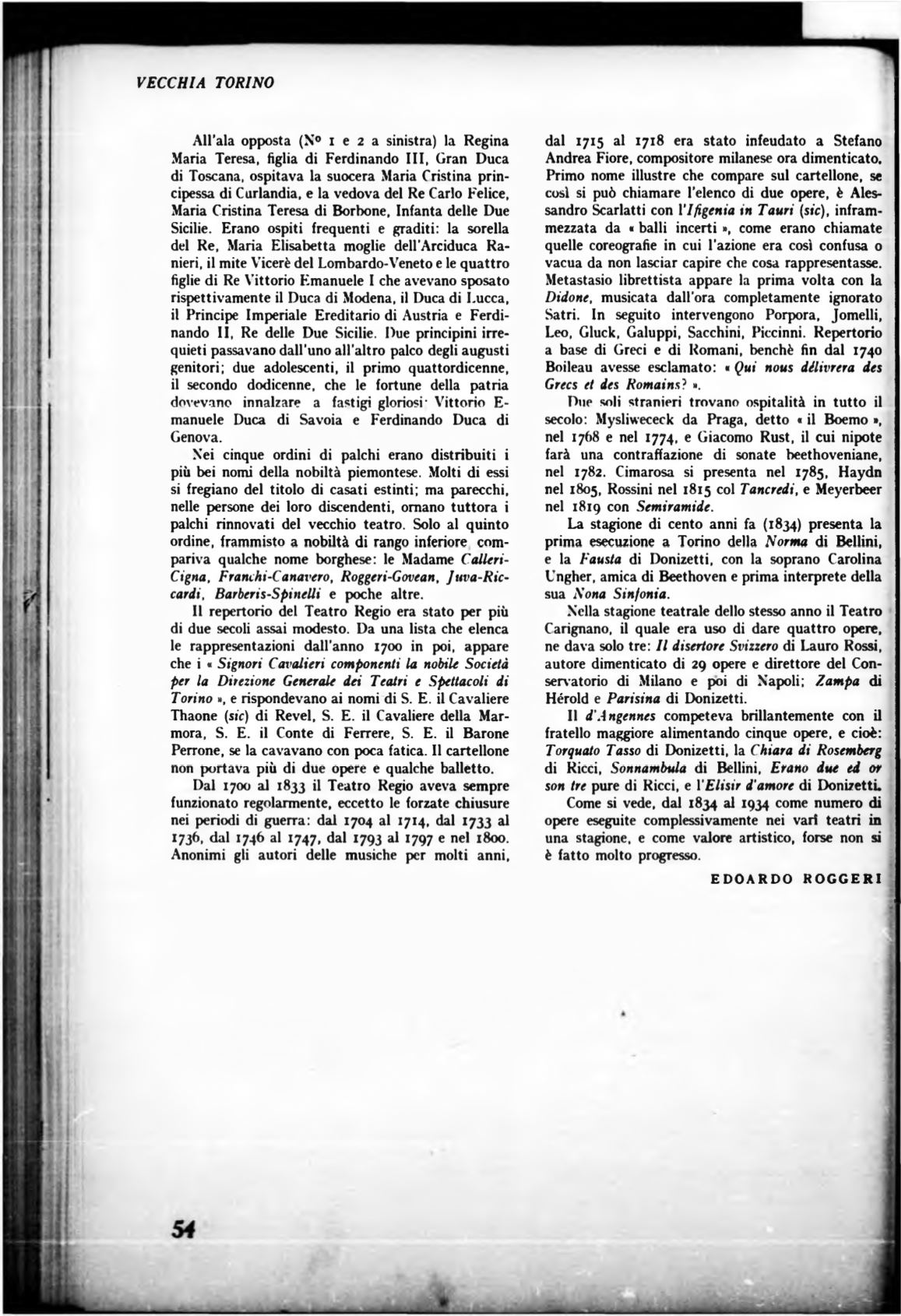
VECCHIA TORINO
All’ala opposta (N° i e 2 a sinistra) la Regina
Maria Teresa, figlia di Ferdinando III, Gran Duca
di Toscana, ospitava la suocera Maria Cristina prin
cipessa di Curlandia, e la vedova del Re Carlo Felice,
Maria Cristina Teresa di Borbone, Infanta delle Due
Sicilie. Erano ospiti frequenti e graditi: la sorella
del Re, Maria Elisabetta moglie dell’Arciduca Ra
nieri, il mite Viceré del Lombardo-Veneto e le quattro
figlie di Re Vittorio Emanuele I che avevano sposato
rispettivamente il Duca di Modena, il Duca di Lucca,
il Principe Imperiale Ereditario di Austria e Ferdi
nando II, Re delle Due Sicilie. Due principini irre
quieti passavano dall’uno all’altro palco degli augusti
genitori: due adolescenti, il primo quattordicenne,
il secondo dodicenne, che le fortune della patria
dovevano innalzare a fastigi gloriosi- Vittorio E-
manuele Duca di Savoia e Ferdinando Duca di
Genova.
Nei cinque ordini di palchi erano distribuiti i
più bei nomi della nobiltà piemontese. Molti di essi
si fregiano del titolo di casati estinti; ma parecchi,
nelle persone dei loro discendenti, ornano tuttora i
palchi rinnovati del vecchio teatro. Solo al quinto
ordine, frammisto a nobiltà di rango inferiore com
pariva qualche nome borghese: le Madame
Calleri-
Cigna, Franchi-Canavero, Roggeri-Govean, Juva-Ric
cardi, Barberis-Spitulli
e poche altre.
Il
repertorio del Teatro Regio era stato per più
di due secoli assai modesto. Da una lista che elenca
le rappresentazioni dall’anno 1700 in poi, appare
che i «
Signori Cavalieri componenti la nobile Società
per la Direzione Generale dei Teatri e Spettacoli di
Torino
», e rispondevano ai nomi di S. E. il Cavaliere
Thaone
(sic)
di Revel, S. E. il Cavaliere della Mar
mora, S. E. il Conte di Ferrere, S. E. il Barone
Perrone, se la cavavano con poca fatica. Il cartellone
non portava più di due opere e qualche balletto.
Dal 1700 al 1833 il Teatro Regio aveva sempre
funzionato regolarmente, eccetto le forzate chiusure
nei periodi di guerra: dal 1704 al 1714, dal 1733 al
1736, dal 1746 al 1747, dal 1793 al 1797 e nel 1800.
Anonimi gli autori delle musiche per molti anni,
dal 1715 al 1718 era stato infeudato a Stefano
Andrea Fiore, compositore milanese ora dimenticato.
Primo nome illustre che compare sul cartellone, se
così si può chiamare l’elenco di due opere, è Ales
sandro Scarlatti con
VIfigenia in Tauri (sic),
infram
mezzata da «balli incerti », come erano chiamate
quelle coreografie in cui l ’azione era così confusa o
vacua da non lasciar capire che cosa rappresentasse.
Metastasio librettista appare la prima volta con la
Diione,
musicata dall’ora completamente ignorato
Satri. In seguito intervengono Porpora, Jomelli,
Leo, Gluck, Galuppi, Sacchini, Piccinni. Repertorio
a base di Greci e di Romani, benché fin dal 1740
Boileau avesse esclamato: «
Qui nous délivrera des
Grecs et des Romains
? ».
Due soli stranieri trovano ospitalità in tutto il
secolo: Mysliwececk da Praga, detto « il Boemo »,
nel 1768 e nel 1774, e Giacomo Rust, il cui nipote
farà una contraffazione di sonate beethoveniane,
nel 1782. Cimarosa si presenta nel 1785, Haydn
nel 1805, Rossini nel 1815 col
Tancredi,
e Meyerbeer
nel 1819 con
Semiramide.
La stagione di cento anni fa (1834) presenta la
prima esecuzione a Torino della
Norma
di Bellini,
e la
Fausta
di Donizetti, con la soprano Carolina
Ungher, amica di Beethoven e prima interprete della
sua
Nona Sinfonia.
Nella stagione teatrale dello stesso anno il Teatro
Carignano, il quale era uso di dare quattro opere,
ne dava solo tre:
I l disertore Svizzero
di Lauro Rossi,
autore dimenticato di 29 opere e direttore del Con
servatorio di Milano e poi di Napoli;
Zampa
di
Hérold e
Parisina
di Donizetti.
Il
d’Angennes
competeva brillantemente con i
fratello maggiore alimentando cinque opere, e cioè:
Torquato Tasso
di Donizetti, la
Chiara di Rosemberg
di Ricci,
Sonnambula
di Bellini,
Erano due ed or
son tre
pure di Ricci, e l’
Elisir d’amore
di Donizetti.
Come si vede, dal 1834 al 1934 come numero di
opere eseguite complessivamente nei vari teatri in
una stagione, e come valore artistico, forse non si
è fatto molto progresso.
E D O A R D O R O G G E R I


















