
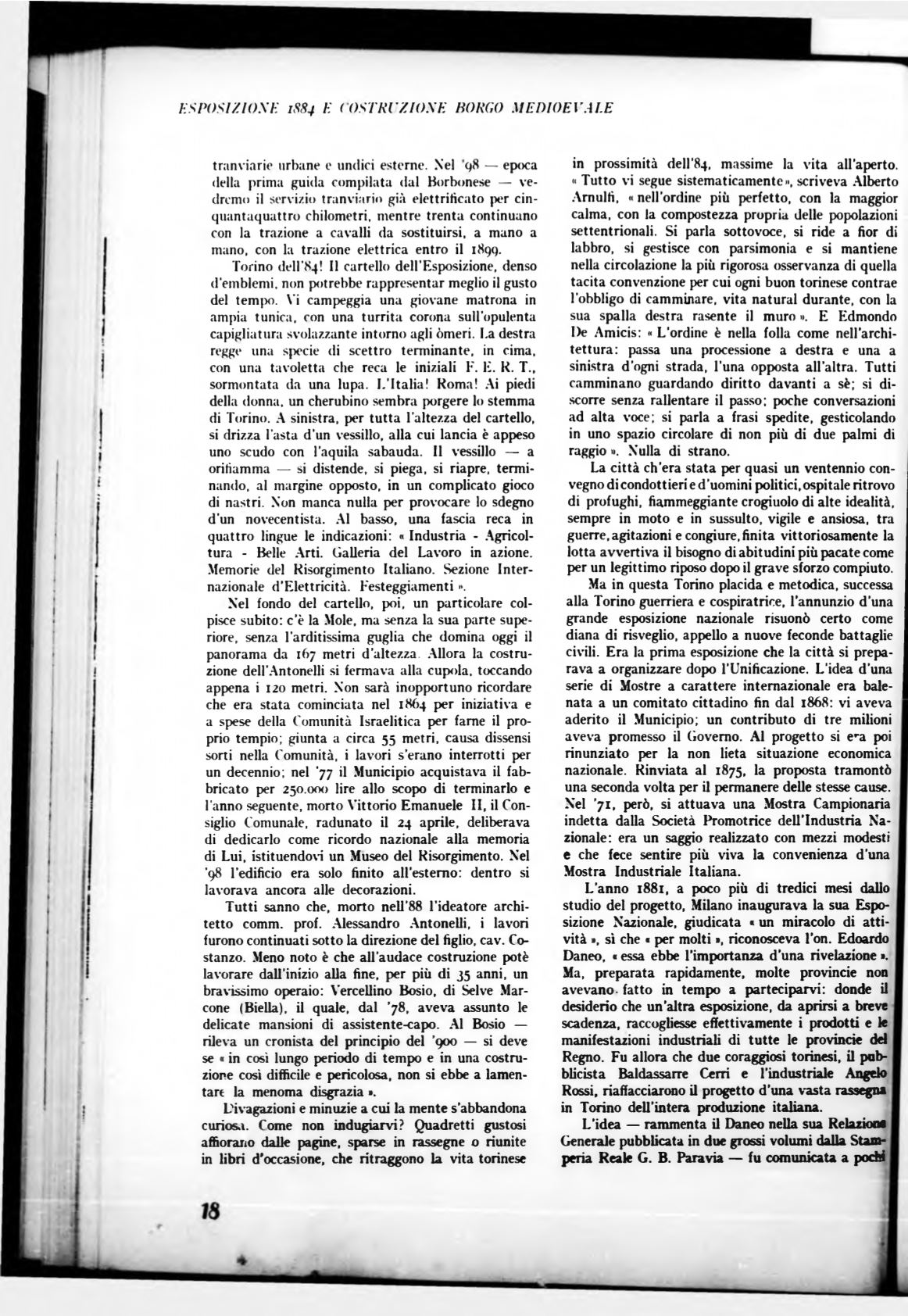
ESPOSI Z IOSE 1SS4 E (OSTR I 'Z I OS E BORGO MEDIOEVALE
tranviarie urbane e undici esterne. Nel 98 — epoca
della prima guida compilata dal Borbonese — ve
dremo il servizio tranviario già elettrificato per cin-
quantaquattro chilometri, mentre trenta continuano
con la trazione a cavalli da sostituirsi, a mano a
mano, con la trazione elettrica entro il 1899.
Torino dell’84! Il cartello dell'Esposizione, denso
d’emblemi, non potrebbe rappresentar meglio il gusto
del tempo. Vi campeggia una giovane matrona in
ampia tunica, con una turrita corona sull’opulenta
capigliatura svolazzante intorno agli òmeri. La destra
regge una specie di scettro terminante, in cima,
con una tavoletta che reca le iniziali F. li. R. T.,
sormontata da una lupa. L ’Italia! Roma! Ai piedi
della donna, un cherubino sembra porgere lo stemma
di Torino. A sinistra, per tutta l ’altezza del cartello,
si drizza l’asta d’un vessillo, alla cui lancia è appeso
uno scudo con l’aquila sabauda. Il vessillo — a
oritìamma — si distende, si piega, si riapre, termi
nando, al margine opposto, in un complicato gioco
di nastri. Non manca nulla per provocare lo sdegno
d’un novecentista. Al basso, una fascia reca in
quattro lingue le indicazioni: « Industria - Agricol
tura - Belle Arti. Galleria del Lavoro in azione.
Memorie del Risorgimento Italiano. Sezione Inter
nazionale d’Elettricità. Festeggiamenti ».
Nel fondo del cartello, poi, un particolare col
pisce subito: c ’è la Mole, ma senza la sua parte supe
riore, senza l’arditissima guglia che domina oggi il
panorama da 167 metri d’altezza. Allora la costru
zione dell’Antonelli si fermava alla cupola, toccando
appena i 120 metri. Non sarà inopportuno ricordare
che era stata cominciata nel 1864 per iniziativa e
a spese della Comunità Israelitica per fame il pro
prio tempio; giunta a circa 55 metri, causa dissensi
sorti nella Comunità, i lavori s’erano interrotti per
un decennio: nel '77 il Municipio acquistava il fab
bricato per 250.000 lire allo scopo di terminarlo e
l'anno seguente, morto Vittorio Emanuele II, il Con
siglio Comunale, radunato il 24 aprile, deliberava
di dedicarlo come ricordo nazionale alla memoria
di Lui, istituendovi un Museo del Risorgimento. Nel
'98 l’edificio era solo finito aH’estemo: dentro si
lavorava ancora alle decorazioni.
Tutti sanno che, morto nell’88 l ’ideatore archi
tetto comm. prof. Alessandro Antonelli, i lavori
furono continuati sotto la direzione del figlio, cav. Co
stanzo. Meno noto è che all’audace costruzione potè
lavorare dall’inizio alla fine, per più di 35 anni, un
bravissimo operaio: Vercellino Bosio, di Selve Mar-
cone (Biella), il quale, dal '78, aveva assunto le
delicate mansioni di assistente-capo. Al Bosio —
rileva un cronista del principio del '900 — si deve
se « in cosi lungo periodo di tempo e in una costru
zione così difficile e pericolosa, non si ebbe a lamen
tare la menoma disgrazia ».
Divagazioni e minuzie a cui la mente s’abbandona
curiosa. Come non indugiarvi? Quadretti gustosi
affiorano dalle pagine, sparse in rassegne o riunite
in libri d’occasione, che ritraggono la vita torinese
in prossimità dell’84, massime la vita all’aperto.
« Tutto vi segue sistematicamente», scriveva Alberto
Arnulfi, «nell’ordine più perfetto, con la maggior
calma, con la compostezza propria delle popolazioni
settentrionali. Si parla sottovoce, si ride a fior di
labbro, si gestisce con parsimonia e si mantiene
nella circolazione la più rigorosa osservanza di quella
tacita convenzione per cui ogni buon torinese contrae
l’obbligo di camminare, vita naturai durante, con la
sua spalla destra rasente il muro ». E Edmondo
De Amicis: « L ’ordine è nella folla come nell’archi
tettura: passa una processione a destra e una a
sinistra d ’ogni strada, Luna opposta all’altra. Tutti
camminano guardando diritto davanti a sè; si di
scorre senza rallentare il passo; poche conversazioni
ad alta voce; si parla a frasi spedite, gesticolando
in uno spazio circolare di non più di due palmi di
raggio ». Nulla di strano.
La città ch’era stata per quasi un ventennio con
vegno di condottieri e d’uomini politici, ospitale ritrovo
di profughi, fiammeggiante crogiuolo di alte idealità,
sempre in moto e in sussulto, vigile e ansiosa, tra
guerre, agitazioni e congiure, finita vittoriosamente la
lotta avvertiva il bisogno di abitudini più pacate come
per un legittimo riposo dopo il grave sforzo compiuto.
Ma in questa Torino placida e metodica, successa
alla Torino guerriera e cospiratrice, l’annunzio d’una
grande esposizione nazionale risuonò certo come
diana di risveglio, appello a nuove feconde battaglie
civili. Era la prima esposizione che la città si prepa
rava a organizzare dopo l’Unificazione. L ’idea d’una
serie di Mostre a carattere intemazionale era bale
nata a un comitato cittadino fin dal 1868: vi aveva
aderito il Municipio; un contributo di tre milioni
aveva promesso il Governo. Al progetto si era poi
rinunziato per la non lieta situazione economica
nazionale. Rinviata al 1875, la proposta tramontò
una seconda volta per il permanere delle stesse cause.
Nel '71, però, si attuava una Mostra Campionaria
indetta dalla Società Promotrice dell’industria Na
zionale: era un saggio realizzato con mezzi modesti
e che fece sentire più viva la convenienza d’una
Mostra Industriale Italiana.
L ’anno 1881. a poco più di tredici mesi dallo
studio del progetto, Milano inaugurava la sua Espo
sizione Nazionale, giudicata « un miracolo di atti
vità », si che « per molti », riconosceva l ’on. Edoardo
Daneo, «essa ebbe l’importanza d’una rivelazione ».
Ma, preparata rapidamente, molte provincie non
avevano- fatto in tempo a parteciparvi: donde il
desiderio che un’altra esposizione, da aprirsi a breve
scadenza, raccogliesse effettivamente i prodotti e le
manifestazioni industriali di tutte le provincie del
Regno. Fu allora che due coraggiosi torinesi, il pub
blicista Baldassarre Cerri e l’industriale Angelo
Rossi, riaffacciarono il progetto d’una vasta rassegna
in Torino dell’intera produzione italiana.
L ’idea — rammenta il Daneo nella sua Relazione
Generale pubblicata in due grossi volumi dalla Stam
peria Reale G. B. Paravia — fu comunicata a pochi


















