
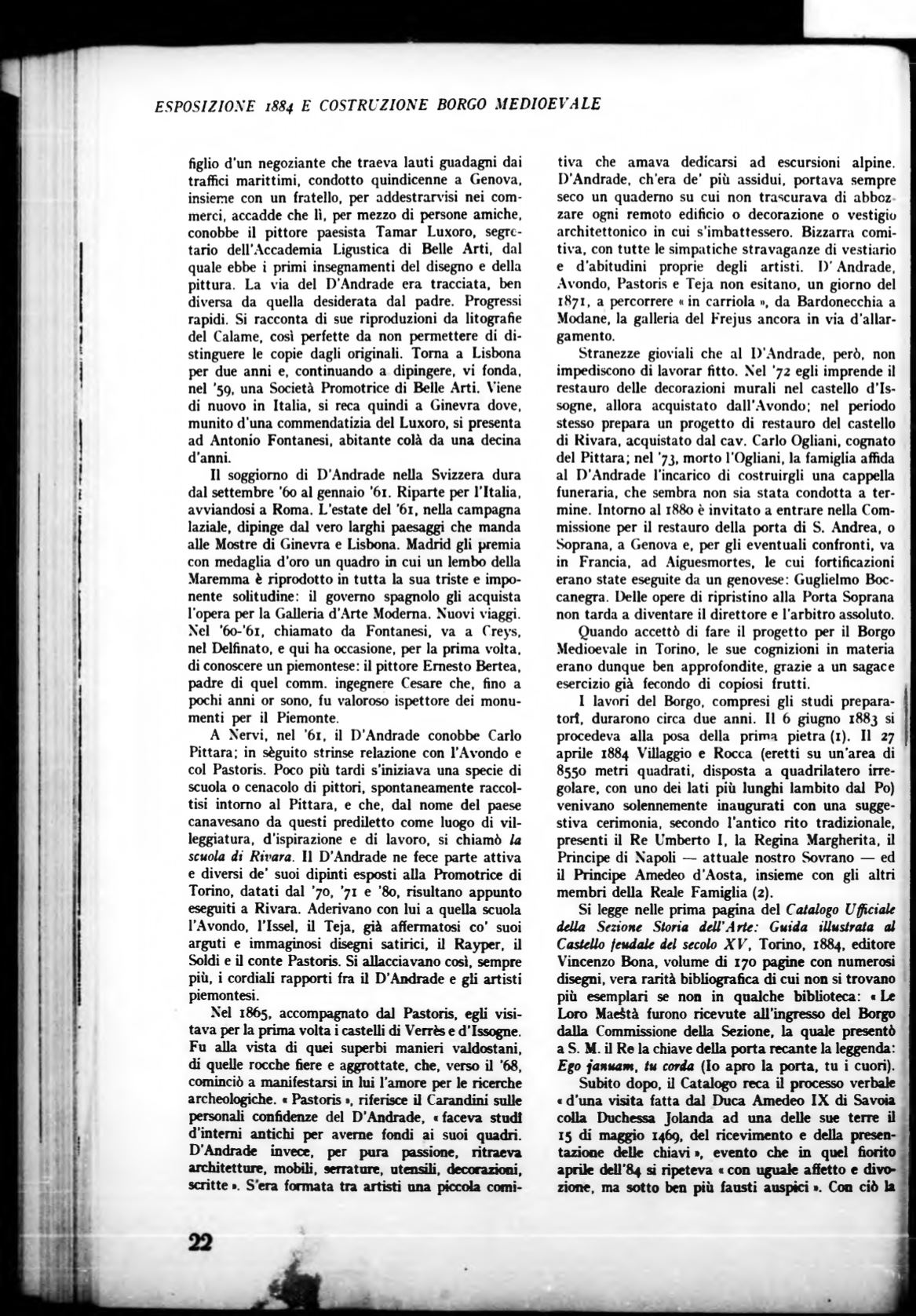
ESPOSIZIONE 1884 E COSTRUZIONE BORGO MEDIOEVALE
figlio d’un negoziante che traeva lauti guadagni dai
traffici marittimi, condotto quindicenne a Genova,
insieme con un fratello, per addestrarvisi nei com
merci, accadde che lì, per mezzo di persone amiche,
conobbe il pittore paesista Tamar Luxoro, segre
tario dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, dal
quale ebbe i primi insegnamenti del disegno e della
pittura. La via del D’Andrade era tracciata, ben
diversa da quella desiderata dal padre. Progressi
rapidi. Si racconta di sue riproduzioni da litografie
del Calarne, così perfette da non permettere di di
stinguere le copie dagli originali. Torna a Lisbona
per due anni e, continuando a dipingere, vi fonda,
nel '59, una Società Promotrice di Belle Arti. Viene
di nuovo in Italia, si reca quindi a Ginevra dove,
munito d’una commendatizia del Luxoro, si presenta
ad Antonio Fontanesi, abitante colà da una decina
d’anni.
Il soggiorno di D’Andrade nella Svizzera dura
dal settembre ’6o al gennaio ’6i. Riparte per l ’Italia,
avviandosi a Roma. L ’estate del ’6i, nella campagna
laziale, dipinge dal vero larghi paesaggi che manda
alle Mostre di Ginevra e Lisbona. Madrid gli premia
con medaglia d’oro un quadro in cui un lembo della
Maremma è riprodotto in tutta la sua triste e impo
nente solitudine: il governo spagnolo gli acquista
l'opera per la Galleria d’Arte Moderna. Nuovi viaggi.
Nel ’6o-’6i, chiamato da Fontanesi, va a Creys,
nel Delfinato, e qui ha occasione, per la prima volta,
di conoscere un piemontese: il pittore Ernesto Bertea,
padre di quel comm. ingegnere Cesare che, fino a
pochi anni or sono, fu valoroso ispettore dei monu
menti per il Piemonte.
A Nervi, nel ’6i, il D’Andrade conobbe Carlo
Pittara; in sèguito strinse relazione con l’Avondo e
col Pastoris. Poco più tardi s’iniziava una specie di
scuola o cenacolo di pittori, spontaneamente raccol
tisi intorno al Pittara, e che, dal nome del paese
canavesano da questi prediletto come luogo di vil
leggiatura, d ’ispirazione e di lavoro, si chiamò
la
scuola di Rivara.
Il D’Andrade ne fece parte attiva
e diversi de’ suoi dipinti esposti alla Promotrice di
Torino, datati dal '70, '71 e ’8o, risultano appunto
eseguiti a Rivara. Aderivano con lui a quella scuola
l’Avondo, l’Issel, il Teja, già affermatosi co’ suoi
arguti e immaginosi disegni satirici, il Rayper, il
Soldi e il conte Pastoris. Si allacciavano così, sempre
più, i cordiali rapporti fra il D’Andrade e gli artisti
piemontesi.
Nel 1865, accompagnato dal Pastoris, egli visi
tava per la prima volta i castelli di Verrès e d’Issogne.
Fu alla vista di quei superbi manieri valdostani,
di quelle rocche fiere e aggrottate, che, verso il ’68,
cominciò a manifestarsi in lui l’amore per le ricerche
archeologiche. « Pastoris », riferisce il Carandini sulle
personali confidenze del D’Andrade, «faceva studi
d’interni antichi per averne fondi ai suoi quadri.
D’Andrade invece, per pura passione, ritraeva
architetture, mobili, serrature, utensili, decorazioni,
scritte ». Sera formata tra artisti una piccola comi
tiva che amava dedicarsi ad escursioni alpine.
D’Andrade, ch’era de’ più assidui, portava sempre
seco un quaderno su cui non trascurava di abboz
zare ogni remoto edificio o decorazione o vestigio
architettonico in cui s’imbattessero. Bizzarra comi
tiva, con tutte le simpatiche stravaganze di vestiario
e d ’abitudini proprie degli artisti. I)’ Andrade,
Avondo, Pastoris e Teja non esitano, un giorno del
1871, a percorrere « in carriola », da Bardonecchia a
Modane, la galleria del Frejus ancora in via d’allar
gamento.
Stranezze gioviali che al D’Andrade, però, non
impediscono di lavorar fitto. Nel '72 egli imprende il
restauro delle decorazioni murali nel castello d’Is-
sogne, allora acquistato dall’Avondo; nel periodo
stesso prepara un progetto di restauro del castello
di Rivara, acquistato dal cav. Carlo Ogliani, cognato
del Pittara; nel '73, morto l ’Ogliani, la famiglia affida
al D’Andrade l'incarico di costruirgli una cappella
funeraria, che sembra non sia stata condotta a ter
mine. Intorno al 1880 è invitato a entrare nella Com
missione per il restauro della porta di S. Andrea, 0
Soprana, a Genova e, per gli eventuali confronti, va
in Francia, ad Aiguesmortes, le cui fortificazioni
erano state eseguite da un genovese: Guglielmo Boc-
canegra. Delle opere di ripristino alla Porta Soprana
non tarda a diventare il direttore e l’arbitro assoluto.
Quando accettò di fare il progetto per il Borgo
Medioevale in Torino, le sue cognizioni in materia
erano dunque ben approfondite, grazie a un sagace
esercizio già fecondo di copiosi frutti.
I
lavori del Borgo, compresi gli studi prepara
tori, durarono circa due anni. 11 6 giugno 1883 si
procedeva alla posa della prima pietra (1). Il 27
aprile 1884 Villaggio e Rocca (eretti su un’area di
8550 metri quadrati, disposta a quadrilatero irre
golare, con uno dei lati più lunghi lambito dal Po)
venivano solennemente inaugurati con una sugge
stiva cerimonia, secondo l ’antico rito tradizionale,
presenti il Re Umberto l, la Regina Margherita, il
Principe di Napoli — attuale nostro Sovrano — ed
il Principe Amedeo d ’Aosta, insieme con gli altri
membri della Reale Famiglia (2).
Si legge nelle prima pagina del
Catalogo Ufficiale
deUa Sezione Storia dell’Arte: Guida illustrata al
Castello feudale del secolo X V ,
Torino, 1884, editore
Vincenzo Bona, volume di 170 pagine con numerosi
disegni, vera rarità bibliografica di cui non si trovano
più esemplari se non in qualche biblioteca: « Le
Loro Maeètà furono ricevute all’ingresso del Borgo
dalla Commissione della Sezione, la quale presentò
a S. M. il Re la chiave della porta recante la leggenda:
Ego januam, tu corda
(Io apro la porta, tu i cuori).
Subito dopo, il Catalogo reca il processo verbale
«d’una visita fatta dal Duca Amedeo IX di Savoia
colla Duchessa Jolanda ad una delle sue terre il
15 di maggio 1469, del ricevimento e della presen
tazione delle chiavi », evento che in quel fiorito
aprile dell’84 si ripeteva «con uguale affetto e divo*
zione, ma sotto ben più fausti auspici ». Con ciò la


















