
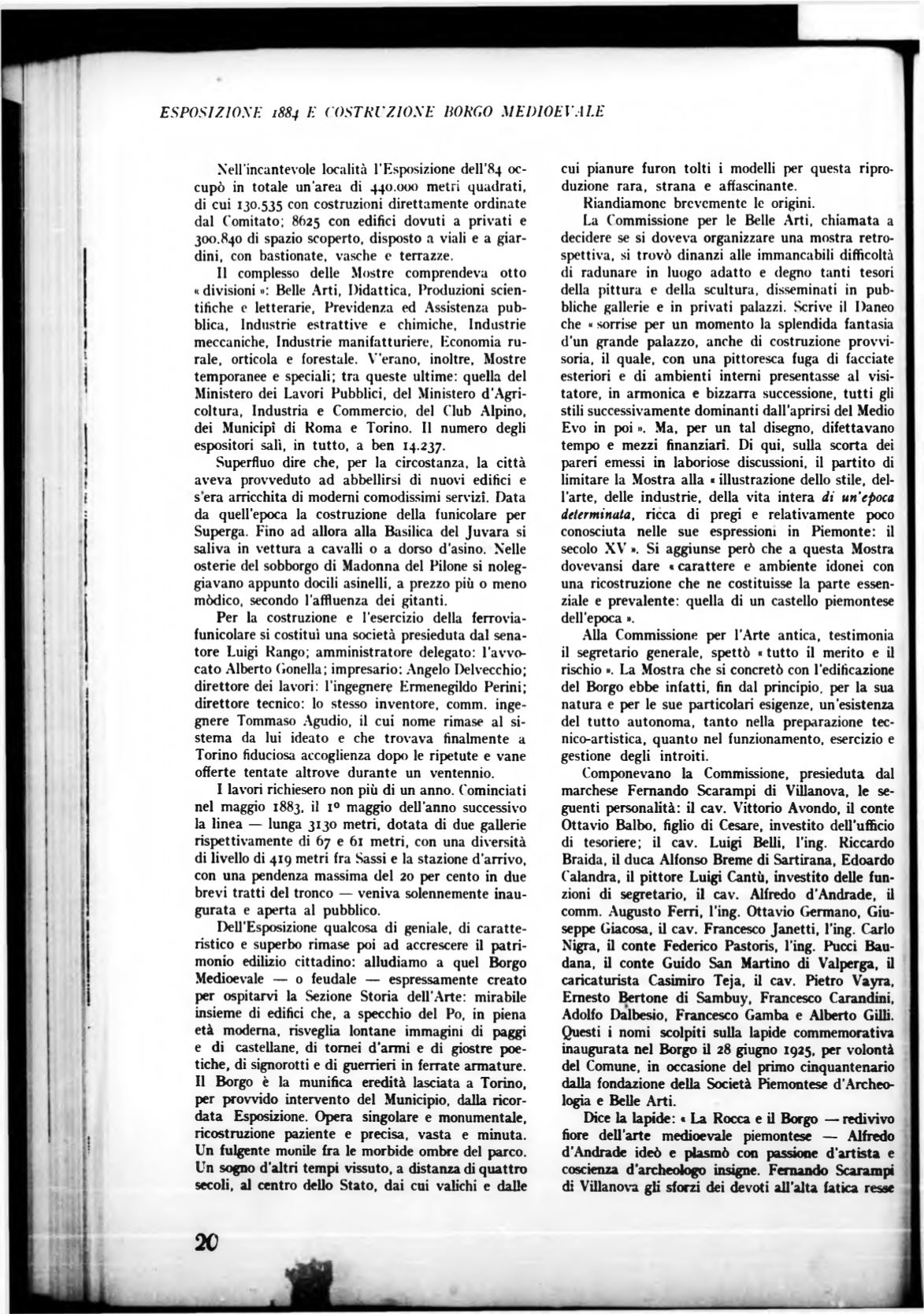
ESPOSIZIONE 1884 E
c o s t r i z i o n e
bo rgo
m e d i o e v a l e
Nell’incantevole località l ’Esposizione dell’84 oc
cupò in totale un'area di 440.000 metri quadrati,
di cui 130.535 con costruzioni direttamente ordinate
dal Comitato; 8625 con edifici dovuti a privati e
300.840 di spazio scoperto, disposto a viali e a giar
dini, con bastionate, vasche e terrazze.
Il complesso delle Mostre comprendeva otto
«divisioni »: Belle Arti, Didattica, Produzioni scien
tifiche e letterarie, Previdenza ed Assistenza pub
blica, Industrie estrattive e chimiche, Industrie
meccaniche, Industrie manifatturiere, Economia ru
rale, orticola e forestale. V ’erano, inoltre, Mostre
temporanee e speciali; tra queste ultime: quella del
Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero d ’Agri-
coltura, Industria e Commercio, del Club Alpino,
dei Municipi di Roma e Torino. Il numero degli
espositori salì, in tutto, a ben 14.237.
Superfluo dire che, per la circostanza, la città
aveva provveduto ad abbellirsi di nuovi edifici e
sera arricchita di moderni comodissimi servizi. Data
da quell’epoca la costruzione della funicolare per
Superga. Fino ad allora alla Basilica del Juvara si
saliva in vettura a cavalli o a dorso d’asino. Nelle
osterie del sobborgo di Madonna del Pilone si noleg
giavano appunto docili asinelli, a prezzo più o meno
mòdico, secondo l’affluenza dei gitanti.
Per la costruzione e l’esercizio della ferrovia-
funicolare si costituì una società presieduta dal sena
tore Luigi Rango; amministratore delegato: l ’avvo
cato Alberto Gonella; impresario: Angelo Deivecchio;
direttore dei lavori: l'ingegnere Ermenegildo Perini;
direttore tecnico: lo stesso inventore, comm. inge
gnere Tommaso Agudio, il cui nome rimase al si
stema da lui ideato e che trovava finalmente a
Torino fiduciosa accoglienza dopo le ripetute e vane
offerte tentate altrove durante un ventennio.
I
lavori richiesero non più di un anno. Cominciati
nel maggio 1883, il i ° maggio dell'anno successivo
la linea — lunga 3130 metri, dotata di due gallerie
rispettivamente di 67 e 61 metri, con una diversità
di livello di 419 metri fra Sassi e la stazione d’arrivo,
con una pendenza massima del 20 per cento in due
brevi tratti del tronco — veniva solennemente inau
gurata e aperta al pubblico.
Dell’Esposizione qualcosa di geniale, di caratte
ristico e superbo rimase poi ad accrescere il patri
monio edilizio cittadino: alludiamo a quel Borgo
Medioevale — 0 feudale — espressamente creato
per ospitarvi la Sezione Storia dell’Arte: mirabile
insieme di edifìci che, a specchio del Po, in piena
età moderna, risveglia lontane immagini di paggi
e di castellane, di tornei d'armi e di giostre poe
tiche, di signorotti e di guerrieri in ferrate armature.
Il Borgo è la munifica eredità lasciata a Torino,
per provvido intervento del Municipio, dalla ricor
data Esposizione. Opera singolare e monumentale,
ricostruzione paziente e precisa, vasta e minuta.
Un fulgente monile fra le morbide ombre del parco.
Un sogno d'altri tempi vissuto, a distanza di quattro
secoli, al centro dello Stato, dai cui valichi e dalle
cui pianure furon tolti i modelli per questa ripro
duzione rara, strana e affascinante.
Riandiamone brevemente le origini.
La Commissione per le Belle Arti, chiamata a
decidere se si doveva organizzare una mostra retro
spettiva, si trovò dinanzi alle immancabili difficoltà
di radunare in luogo adatto e degno tanti tesori
della pittura e della scultura, disseminati in pub
bliche gallerie e in privati palazzi. Scrive il Daneo
che
«
sorrise per un momento la splendida fantasia
d’un grande palazzo, anche di costruzione provvi
soria, il quale, con una pittoresca fuga di facciate
esteriori e di ambienti interni presentasse al visi
tatore, in armonica e bizzarra successione, tutti gli
stili successivamente dominanti dall'aprirsi del Medio
Evo in poi ». Ma, per un tal disegno, difettavano
tempo e mezzi finanziari. Di qui, sulla scorta dei
pareri emessi in laboriose discussioni, il partito di
limitare la Mostra alla «illustrazione dello stile, del
l’arte, delle industrie, della vita intera
di un’epoca
determinata,
ricca di pregi e relativamente poco
conosciuta nelle sue espressioni in Piemonte: il
secolo XV' ». Si aggiunse però che a questa Mostra
dovevansi dare «carattere e ambiente idonei con
una ricostruzione che ne costituisse la parte essen
ziale e prevalente: quella di un castello piemontese
dell’epoca ».
Alla Commissione per l’Arte antica, testimonia
il segretario generale, spettò «tutto il merito e il
rischio ». La Mostra che si concretò con l'edificazione
del Borgo ebbe infatti, fin dal principio, per la sua
natura e per le sue particolari esigenze, un’esistenza
del tutto autonoma, tanto nella preparazione tec
nico-artistica, quanto nel funzionamento, esercizio e
gestione degli introiti.
Componevano la Commissione, presieduta dal
marchese Fernando Scarampi di Villanova, le se
guenti personalità: il cav. Vittorio Avondo, il conte
Ottavio Balbo, figlio di Cesare, investito delTufficio
di tesoriere; il cav. Luigi Belli, l’ing. Riccardo
Braida, il duca Alfonso Breme di Sartirana, Edoardo
Calandra, il pittore Luigi Cantù, investito delle fun
zioni di segretario, il cav. Alfredo d'Andrade, il
comm. Augusto Ferri, l'ing. Ottavio Germano, Giu
seppe Giacosa, il cav. Francesco Janetti, l'ing. Carlo
Nigra, il conte Federico Pastoris, l'ing. Pucci Bau-
dana, il conte Guido San Martino di Valperga, il
caricaturista Casimiro Teja, il cav. Pietro Vayra,
Ernesto Bertone di Sambuy, Francesco Carandini,
Adolfo Dalbesio, Francesco Gamba e Alberto Gilli.
Questi i nomi scolpiti sulla lapide commemorativa
inaugurata nel Borgo il 28 giugno 1925, per volontà
del Comune, in occasione del primo cinquantenario
dalla fondazione della Società Piemontese d’Archeo-
logia e Belle Arti.
Dice la lapide: « La Rocca e il Borgo — redivivo
fiore dell’arte medioevale piemontese — Alfredo
d'Andrade ideò e plasmò con passione d’artista e
coscienza d’archeologo insigne. Fernando Scarampi
di Villanova gli sforzi dei devoti all’alta fatica resse
20


















