
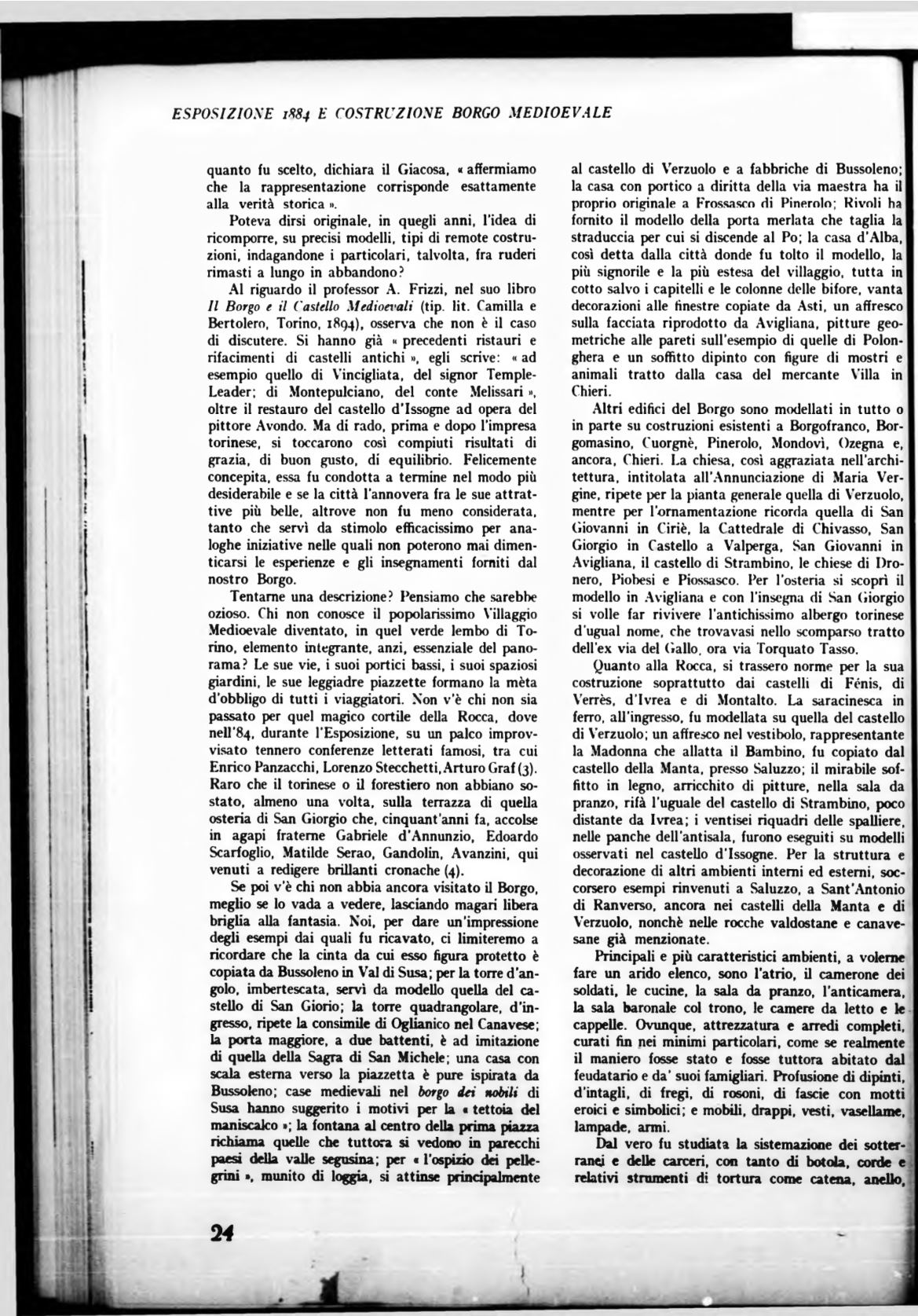
ESPOSIZIONE 1X84 E COSTRUZIONE BORGO MEDIOEVALE
quanto fu scelto, dichiara il Giacosa, « affermiamo
che la rappresentazione corrisponde esattamente
alla verità storica ».
Poteva dirsi originale, in quegli anni, l’idea di
ricomporre, su precisi modelli, tipi di remote costru
zioni, indagandone i particolari, talvolta, fra ruderi
rimasti a lungo in abbandono?
Al riguardo il professor A. Frizzi, nel suo libro
Il Borgo e il Castello Medioevali
(tip. lit. Camilla e
Bertolero, Torino, 1894), osserva che non è il caso
di discutere. Si hanno già « precedenti ristauri e
rifacimenti di castelli antichi »>, egli scrive: « ad
esempio quello di Yincigliata, del signor Tempie-
Leader; di Montepulciano, del conte Melissari »,
oltre il restauro del castello d’ Issogne ad opera del
pittore Avondo. Ma di rado, prima e dopo l’impresa
torinese, si toccarono così compiuti risultati di
grazia, di buon gusto, di equilibrio. Felicemente
concepita, essa fu condotta a termine nel modo più
desiderabile e se la città l’annovera fra le sue attrat
tive più belle, altrove non fu meno considerata,
tanto che servì da stimolo efficacissimo per ana
loghe iniziative nelle quali non poterono mai dimen
ticarsi le esperienze e gli insegnamenti forniti dal
nostro Borgo.
Tentarne una descrizione? Pensiamo che sarebbe
ozioso. Chi non conosce il popolarissimo Villaggio
Medioevale diventato, in quel verde lembo di To
rino, elemento integrante, anzi, essenziale del pano
rama? Le sue vie, i suoi portici bassi, i suoi spaziosi
giardini, le sue leggiadre piazzette formano la mèta
d’obbligo di tutti i viaggiatori. Non v ’è chi non sia
passato per quel magico cortile della Rocca, dove
nell’84, durante l’Esposizione, su un palco improv
visato tennero conferenze letterati famosi, tra cui
Enrico Panzacchi, Lorenzo Stecchetti, Arturo Graf (3).
Raro che il torinese o il forestiero non abbiano so
stato, almeno una volta, sulla terrazza di quella
osteria di San Giorgio che, cinquant’anni fa, accolse
in agapi fraterne Gabriele d'Annunzio, Edoardo
Scarfoglio, Matilde Serao, Gandolin, Avanzini, qui
venuti a redigere brillanti cronache (4).
Se poi v ’è chi non abbia ancora visitato il Borgo,
meglio se lo vada a vedere, lasciando magari libera
briglia alla fantasia. Noi, per dare un’impressione
degli esempi dai quali fu ricavato, ci limiteremo a
ricordare che la cinta da cui esso figura protetto è
copiata da Bussoleno in Val di Susa; per la torre d’an
golo, imbertescata, servì da modello quella del ca
stello di San Giorio; la torre quadrangolare, d ’in
gresso, ripete la consimile di Oglianico nel Canavese;
la porta maggiore, a due battenti, è ad imitazione
di quella della Sagra di San Michele; una casa con
scala esterna verso la piazzetta è pure ispirata da
Bussoleno; case medievali nel
borgo dei nobili
di
Susa hanno suggerito i motivi per la
•
tettoia del
maniscalco »; la fontana al centro della prima piazza
richiama quelle che tuttora si vedono in parecchi
paesi della valle segusina; per « l ’ospizio dei pelle
grini », munito di loggia, si attinse principalmente
al castello di Verzuolo e a fabbriche di Bussoleno;
la casa con portico a diritta della via maestra ha il
proprio originale a Frossasco di Pinerolo; Rivoli ha
fornito il modello della porta merlata che taglia la
straduccia per cui si discende al Po; la casa d’Alba,
così detta dalla città donde fu tolto il modello, la
più signorile e la più estesa del villaggio, tutta in
cotto salvo i capitelli e le colonne delle bifore, vanta
decorazioni alle finestre copiate da Asti, un affresco
sulla facciata riprodotto da Avigliana, pitture geo
metriche alle pareti sull’esempio di quelle di Polon-
ghera e un soffitto dipinto con figure di mostri e
animali tratto dalla casa del mercante Villa in
Chieri.
Altri edifici del Borgo sono modellati in tutto 0
in parte su costruzioni esistenti a Borgofranco, Bor-
gomasino, Cuorgnè, Pinerolo, Mondovì, Ozegna e,
ancora, Chieri. La chiesa, così aggraziata nell’archi
tettura, intitolata all’Annunciazione di Maria Ver
gine, ripete per la pianta generale quella di Verzuolo,
mentre per l’ornamentazione ricorda quella di San
Giovanni in Ciriè, la Cattedrale di Chivasso, San
Giorgio in Castello a Valperga, San Giovanni in
Avigliana, il castello di Strambino, le chiese di Dro-
nero, Piobesi e Piossasco. Per l ’osteria si scoprì il
modello in Avigliana e con l’insegna di San Giorgio
si volle far rivivere l’antichissimo albergo torinese
d'ugual nome, che trovavasi nello scomparso tratto
dell'ex via del Gallo, ora via Torquato Tasso.
Quanto alla Rocca, si trassero norme per la sua
costruzione soprattutto dai castelli di Fénis, di
Verrès, d ’Ivrea e di Montalto. La saracinesca in
ferro, all’ingresso, fu modellata su quella del castello
di Verzuolo; un affresco nel vestibolo, rappresentante
la Madonna che allatta il Bambino, fu copiato dal
castello della Manta, presso Saluzzo; il mirabile sof
fitto in legno, arricchito di pitture, nella sala da
pranzo, rifà l'uguale del castello di Strambino, poco
distante da Ivrea; i ventisei riquadri delle spalliere,
nelle panche dell’antisala, furono eseguiti su modelli
osservati nel castello d’Issogne. Per la struttura e
decorazione di altri ambienti interni ed esterni, soc
corsero esempi rinvenuti a Saluzzo, a Sant’Antonio
di Ranverso, ancora nei castelli della Manta e di
Verzuolo, nonché nelle rocche valdostane e canave-
sane già menzionate.
Principali e più caratteristici ambienti, a volerne
fare un arido elenco, sono l’atrio, il camerone dei
soldati, le cucine, la sala da pranzo, l’anticamera,
la sala baronale col trono, le camere da letto e le
cappelle. Ovunque, attrezzatura e arredi completi,
curati fin nei minimi particolari, come se realmente
il maniero fosse stato e fosse tuttora abitato dal
feudatario e da’ suoi famigliai! Profusione di dipinti,
d ’intagli, di fregi, di rosoni, di fascie con motti
eroici e simbolici; e mobili, drappi, vesti, vasellame,
lampade, armi.
Dal vero fu studiata la sistemazione dei sotter
ranei e delle carceri, con tanto di botola, corde e
relativi strumenti di tortura come catena, anello.
2
4


















