
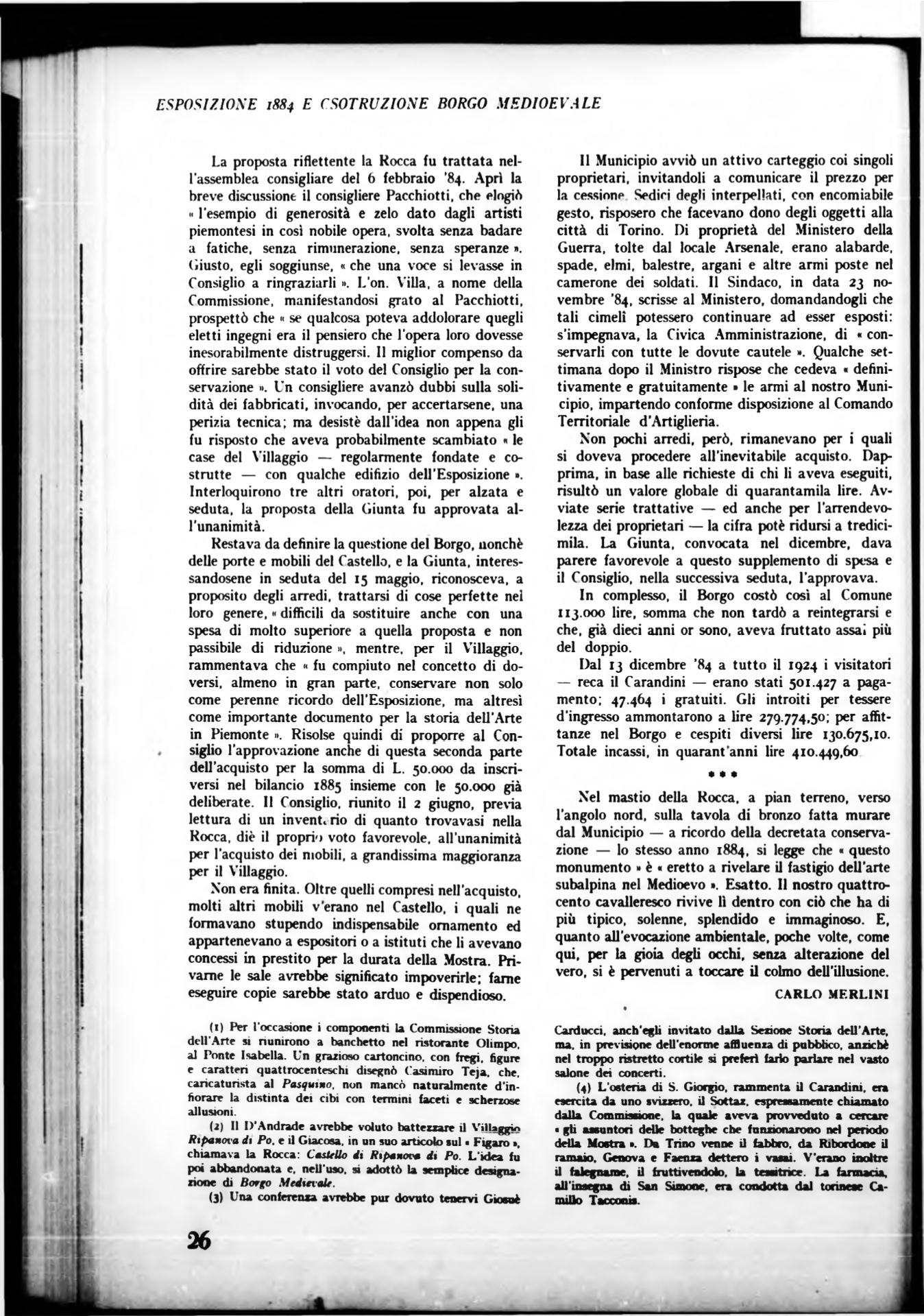
ESPOSIZIONE 1884 E CSOTRUZIONE BORGO MEDIOEVALE
La proposta riflettente la Rocca fu trattata nel
l’assemblea consigliare del 6 febbraio '84. Aprì la
breve discussione il consigliere Pacchiotti, che elogiò
•«l’esempio di generosità e zelo dato dagli artisti
piemontesi in così nobile opera, svolta senza badare
a fatiche, senza rimunerazione, senza speranze ».
(ìiusto, egli soggiunse, « che una voce si levasse in
Consiglio a ringraziarli ». L ’on. Villa, a nome della
Commissione, manifestandosi grato al Pacchiotti,
prospettò che « se qualcosa poteva addolorare quegli
eletti ingegni era il pensiero che l'opera loro dovesse
inesorabilmente distruggersi. Il miglior compenso da
offrire sarebbe stato il voto del Consiglio per la con
servazione ». Un consigliere avanzò dubbi sulla soli
dità dei fabbricati, invocando, per accertarsene, una
perizia tecnica; ma desistè dall’idea non appena gli
fu risposto che aveva probabilmente scambiato « le
case del Villaggio — regolarmente fondate e co
strutte — con qualche edifizio dell'Esposizione ».
Interloquirono tre altri oratori, poi, per alzata e
seduta, la proposta della Giunta fu approvata al
l’unanimità.
Restava da definire la questione del Borgo, uonchè
delle porte e mobili del Castello, e la Giunta, interes
sandosene in seduta del 15 maggio, riconosceva, a
proposito degli arredi, trattarsi di cose perfette nei
loro genere, «diffìcili da sostituire anche con una
spesa di molto superiore a quella proposta e non
passibile di riduzione », mentre, per il Villaggio,
rammentava che « fu compiuto nel concetto di do
versi, almeno in gran parte, conservare non solo
come perenne ricordo dell’Esposizione, ma altresì
come importante documento per la storia deU’Arte
in Piemonte ». Risolse quindi di proporre al Con
siglio l’approvazione anche di questa seconda parte
dell’acquisto per la somma di L. 50.000 da inscri
versi nel bilancio 1885 insieme con le 50.000 già
deliberate. Il Consiglio, riunito il 2 giugno, previa
lettura di un inventcrio di quanto trovavasi nella
Rocca, diè il propri») voto favorevole, all’unanimità
per l’acquisto dei mobili, a grandissima maggioranza
per il Villaggio.
Non era finita. Oltre quelli compresi nell’acquisto,
molti altri mobili v erano nel Castello, i quali ne
formavano stupendo indispensabile ornamento ed
appartenevano a espositori o a istituti che li avevano
concessi in prestito per la durata della Mostra. Pri
varne le sale avrebbe significato impoverirle; farne
eseguire copie sarebbe stato arduo e dispendioso.
(
1
) Per l’occasione i componenti la Commissione Storia
deU'Arte si riunirono a banchetto nel ristorante Olimpo,
al Ponte Isabella. Un grazioso cartoncino, con fregi, figure
e caratteri quattrocenteschi disegnò Casimiro Teja, che.
caricaturista al
Pasquino,
non mancò naturalmente d'in
fiorare la distinta dei cibi con termini faceti e scherzose
allusioni.
(i) Il D’Andrade avrebbe voluto battezzare il Villaggio
Ripanova di Po.
e il Giacosa, in un suo articolo sul *Figaro »,
chiamava la Rocca:
Cestello di Ripanova di Po.
L’idea fu
poi abbandonata e, nell’uso, si adottò la semplice designa
zione di
Borgo Medievale.
(
3
) Una conferenza avrebbe pur dovuto tenervi Giosuè
Il Municipio avviò un attivo carteggio coi singoli
proprietari, invitandoli a comunicare il prezzo per
la cessione Sedici degli interpellati, con encomiabile
gesto, risposero che facevano dono degli oggetti alla
città di Torino. Di proprietà del Ministero della
Guerra, tolte dal locale Arsenale, erano alabarde,
spade, elmi, balestre, argani e altre armi poste nel
camerone dei soldati. Il Sindaco, in data 23 no
vembre '84, scrisse al Ministero, domandandogli che
tali cimeli potessero continuare ad esser esposti:
s’impegnava, la Civica Amministrazione, di « con
servarli con tutte le dovute cautele ». Qualche set
timana dopo il Ministro rispose che cedeva « defini
tivamente e gratuitamente » le armi al nostro Muni
cipio, impartendo conforme disposizione al Comando
Territoriale d’Artiglieria.
Non pochi arredi, però, rimanevano per i quali
si doveva procedere all’inevitabile acquisto. Dap
prima, in base alle richieste di chi li aveva eseguiti,
risultò un valore globale di quarantamila lire. Av
viate serie trattative — ed anche per l’arrendevo
lezza dei proprietari — la cifra potè ridursi a tredici
mila. La Giunta, convocata nel dicembre, dava
parere favorevole a questo supplemento di spesa e
il Consiglio, nella successiva seduta, l’approvava.
In complesso, il Borgo costò così al Comune
113.000 lire, somma che non tardò a reintegrarsi e
che, già dieci anni or sono, aveva fruttato assai più
del doppio.
Dal 13 dicembre '84 a tutto il 1924 i visitatori
— reca il Carandini — erano stati 501.427 a paga
mento; 47.464 i gratuiti. Gli introiti per tessere
d’ingresso ammontarono a lire 279.774,50; per affit
tanze nel Borgo e cespiti diversi lire 130.675,10.
Totale incassi, in quarantanni lire 410.449,60
• * *
Nel mastio della Rocca, a pian terreno, verso
l’angolo nord, sulla tavola di bronzo fatta murare
dal Municipio — a ricordo della decretata conserva
zione — lo stesso anno 1884, si legge che « questo
monumento » è « eretto a rivelare il fastigio dell’arte
subalpina nel Medioevo ». Esatto. Il nostro quattro-
cento cavalleresco rivive lì dentro con ciò che ha di
più tipico, solenne, splendido e immaginoso. E,
quanto all’evocazione ambientale, poche volte, come
qui, per la gioia degli occhi, senza alterazione del
vero, si è pervenuti a toccare il colmo deU’illusione.
CARLO MERL1NI
♦
Carducci, anch'egli invitato dalla Sezione Storia deU'Arte,
ma, in previsione deU'enonne affluenza di pubblico, anziché
nel troppo ristretto cortile si preferì farlo parlare nel vasto
salone dei concerti.
(
4
)
L'osteria di S. Giorgio, rammenta il Carandini, era
esercita da uno svizzero, il Sottaz, espressamente chiamato
dalla Commissione, la quale aveva provveduto a cercare
«gli assuntori delle botteghe che funzionarono nel periodo
della Mostra ». Da Trino venne il fabbro, da Ribordone il
ramaio. Genova e Faenza dettero i vasai. V'erano inoltre
il falegname, il fruttivendolo, la tessitrice. La farmacia,
all’insegna di San Simone, era condotta dal torinese Ca
millo Tacconis.
26


















