
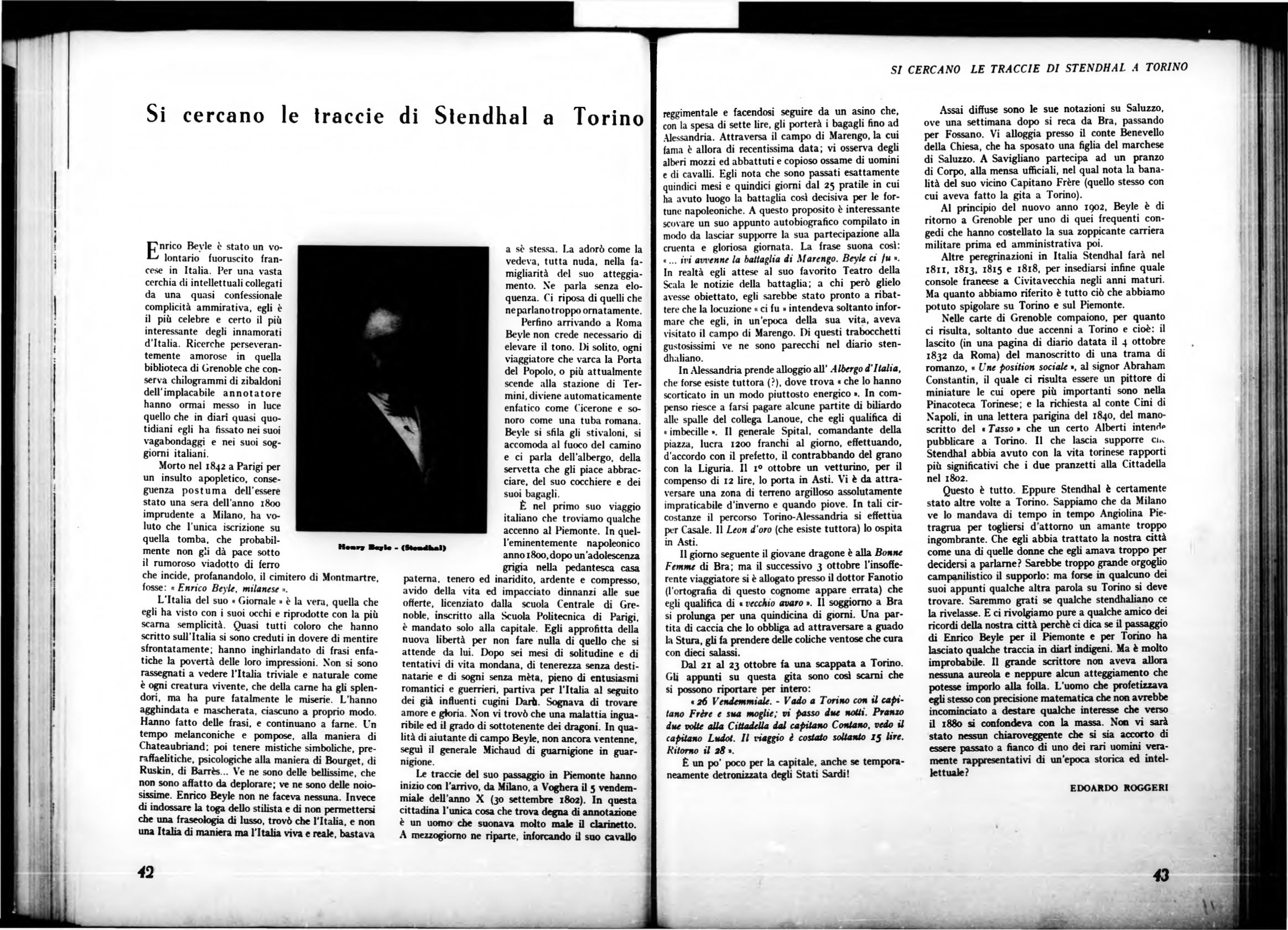
S I CERCANO L E TRACCI E DI STENDHAL A TORINO
E
nrico Beyle è stato un vo
lontario fuoruscito fran
cese in Italia. Per una vasta
cerchia di intellettuali collegati
da una quasi confessionale
complicità ammirativa, egli è
il più celebre e certo il più
interessante degli innamorati
d'Italia. Ricerche perseveran
temente amorose in quella
biblioteca di Grenoble che con
serva chilogrammi di zibaldoni
dell'implacabile annotatore
hanno ormai messo in luce
quello che in diari quasi quo
tidiani egli ha fissato nei suoi
vagabondaggi e nei suoi sog
giorni italiani.
Morto nel 1842 a Parigi per
un insulto apopletico, conse
guenza postuma dell’essere
stato una sera dell'anno 1800
imprudente a Milano, ha vo
luto che l’unica iscrizione su
quella tomba, che probabil
mente non gli dà pace sotto
il rumoroso viadotto di ferro
che incide, profanandolo, il cimitero di Montmartre,
fosse: «
Enrico Beyle, milanese
».
L ’Italia del suo «Giornale » è la vera, quella che
egli ha visto con i suoi occhi e riprodotte con la più
scarna semplicità. Quasi tutti coloro che hanno
scritto sull’Italia si sono creduti in dovere di mentire
sfrontatamente; hanno inghirlandato di frasi enfa
tiche la povertà delle loro impressioni. Non si sono
rassegnati a vedere l ’Italia triviale e naturale come
è ogni creatura vivente, che della carne ha gli splen
dori, ma ha pure fatalmente le miserie. L ’hanno
agghindata e mascherata, ciascuno a proprio modo.
Hanno fatto delle frasi, e continuano a fame. Un
tempo melanconiche e pompose, alla maniera di
Chateaubriand: poi tenere mistiche simboliche, pre-
raffaelitiche, psicologiche alla maniera di Bourget, di
Ruskin, di Barrès... Ve ne sono delle bellissime, che
non sono affatto da deplorare; ve ne sono delle noio
sissime. Enrico Beyle non ne faceva nessuna. Invece
di indossare la toga dello stilista e di non permettersi
che una fraseologia di lusso, trovò che l'Italia, e non
una Italia di maniera ma l'Italia viva e reale, bastava
a sè stessa. La adorò come la
vedeva, tutta nuda, nella fa
migliarità del suo atteggia
mento. Ne parla senza elo
quenza. Ci riposa di quelli che
neparlano troppo ornatamente.
Perfino arrivando a Roma
Beyle non crede necessario di
elevare il tono. Di solito, ogni
viaggiatore che varca la Porta
del Popolo, o più attualmente
scende alla stazione di Ter
mini, diviene automaticamente
enfatico come Cicerone e so
noro come una tuba romana.
Beyle si sfila gli stivaloni, si
accomoda al fuoco del camino
e ci parla dell’albergo, della
servetta che gli piace abbrac
ciare, del suo cocchiere e dei
suoi bagagli.
È nel primo suo viaggio
italiano che troviamo qualche
accenno al Piemonte. In quel-
l’eminentemente napoleonico
anno 1800,dopo un’adolescenza
grigia nella pedantesca casa
patema, tenero ed inaridito, ardente e compresso,
avido della vita ed impacciato dinnanzi alle sue
offerte, licenziato dalla scuola Centrale di Gre
noble, inscritto alla Scuola Politecnica di Parigi,
è mandato solo alla capitale. Egli approfitta della
nuova libertà per non fare nulla di quello che si
attende da lui. Dopo sei mesi di solitudine e di
tentativi di vita mondana, di tenerezza senza desti
natarie e di sogni senza mèta, pieno di entusiasmi
romantici e guerrieri, partiva per l’Italia al seguito
dei già influenti cugini Darà. Sognava di trovare
amore e gloria. Non vi trovò che una malattia ingua
ribile ed il grado di sottotenente dei dragoni. In qua
lità di aiutante di campo Beyle, non ancora ventenne,
seguì il generale Michaud di guarnigione in guar
nigione.
Le traccie del suo passaggio in Piemonte hanno
inizio con l’arrivo, da Milano, a Voghera il 5 vendem
miale dell’anno X (30 settembre 1802). In questa
cittadina l ’unica cosa che trova degna di annotazione
è un uomo che suonava molto male il clarinetto.
A mezzogiorno ne riparte, inforcando il suo cavallo
reggimentale e facendosi seguire da un asino che,
con la spesa di sette lire, gli porterà i bagagli fino ad
Alessandria. Attraversa il campo di Marengo, la cui
fama è allora di recentissima data; vi osserva degli
alberi mozzi ed abbattuti e copioso ossame di uomini
e di cavalli. Egli nota che sono passati esattamente
quindici mesi e quindici giorni dal 25 pratile in cui
ha avuto luogo la battaglia così decisiva per le for
tune napoleoniche. A questo proposito è interessante
scovare un suo appunto autobiografico compilato in
modo da lasciar supporre la sua partecipazione alla
cruenta e gloriosa giornata. La frase suona così:
«...
ivi avvenne la battaglia di Marengo. Beyle ci fu
».
In realtà egli attese al suo favorito Teatro della
Scala le notizie della battaglia; a chi però glielo
avesse obiettato, egli sarebbe stato pronto a ribat
tere che la locuzione «ci fu »intendeva soltanto infor
mare che egli, in un’epoca della sua vita, aveva
visitato il campo di Marengo. Di questi trabocchetti
gustosissimi ve ne sono parecchi nel diario sten-
dhaliano.
In Alessandria prende alloggio all’
Albergo d’Italia,
che forse esiste tuttora (?), dove trova «che lo hanno
scorticato in un modo piuttosto energico ». In com
penso riesce a farsi pagare alcune partite di biliardo
alle spalle del collega Lanoue, che egli qualifica di
* imbecille ». Il generale Spital, comandante della
piazza, lucra 1200 franchi al giorno, effettuando,
d’accordo con il prefetto, il contrabbando del grano
con la Liguria. Il i° ottobre un vetturino, per il
compenso di 12 lire, lo porta in Asti. Vi è da attra
versare una zona di terreno argilloso assolutamente
impraticabile d’inverno e quando piove. In tali cir
costanze il percorso Torino-Alessandria si effettua
per Casale. Il
Leon d'oro
(che esiste tuttora) lo ospita
in Asti.
Il
giorno seguente il giovane dragone è alla
Bonne
Femme
di Bra; ma il successivo 3 ottobre l’insoffe
rente viaggiatore si è allogato presso il dottor Fanotio
(l’ortografia di questo cognome appare errata) che
egli qualifica di «
vecchio avaro
». Il soggiorno a Bra
si prolunga per una quindicina di giorni. Una par
tita di caccia che lo obbliga ad attraversare a guado
la Stura, gli fa prendere delle coliche ventose che cura
con dieci salassi.
Dal 2 1 al 23 ottobre fa una scappata a Torino.
Gli appunti su questa gita sono così scarni che
si possono riportare per intero:
«
26 Vendemmiale.
-
Vado a Torino con il capi
tano Frère e sua moglie; vi passo due notti. Pranzo
due volte alla Cittadella dal capitano Contano, vedo il
capitano Ludot. Il viaggio
è
costato soltanto
1 5
lire.
Ritorno il 28
».
È un po’ poco per la capitale, anche se tempora
neamente detronizzata degù Stati Sardi!
Assai diffuse sono le sue notazioni su Saluzzo,
ove una settimana dopo si reca da Bra, passando
per Fossano. Vi alloggia presso il conte Benevello
della Chiesa, che ha sposato una figlia del marchese
di Saluzzo. A Savigliano partecipa ad un pranzo
di Corpo, alla mensa ufficiali, nel qual nota la bana
lità del suo vicino Capitano Frère (quello stesso con
cui aveva fatto la gita a Torino).
Al principio del nuovo anno 1902, Beyle è di
ritorno a Grenoble per uno di quei frequenti con
gedi che hanno costellato la sua zoppicante carriera
militare prima ed amministrativa poi.
Altre peregrinazioni in Italia Stendhal farà nel
18 1 1 , 1813, 1815 e 1818, per insediarsi infine quale
console francese a Civitavecchia negli anni maturi.
Ma quanto abbiamo riferito è tutto ciò che abbiamo
potuto spigolare su Torino e sul Piemonte.
Nelle carte di Grenoble compaiono, per quanto
ci risulta, soltanto due accenni a Torino e cioè: il
lascito (in una pagina di diario datata il 4 ottobre
1832 da Roma) del manoscritto di una trama di
romanzo, «
Une position sociale
», al signor Abraham
Constantin, il quale ci risulta essere un pittore di
miniature le cui opere più importanti sono nella
Pinacoteca Torinese; e la richiesta al conte Cini di
Napoli, in una lettera parigina del 1840, del mano
scritto del «
Tasso
» che un certo Alberti intenHp
pubblicare a Torino. Il che lascia supporre ci^
Stendhal abbia avuto con la vita torinese rapporti
più significativi che i due pranzetti alla Cittadella
nel 1802.
Questo è tutto. Eppure Stendhal è certamente
stato altre volte a Torino. Sappiamo che da Milano
ve lo mandava di tempo in tempo Angiolina Pie-
tragrua per togliersi dattorno un amante troppo
ingombrante. Che egli abbia trattato la nostra città
come una di quelle donne che egli amava troppo per
decidersi a parlarne? Sarebbe troppo grande orgoglio
campanilistico il supporlo: ma forse in qualcuno dei
suoi appunti qualche altra parola su Torino si deve
trovare. Saremmo grati se qualche stendhaliano ce
la rivelasse. E ci rivolgiamo pure a qualche amico dei
ricordi della nostra città perchè ci dica se il passaggio
di Enrico Beyle per il Piemonte e per Torino ha
lasciato qualche traccia in diari indigeni. Ma è molto
improbabile. Il grande scrittore non aveva allora
nessuna aureola e neppure alcun atteggiamento che
potesse imporlo alla folla. L ’uomo che profetizzava
egli stesso con precisione matematica che non avrebbe
incominciato a destare qualche interesse che verso
il
1880
si confondeva con la massa. Non vi sarà
stato nessun chiaroveggente che si sia accorto di
essere passato a fianco di uno dei rari uomini vera
mente rappresentativi di un’epoca storica ed intel
lettuale?
EDOARDO ROGGERI
Si cercano le Iraccie di Slendhal a Torino
H # » r i I t f k - ( S t r a m b a i )
42
43


















