
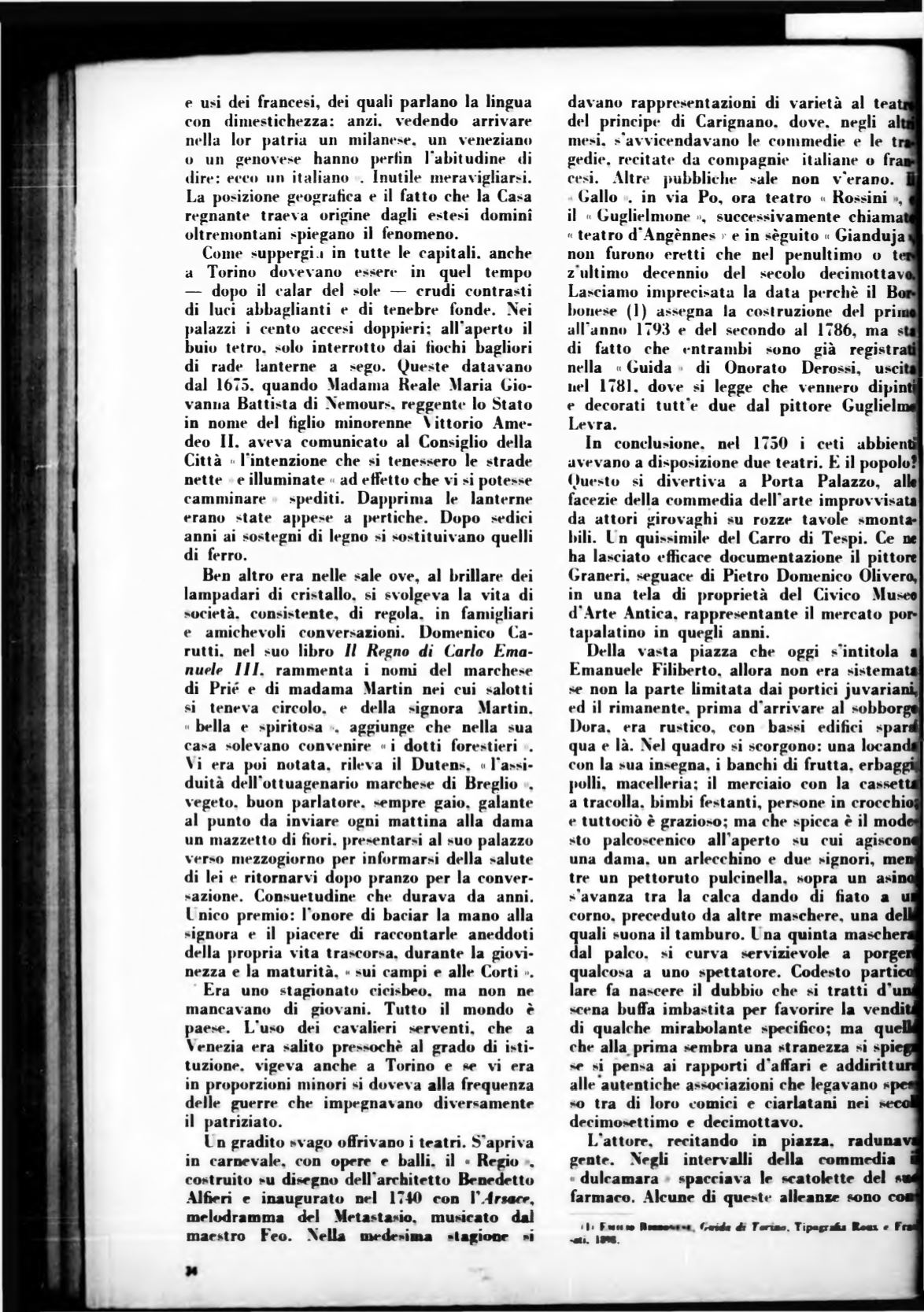
e usi dei francesi, dei quali parlano la lingua
con dimestichezza: anzi, vedendo arrivare
nella lor patria un milanese, un veneziano
o un genovese hanno perfin l'abitudine di
dire: ecco un italiano . Inutile meravigliarsi.
La posizione geografica e il fatto che la Casa
regnante traeva origine dagli estesi domini
oltremontani spiegano il fenomeno.
Come suppergiù in tutte le capitali, anche
a Torino dovevano essere in quel tempo
— dopo il calar del sole — crudi contrasti
di luci abbaglianti e di tenebre fonde. Nei
palazzi i cento accesi doppieri: all'aperto il
buio tetro, solo interrotto dai fiochi bagliori
di rade lanterne a sego. Queste datavano
dal 1675. quando Madama Reale Maria Gio
vanna Battista di Nemours, reggente lo Stato
in nome del figlio minorenne \ ittorio Ame
deo I I . aveva comunicato al Consiglio della
Città » l'intenzione che si tenessero le strade
nette e illuminate « ad effetto che vi si potesse
camminare spediti. Dapprima le lanterne
erano state appese a pertiche. Dopo sedici
anni ai sostegni di legno si sostituivano quelli
di ferro.
Ben altro era nelle sale ove, al brillare dei
lampadari di cristallo, si svolgeva la vita di
società, consistente, di regola, in famigliari
e amichevoli conversazioni. Domenico Ca-
rutti. nel suo libro
11 Regno d i Carlo Ema
nuele I I I .
rammenta i nomi del marchese
di Prie e di madama Martin nei cui salotti
si teneva circolo, e della signora Martin.
« bella e spiritosa •, aggiunge che nella sua
casa solevano convenire « i dotti forestieri .
\ i era poi notata, rileva il Dutens. « l'assi
duita dell'ottuagenario marchese di Breglio .
vegeto, buon parlatore, sempre gaio, galante
al punto da inviare ogni mattina alla dama
un mazzetto di fiori, presentarsi al suo palazzo
verso mezzogiorno per informarsi della salute
di lei e ritornarvi dopo pranzo per la conver
sazione. Consuetudine che durava da anni.
L nico premio: l'onore di baciar la mano alla
signora e il piacere di raccontarle aneddoti
della propria vita trascorsa, durante la giovi
nezza e la maturità. « sui campi e alle Corti ».
Era uno stagionato cicisbeo, ma non ne
mancavano di giovani. Tutto il mondo è
paese. L'uso dei cavalieri serventi, che a
Venezia era salito pressoché al grado di isti
tuzione. vigeva anche a Torino e se vi era
in proporzioni minori si doveva alla frequenza
delle guerre che impegnavano diversamente
il patriziato.
L n gradito svago offrivano i teatri. S'apriva
in carnevale, con opere e balli, il « Regio .
costruito su disegno dell'arehitetto Benedetto
Alfieri e inaugurato nel 1740 con
VArsace,
melodramma del Metastasio. musicato dal
maestro Feo. Nella medesima -tagiooe si
davano rappresentazioni di varietà al teat
del principi* di Carignano. dove, negli al
mesi, s'avvicendavano le commedie e le t
gedie. recitate da compagnie italiane o fra
cesi. Altre pubbliche sale non v'erano.
Gallo . in via Po, ora teatro <>Rossini »,
il « Guglielmone », successivamente chiama
« teatro d'Angènnes >e in sèguito « Gianduja
non furono eretti che nel penultimo o te
z ultimo decennio del secolo decimottav
Lasciamo imprecisata la data perchè il Bo
bonese (1) assegna la costruzione del pria
all'anno 1793 e del secondo al 1786, ma s
di fatto che entrambi sono già registra*
nella « Guida > di Onorato Derossi, usci
nel 1781. dove si legge che vennero dipint
e decorati tutt'e due dal pittore Guglielmi
Levra.
In conclusione, nel 1750 i ceti abbienti
avevano a disposizione due teatri. E il popolo?
Questo si divertiva a Porta Palazzo, alle
facezie della commedia dell'arte improvvisata
da attori girovaghi su rozze tavole smonta*
bili. I n quissimile del Carro di Tespi. Ce ne
ha lasciato efficace documentazione il pittore
Graneri. seguace di Pietro Domenico Olivero,
in una tela di proprietà del Civico Muse*
d'Arte Antica, rappresentante il mercato por»
tapalatino in quegli anni.
Della vasta piazza che oggi s'intitola a
Emanuele Filiberto, allora non era sistemata
se non la parte limitata dai portici juvariani,
ed il rimanente, prima d'arrivare al sobborg#
Dora, era rustico, con bassi edifici sparai
qua e là. Nel quadro si scorgono: una locanda]
con la sua insegna, i banchi di frutta. erbaggiJ
polli, macelleria; il mereiaio con la cassetta
a tracolla, bimbi festanti, persone in crocchio;
e tuttociò è grazioso; ma che spicca è il mode*
sto palcoscenico alPaperto su cui agiscono
una dama, un arlecchino e due signori, menj
tre un pettoruto pulcinella. sopra un asino!
s'avanza tra la calca dando di fiato a ua
corno, preceduto da altre maschere, una dell!
quali suona il tamburo. I na quinta maschera
dal palco, si curva servizievole a porgeri
qualcosa a uno spettatore. Codesto particol
lare fa nascere il dubbio che si tratti d 'u n i
scena buffa imbastita per favorire la vendili
di qualche mirabolante specifico; ma quelli
che alla prima sembra una stranezza si spiega
se si pensa ai rapporti d'affari e addirittura
alle autentiche associazioni che legavano speN
so tra di loro comici e ciarlatani nei seco!
decimosettimo e decimottavo.
L'attore, recitando in piazza, radunava
gente. Negli intervalli della commedia I
« dulcamara spacciava le scatolette del su i
farmaco. Alcune di queste alleanze sono coaj
ili F«nw .........
fnridm é t Ta rta n .
Tipografo Im i
r
Frati
-*i. im.


















