
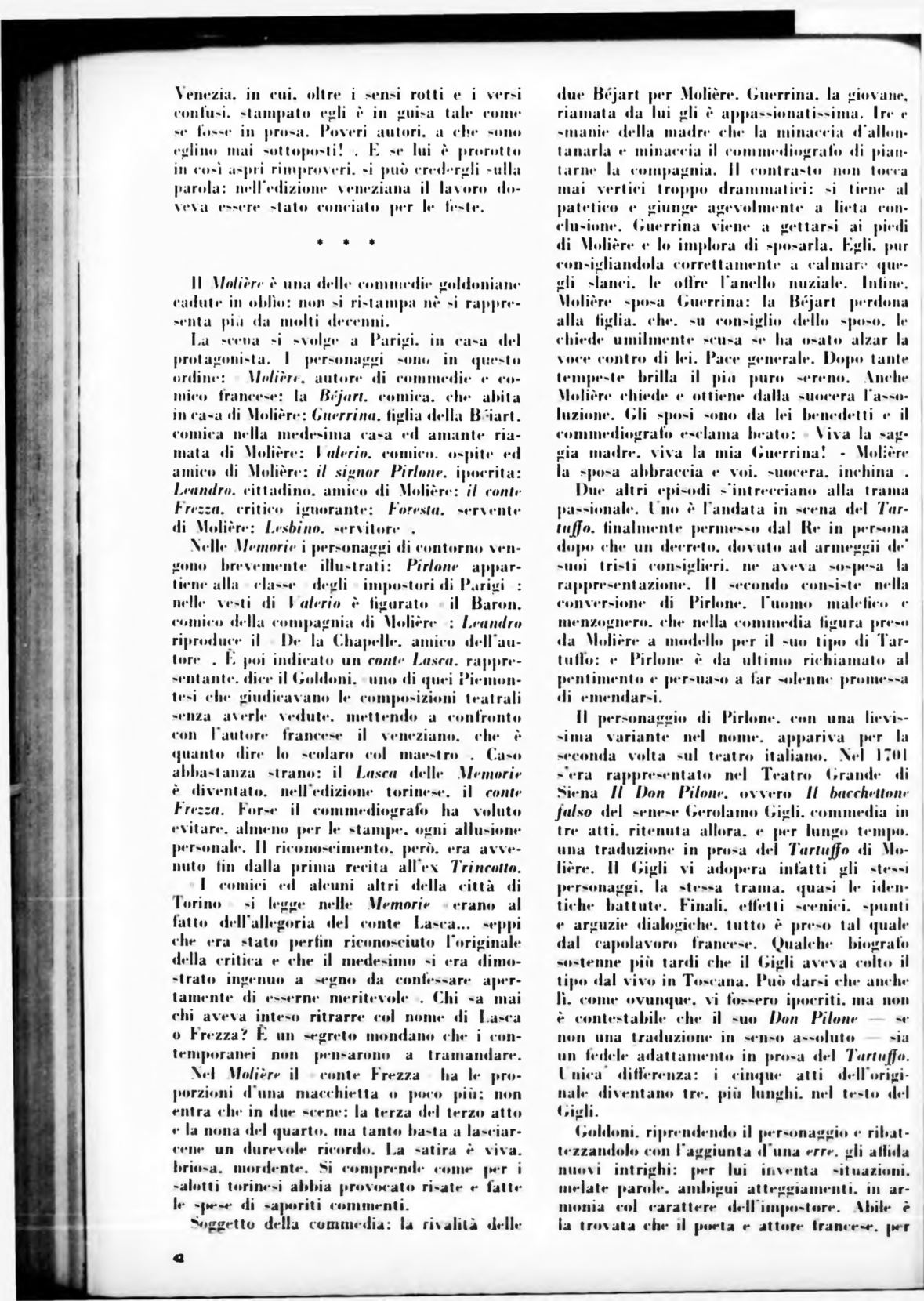
\enezia. in cui, oltre i sensi rotti e i ver>i
confusi. stampato egli è in guisa tale come
se fosse in prosa. Poveri autori, a che sono
eglino mai sottoposti! . K se lui è prorotto
in così aspri rimproveri. «i può credergli aitila
parola: ndl'edizione veneziana il lavoro do
veva essere «tato conciato per le feste.
* * *
Il
Molière
è una delle commedie goldoniane
cadute in oidio: non «i ristampa nè «i rappre
senta pia da molti decenni.
La scena si svolge a Paridi, in casa «lei
protagonista. I personali sono in quo to
ordine:
Molière.
autore di commedie e co
mico francese; la
Béjart.
comica, che abita
in ca«a di Molière:
Guerrina.
figlia della B'iart.
comica nella medesima ca«a ed amante ria
mata di Molière: 1
alerio.
comico, ospite ed
amico di Molière:
il signor Pirlone.
ipocrita:
Leandro,
cittadino, amico di Molière:
il conte
brezza,
critico ignorante:
Foresta,
servente
di Molière:
Lesbino.
servitore .
Nelle
Memorie
i personali di contorno ven
gono brevemente illustrati:
Pi rione
appar
tiene alla cla«se de«:li impostori di Paridi :
nelle \e*ti di I
alerio
è timorato il Baron.
comico della compagnia di Molière :
Leandro
riproduce il De la Chapclle. amico dcllaii-
tore . h poi indicato un
conte Lasca,
rappre
sentante. dice il Goldoni. uno di quei Piemon
tesi clic "indicavano le composizioni teatrali
senza averle vedute, mettendo a confronto
con 1autore francese il veneziano, che è
quanto dire lo scolaro col maestro . Caso
abbastanza «trailo: il
Lasca
delle
Memorie
è diventato, nell edizione torinese, il
conte
Frezza.
hor«c il commediografo ha voluto
evitare, almeno per le stampe, ogni allusione
personale. Il riconoscimento, però, era avve
nuto fin dalla prima recita allex
Trincotto.
I comici ed alcuni altri della città di
1orino sj legge nelle
Memorie
erano al
fatto dell'allegoria del conte Lasca... seppi
che era stato perfin riconosciuto l'originale
della critica e che il medesimo si era «limo-
strato ingenuo a segno da confessare aper
tamente di esserne meritevole . Chi sa mai
chi aveva inteso ritrarre col nome di Lasca
o Frezza? K un segreto mondano che i con
temporanei non pensarono a tramandare.
Nel
Molière
il conte Frezza ha le pro
porzioni d una macchietta o poco più: non
entra che in due scene: la terza del terzo atto
e la nona del quarto, ma tanto basta a lasciar
cene un durevole ricordo. La >atira è viva,
briosa, mordente. Si comprende come per i
-alotti torinesi abbia provocato ri«ate e latte
le «jh*s«* di saporiti commenti.
Soggetto della commedia: la rivalità delle
due Bcjart per Molière. Guerrina, la giovane,
riamata da lui gli è appassionatissima. Ire »•
«manie della madre che la minaccia d'allon-
tanarla e minaccia il commediografo di pian
tarne la compagnia, il contrasto non tocca
mai vertici troppo drammatici: si tiene al
patetico c giunge agevolmente a lieta con
clusione. Guerrina viene a gettarsi ai piedi
di Molière e lo implora di sposarla, hgli. pur
consigliandola correttamente a calmare que
gli slanci, le offre Fanello nuziale. Infine.
Molière sposa Guerrina: la Béjart perdona
alla figlia, che.
mi
consiglio dello sposo, le
chiede umilmente scusa se ha osato alzar la
voce contro di lei. Pace generale. Dopo tante
tempeste brilla il piti puro sereno. Anche
Molière chiede e ottiene dalla suocera l’asso
luzione. Gli sposi sono da lei benedetti e il
commediografo esclama beato: Viva la sag
gia madre, viva la mia Guerrina! - Molière
la sposa abbraccia c voi. suocera, inchina .
Dm* altri episodi s'intrecciano alla traina
passionale. 1 no è l audata in scena del
Tar
tu fo .
finalmente permesso dal Ite in persona
dopo che un decreto, dovuto ad armeggìi de*
«noi tristi consiglieri, ne aveva so-pe-a la
rappresentazione. Il «ccondo consiste nella
conversione di Pirlone. l'uomo malefico e
menzognero, che nella commedia figura pre»o
da Molière a modello per il suo tipo di Tar-
t il fio: e Pirlone è da ultimo richiamalo al
pentimento e persuaso a far solenne promessa
di emendarsi.
Il
personaggio di Pirlone. con una lievi
sima variante nel nome, appariva per la
seconda volta sul teatro italiano. Nel 1T0|
«era rappresentato nel Teatro Grande di
Siena
11 Don Pilone,
ovvero
II bacchettone
Jalso
del senese Gerolamo Gigli, commedia in
tre atti, ritenuta allora, e per lungo tempo,
una traduzione in prosa del
Tartujjo
di Mo
lière. Il Gigli vi adopera infatti gli ste«»i
personaggi, la *te**a trama, quasi le iden
tiche battute. Finali, effetti ^cenici, «punti
e arguzie dialogiche, tutto è preso tal quale
dal capolavoro francese. Oualche biografo
sostenne più tardi che il Gigli aveva colto il
tipo dal vivo in To«cana. Può darsi clic anche
lì. come ovunque, vi fossero ipocriti, ma non
è contestabile che il «un
Don Pilone
— st-
non una traduzione in senso assoluto
»ia
un fedele adattamento in prosa del
Tartujfo.
I nica differenza: i cinque atti dcllorigi-
nale diventano tre. più lunghi, nel testo del
Gigli.
Goldoni, riprendendo il personaggio e ribat
tezzandolo con l'aggiunta d una
e r r e ,
gli afhda
nuovi intrighi: per lui inventa situazioni,
melate parole, ambigui atteggiamenti, in ar
monia col carattere dt-H'impostore. \bile è
la trovata che il porta e attore traneese. jnr
42


















