
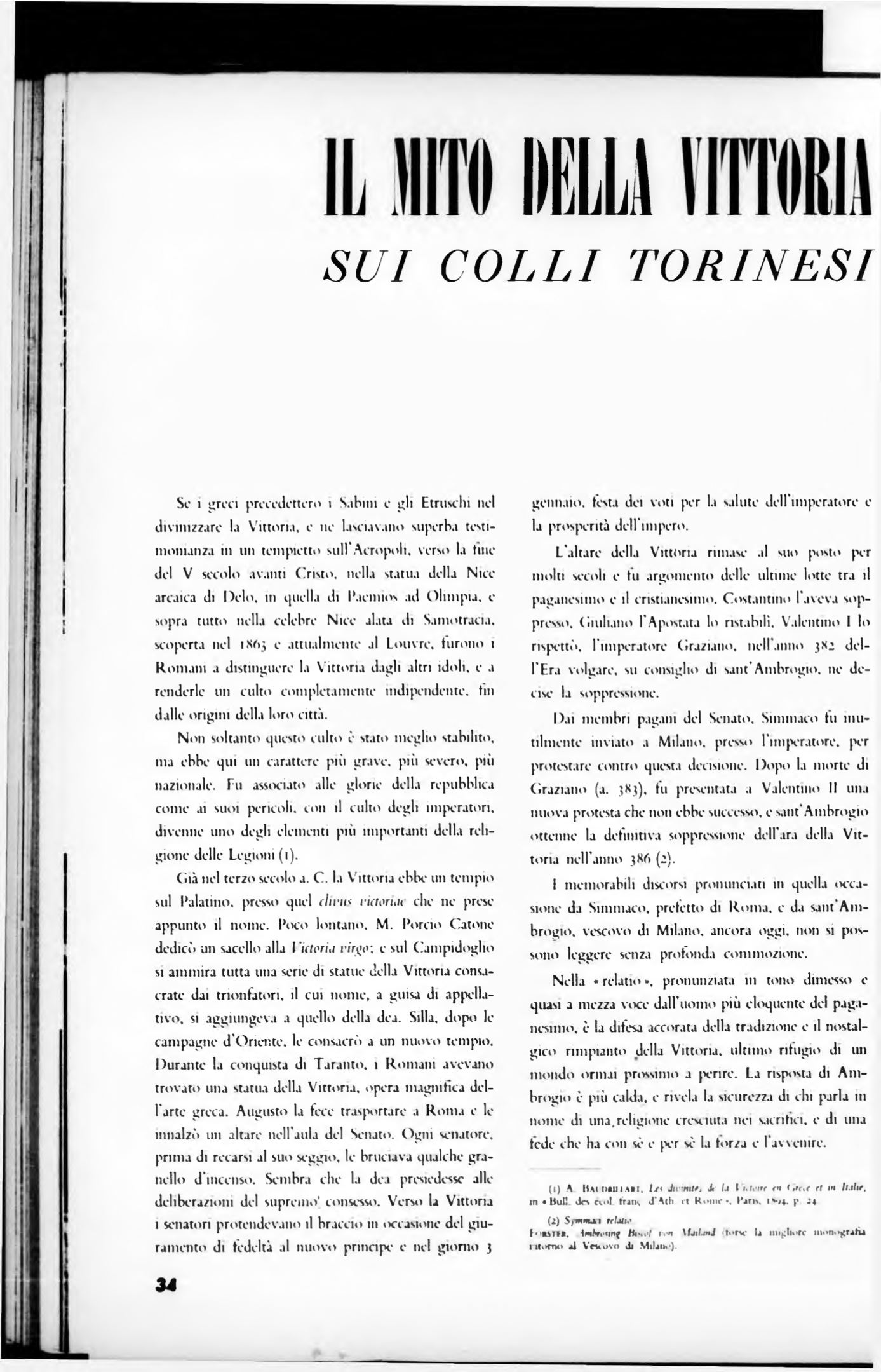
n u
SUI COLLI TORINESI
Se 1 greci precedettero 1 Sabini e gli Etruschi nel
divinizzare la Vittoria, e ne lasciavano superba testi
monianza 111 un tempietto sull’ Acropoli, verso la tuie
del V secolo avanti Cristo, nella statua della Nice
arcaica di Deio, in quella di Paemios ad Olimpia, e
sopra tutto nella celebre Nice alata di Samotracia,
scoperta nel 1S63 e attualmente al Louvre, turono 1
Romani a distinguere la Vittoria dagli altri idoli, e a
renderle ini culto completamente indipendente, tm
dalle origini della loro città.
Non soltanto questo culto è stato meglio stabilito,
ma ebbe qui un carattere piii grave, piìi severo, più
nazionale. Fu associato alle glorie della repubblica
come ai suoi pericoli, con il culto degli imperatori,
divenne uno degli elementi più importanti della reli
gione delle Legioni (1).
Già nel terz»' secolo a. C . la Vittoria ebbe 1111 tempio
sul Palatino, presso quel
d i vii < victorun
che ne prese
appunto il nome. Poco lontano, M. Porcio Catone
dedicò un sacello alla
l ’ictorù virgo;
e sul Campidoglio
si ammira tutta una serie di statue della Vittoria consa
crate dai trionfatori, il cui nome, a guisa di appella
tivo, si aggiungeva a quello della dea. Siila, dopo le
campagne d ’
Orier.te,le consacrò a 1111 nuovo tempio.
Durante la conquista di Taranto, 1 Romani avevano
trovato una statua della Vittoria, opera magnifica del
l’arte greca. Augusto la fece trasportare a Roma e le
innalzò 1111 altare nell’aula del Senato. Ogni senatore,
prima di recarsi al suo seggio, le bruciava qualche gra
nello d’ incenso. Sembra che la dea presiedesse alle
deliberazioni del supremo' consesso. Verso la Vittoria
1 senatori protendevano il braccio 111 occasione del giu
ramento di fedeltà al nuovo principe e nel giorno 3
gennaio, testa dei voti per la salute dell'imperatore e
la prosperità dell'impero.
L'altare della Vittoria rimase al suo posto per
molti secoli e tu argomento delle ultime lotte tra il
paganesimo e il cristianesimo. Costantini' l'aveva sop
pressi'. Giuliano l 'Apostata lo ristabilì. Valentino I lo
rispettò, l’imperatore Graziano, ncllanno 3S2 del-
l’ Era volgare, su consiglio di sant’ Ambrogio, ne de
cise la soppressione.
Dai membri pagani del Senato, Simmaco tu inu
tilmente inviato a Milano, presso l’imperatore, per
protestare contro questa decisione. Dopo la morte di
Graziano (a. 383), tu presentata a Valentino II una
nuova protesta che non ebbe successo, e sant Ambrogio
ottenne la definitiva soppressione dell’ara della Vit
toria nell’anno 386 (2).
I
memorabili discorsi pronunciati 111 quella ixrc
sione da Simmaco, prefetto di Rom a, e da sant Am
brogio, vescovo di Milano, ancora oggi, non si pos
sono leggere senza profonda commozione.
Nella « relatio », pronunziata 111 tono dimesso e
quasi a mezza voce dall’ uomo più eloquente del paga
nesimo, è la difesa accorata della tradizione e il nostal
gico rimpianto della Vittoria, ultimo ritugio di un
mondo ormai prossimo .1 perire. La risposta di Am
brogio è più calda, e rivela la sicurezza di clu parla 111
nome di una. religione cresi iuta nei sacrifici, e di una
tede che ha con sì- e per sì- la torza e I avvenire.
(1)
A B a i n u li A ir,
ljt< Jiriiu i/i de U
1
uVirr
en <.in e et
ih
It.ihin «Bui! d<*\ «.ol fruii, J'A th et Koinè •• H inv i VM. p -4
(j)
5
/mnui
relatu'
F<i«stu. fm/r.xin? Wis.’f ivn
\
fjil.mJ(forse li migliore monografia
ritorno
al
Vevovo
Ji Milano).
34


















