
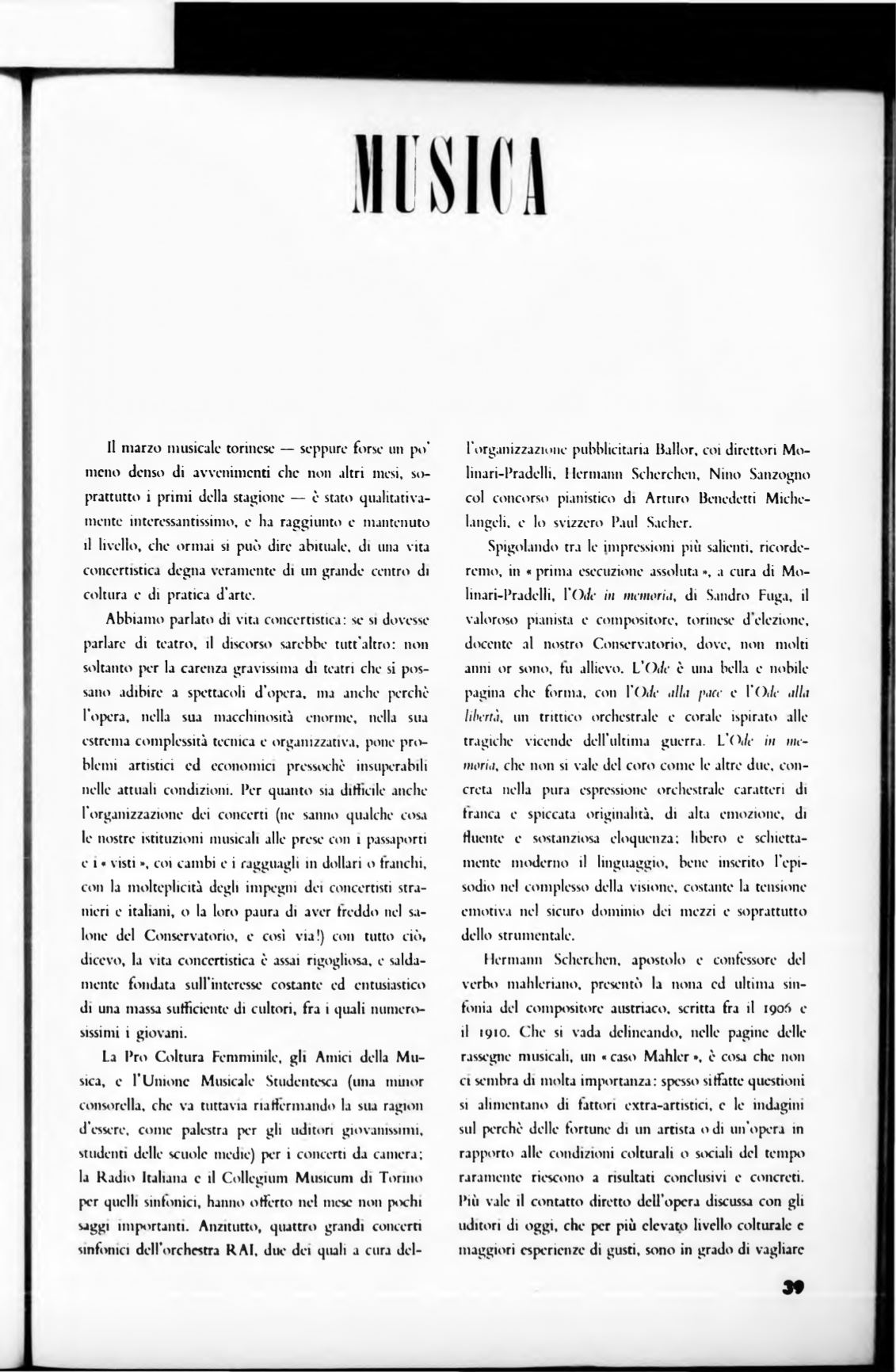
Il
marzo musicale torinese — seppure forse un po’
meno denso di avvenimenti che non altri mesi, so
prattutto i primi della stagione — è stato qualitativa
mente interessantissimo, e lia raggiunto e mantenuto
il livello, che ormai si può dire abituale, di una vita
concertistica degna veramente di 1111 grande centro di
coltura e di pratica d’arte.
Abbiamo parlati) di vita concertistica: se si dovesse
parlare di teatro, il discorso sarebbe tutt’altro: non
soltanto per la carenza gravissima di teatri che si pos
sano adibire a spettacoli d’opera, ma anche perchè
l’opera, nella sua macchinosità enorme, nella sua
estrema complessità tecnica e organizzativa, pone pro
blemi artistici ed economici pressoché insuperabili
nelle attuali condizioni. Per quanto sia difficile' anche
l’organizzazione dei concerti (ne sanno qualche cosa
le nostre istituzioni musicali alle prese con 1 passaporti
e 1 « visti », coi cambi e i ragguagli in dollari o franchi,
con la molteplicità degli impegni dei concertisti stra
nieri e italiani, o la loro paura di aver freddo nel sa
lone del Conservatorio, e così via!) con tutto ciò,
dicevo, la vita concertistica è assai rigogliosa, e salda
mente fondata sull’interesse costante ed entusiastico
di una massa sufficiente di cultori, fra i quali numero
sissimi i giovani.
La Pro Coltura Femminile, gli Amici della Mu
sica, e l’ Unione Musicale Studentesca (una minor
consorella, che va tuttavia riaffermando la sua ragion
d’essere, come palestra per gli uditori giovanissimi,
studenti delle scuole medie) per i concerti da camera;
la Radio Italiana e il Collegium Musicum di Torino
per quelli sinfonici, hanno offerto nel mese non pochi
saggi importanti. Anzitutto, quattro grandi concerti
sinfonici dell’orchestra RA I, due dei quali a cura del
l'organizzazione pubblicitaria Ballor, coi direttori Mo-
linari-Pradelli, Hermann Scherchen, Nino Sanzogno
col concorso pianistico di Arturo Benedetti Miche
langeli, e lo svizzero Paul Sacher.
Spigolando tra le impressioni più salienti, ricorde
remo, in « prima esecuzione assoluta », a cura di Mo-
linari-Pradclli,
\'Ode in memoria,
di Sandro Fuga, il
valoroso pianista e compositore, torinese d elezione,
docente al nostro Conservatorio, dove, non molti
anni or sono, tu allievo.
L'Ode
è una bella e nobile
pagina che forma, con
YOde alla pace
e l’ ()</e
alla
libertà,
un trittico orchestrale e corale ispirato alle
tragiche vicende dell’ ultima guerra. L
'Ode in me
moria,
che non si vale del coro come le altre due, con
creta nella pura espressione orchestrale caratteri di
franca e spiccata originalità, di alta emozione, di
fluente e sostanziosa eloquenza; libero e schietta
mente moderno il linguaggio, bene inserito l’epi
sodio nel complesso della visione, costante la tensione
emotiva nel sicuro dominio dei mezzi e soprattutto
dello strumentale.
Hermann Scherchen, apostolo e confessore del
verbo mahlcriano, presentò la nona ed ultima sin
tonia del compositore austriaco, scritta fra il 1906 e
il 1910. Che si vada delineando, nelle pagine delle
rassegne musicali, 1111 « caso Mahler », è cosa che non
ci sembra di molta importanza: spesso siffatte questioni
si alimentano di fattori extra-artistici, e le indagini
sul perchè delle fortune di un artista o di un’opera in
rapporto alle condizioni colturali o sociali del tempo
raramente riescono a risultati conclusivi e concreti.
Più vale il contatto diretto dell’opera discussa con gli
uditori di oggi, che per più elevato livello colturale e
maggiori esperienze di gusti, sono in grado di vagliare
39


















