
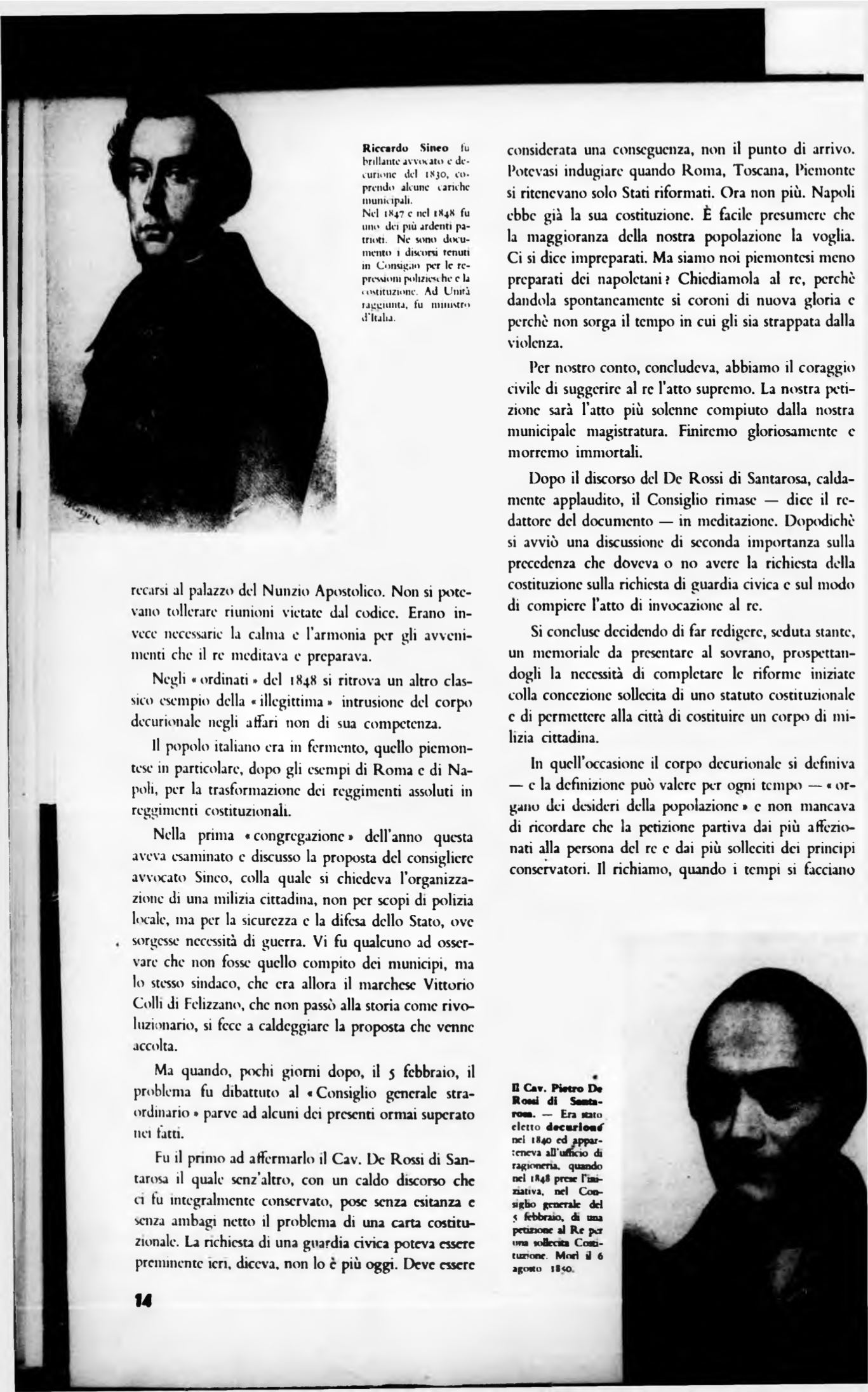
Riccardo Sinro fu
brillante avvocato c de
curione del 1830, co
prendo alcune cariche
municipali.
Nel 1X47 e ne! 1N4K fu
uni' dei più ardenti pa
trioti. Ne vmo docu
mento 1 discorsi tenuti
in Comigììo per le re
pressioni poliziesi he e la
1 ostiamone. Ad Uniti
uucmiitj, fu ministro
d'Italia.
recarsi al palazzo del Nunzio Apostolico. Non si pote
vano tollerare riunioni vietate dal codice. Erano in
vece necessarie la calma e l’armonia per gli avveni
menti che il re meditava e preparava.
Negli «ordinati » del 1848 si ritrova un altro clas
sico esempio della « illegittima » intrusione del corpo
decurionale negli affari non di sua competenza.
Il popolo italiano era in fermento, quello piemon
tese in particolare, dopo gli esempi di Roma e di Na
poli, per la trasformazione dei reggimenti assoluti in
reggimenti costituzionali.
Nella prima «congregazione » dell’anno questa
aveva esaminato e discusso la proposta del consigliere
avvocato Sinco, colla quale si chiedeva l’organizza
zione di una milizia cittadina, non per scopi di polizia
locale, ma per la sicurezza e la difesa dello Stato, ove
sorgesse necessità di guerra. Vi fu qualcuno ad osser
vare che non fosse quello compito dei municipi, ma
10 stesso sindaco, che era allora il marchese Vittorio
Colli di Felizzano, che non passò alla storia come rivo
luzionario, si fece a caldeggiare la proposta che venne
accolta.
Ma quando, pochi giorni dopo, il 5 febbraio, il
problema fu dibattuto al «Consiglio generale stra
ordinario * parve ad alcuni dei presenti ormai superato
nei fatti.
Fu il primo ad affermarlo il Cav. De Rossi di San-
tarosa il quale senz’altro, con un caldo discorso che
11 tu integralmente conservato, pose senza esitanza e
senza ambagi netto il problema di una carta costitu
zionale. La richiesta di una guardia civica poteva essere
preminente ieri, diceva, non lo e più oggi. Deve essere
14
considerata una conseguenza, non il punto di arrivo.
Potcvasi indugiare quando Roma, Toscana, Piemonte
si ritenevano solo Stati riformati. Ora non più. Napoli
ebbe già la sua costituzione. E facile presumere che
la maggioranza della nostra popolazione la voglia.
Ci si dice impreparati. Ma siamo noi piemontesi meno
preparati dei napoletani? Chiediamola al re, perchè
dandola spontaneamente si coroni di nuova gloria e
perchè non sorga il tempo in cui gli sia strappata dalla
violenza.
Per nostro conto, concludeva, abbiamo il coraggio
civile di suggerire al re l’atto supremo. La nostra peti
zione sarà l’atto più solenne compiuto dalla nostra
municipale magistratura. Finiremo gloriosamente e
morremo immortali.
Dopo il discorso del De Rossi di Santarosa, calda
mente applaudito, il Consiglio rimase — dice il re
dattore del documento — in meditazione. Dopodiché
si avviò una discussione di seconda importanza sulla
precedenza che doveva o no avere la richiesta della
costituzione sulla richiesta di guardia civica e sul modo
di compiere l’atto di invocazione al re.
Si concluse decidendo di far redigere, seduta stante,
un memoriale da presentare al sovrano, prospettan
dogli la necessità di completare le riforme iniziate
colla concezione sollecita di uno statuto costituzionale
e di permettere alla città di costituire un corpo di mi
lizia cittadina.
In qucll’occasionc il corpo decurionale si definiva
— e la definizione può valere per ogni tempo — «or
gano dei desideri della popolazione » e non mancava
di ricordare che la petizione partiva dai più affezio
nati alla persona del re e dai più solleciti dei principi
conservatori. Il richiamo, quando i tempi si facciano
D Cav. Pietro De
Rotti di Santa*
rom . —
Era stato
eletto d e c a rio a S
nel 1840 ed appar
teneva all'ufficio di
ragioneria, quando
nei 1X4S prese Pini
ziativa, nel Con
siglio generale del
5 febbraio, di una
petizione al Re per
una sollecita Co*i-
turooe. Mori il 6
agosto liso


















