
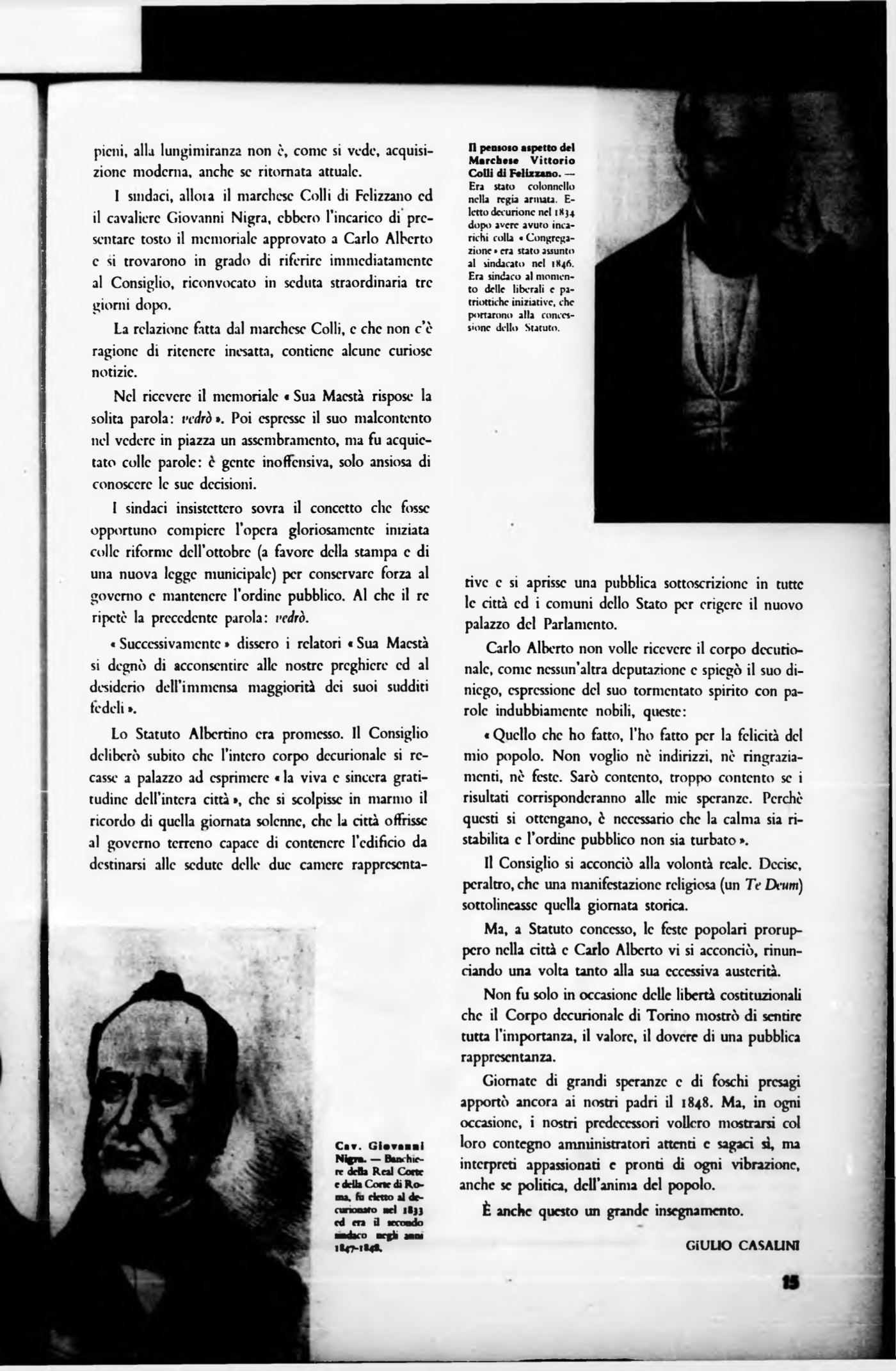
pieni, alla lungimiranza non è, come si vede, acquisi
zione moderna, anche se ritornata attuale.
I
snidaci, alloia il marchese Colli di Fclizzano ed
il cavaliere Giovanni Nigra, ebbero l’incarico di pre
sentare tosto il memoriale approvato a Carlo Alberto
e si trovarono in grado di riferire immediatamente
al Consiglio, riconvocato in seduta straordinaria tre
giorni dopo.
La relazione fitta dal marchese Colli, e che non c’è
ragione di ritenere inesatta, contiene alcune curiose
notizie.
Nel ricevere il memoriale « Sua Maestà rispose la
solita parola :
vedrò
». Poi espresse il suo malcontento
nel vedere in piazza un assembramento, ma fu acquie
tato colle parole: e gente inoffensiva, solo ansiosa di
conoscere le sue decisioni.
I
sindaci insistettero sovra il concetto clic fosse
opportuno compiere l’opera gloriosamente iniziata
colle riforme dell’ottobre (a favore della stampa e di
una nuova legge municipale) per conservare forza al
governo e mantenere l’ordine pubblico. Al che il re
ripetè la precedente parola:
vedrò.
*
Successivamente * dissero i relatori « Sua Maestà
si degnò di acconsentire alle nostre preghiere ed al
desiderio dell’immensa maggiorità dei suoi sudditi
fedeli ».
Lo Statuto Albertino era promesso. Il Consiglio
deliberò subito che l’intero corpo dccurionalc si re
casse a palazzo ad esprimere « la viva e sincera grati
tudine dell’intera città », che si scolpisse in marmo il
ricordo di quella giornata solenne, che la città offrisse
al governo terreno capace di contenere l’edificio da
destinarsi alle sedute delle due camere rapprcscnta-
C av . G io v a n n i
Nifrm. — Banchie
re della Reai Cotte
c della Corte di R o
ma. fu eletto al de-
ruriooaro nel i l ) ]
ed età il ternndo
(indaco negb anni
1I47-1M*.
Il pentolo aspetto del
Marchese V itto rio
C olli di Felizzano. —
Era stato colonnello
nella regia armata. E-
lctto decurione nel 1X34
dopo avere avuto inca
richi colla «Congrega
zione • era stato assunto
al sindacato nel 1X46.
Era sindaco al momen
to delle liberali e pa
triottiche iniziative, che
portarono alla conces
sione dello Statuto.
rive e si aprisse una pubblica sottoscrizione in tutte
le città ed i comuni dello Stato per erigere il nuovo
palazzo del Parlamento.
Carlo Alberto non volle ricevere il corpo dccurio
nalc, come ncssun’altra deputazione c spiegò il suo di
niego, espressione del suo tormentato spirito con pa
role indubbiamente nobili, queste:
«Quello che ho fatto, l’ho fatto per la felicità del
mio popolo. Non voglio nè indirizzi, nè ringrazia
menti, nè feste. Sarò contento, troppo contento se i
risultati corrisponderanno alle mie speranze. Perchè
questi si ottengano, è necessario che la calma sia ri
stabilita e l’ordine pubblico non sia turbato ».
Il Consiglio si acconciò alla volontà reale. Decise,
peraltro, che una manifestazione religiosa (un
Te Deum)
sottolineasse quella giornata storica.
Ma, a Statuto concesso, le feste popolari prorup
pero nella città e Carlo Alberto vi si acconciò, rinun
ciando una volta tanto alla sua eccessiva austerità.
Non fu solo in occasione delle libertà costituzionali
che il Corpo dccurionalc di Torino mostrò di sentire
tutta l’importanza, il valore, il dovere di una pubblica
rappresentanza.
Giornate di grandi speranze e di foschi presagi
apportò ancora ai nostri padri il 1848. Ma, in ogni
occasione, i nostri predecessori vollero mostrarsi col
loro contegno amministratori attenti e sagaci sì, ma
interpreti appassionati e pronti di ogni vibrazione,
anche se politica, dell’anima del popolo.
È anche questo un grande insegnamento.
g ìu l io
c a s a u n i


















