
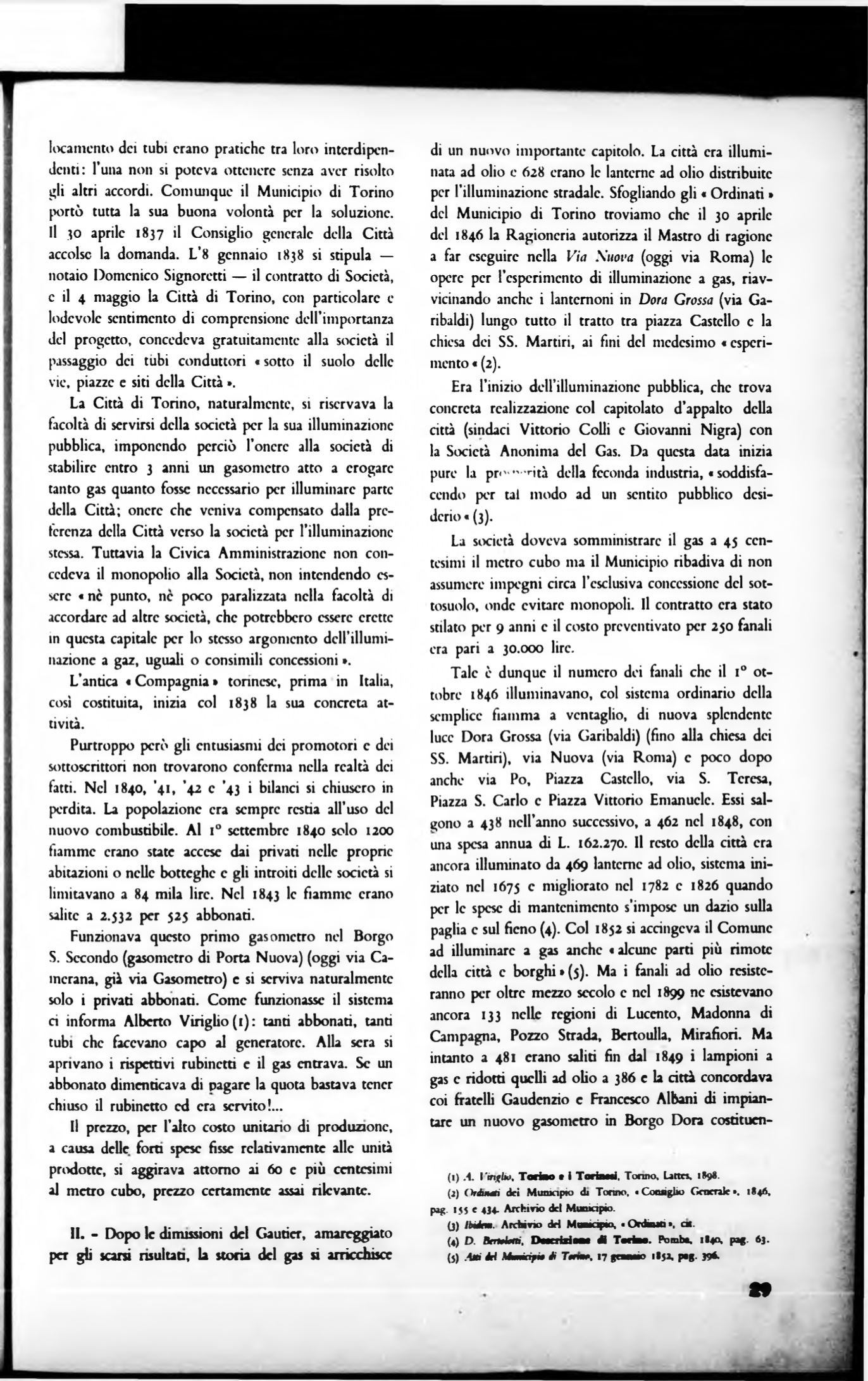
locamcnto dei tubi erano pratiche tra loro interdipen
denti: l'una non si poteva ottenere senza aver risolto
gli altri accordi. Comunque il Municipio di Torino
portò tutta la sua buona volontà per la soluzione.
Il 30 aprile 1837 il Consiglio generale della Città
accolse la domanda. L ’8 gennaio 1838 si stipula —
notaio Domenico Signorotti — il contratto di Società,
e il 4 maggio la Città di Torino, con particolare e
lodevole sentimento di comprensione dell’ importanza
del progetto, concedeva gratuitamente alla società il
passaggio dei tubi conduttori « sotto il suolo delle
vie, piazze e siti della Città ».
La Città di Torino, naturalmente, si riservava la
facoltà di servirsi della società per la sua illuminazione
pubblica, imponendo perciò l’onere alla società di
stabilire entro 3 anni un gasomctro atto a erogare
tanto gas quanto fosse necessario per illuminare parte
della Città; onere che veniva compensato dalla pre
ferenza della Città verso la società per l’illuminazione
stessa. Tuttavia la Civica Amministrazione non con
cedeva il monopolio alla Società, non intendendo es
sere « ne punto, ne poco paralizzata nella facoltà di
accordare ad altre società, che potrebbero essere erette
in questa capitale per lo stesso argomento dcH’illumi-
nazione a gaz, uguali o consimili concessioni ».
L’antica « Compagnia * torinese, prima in Italia,
così costituita, inizia col 1838 la sua concreta at
tività.
Purtroppo però gli entusiasmi dei promotori e dei
sottoscrittori non trovarono conferma nella realtà dei
fatti. Nel 1840, '41, ’42 e '43 i bilanci si chiusero in
perdita. La popolazione era sempre restia all’ uso del
nuovo combustibile. Al i° settembre 1840 solo 1200
fiamme erano state accese dai privati nelle proprie
abluzioni o nelle botteghe e gli introiti delle società si
limitavano a 84 mila lire. Nel 1843 le fiamme erano
salite a 2.532 per 525 abbonati.
Funzionava questo primo gasomctro nel Borgo
S. Secondo (gasometro di Porta Nuova) (oggi via Ca-
inerana, già via Gasometro) e si serviva naturalmente
solo i privati abbonati. Come funzionasse il sistema
ci informa Alberto V irigho(i): tanti abbonati, tanti
tubi che facevano capo al generatore. Alla sera si
aprivano i rispettivi rubinetti e il gas entrava. Se un
abbonato dimenticava di pagare la quota bastava tener
chiuso il rubinetto ed era servito!...
li prezzo, per l’alto costo unitario di produzione,
a causa delle forti spese fisse relativamente alle unità
prodotte, si aggirava attorno ai 60 e più centesimi
al metro cubo, prezzo certamente assai rilevante.
II.
- Dopo le dimissioni del Gauticr, amareggiato
per gli scarsi risultati, la storia del gas si arricchisce
di un nuovo importante capitolo. La città era illumi
nata ad olio e 628 erano le lanterne ad olio distribuite
per l’illuminazione stradale. Sfogliando gli « Ordinati »
del Municipio di Torino troviamo che il 30 aprile
del 1846 la Ragioneria autorizza il Mastro di ragione
a far eseguire nella
Via Nuova
(oggi via Roma) le
opere per l’esperimento di illuminazione a gas, riav
vicinando anche i lanternoni in
Dora
Grossa (via Ga
ribaldi) lungo tutto il tratto tra piazza Castello c la
chiesa dei SS. Martiri, ai fini del medesimo « esperi
mento « (2).
Era l’inizio dd l’illuminazione pubblica, che trova
concreta realizzazione col capitolato d’appalto della
città (sindaci Vittorio Colli e Giovanni Nigra) con
la Società Anonima del Gas. Da questa data inizia
pure la pro^-rità della feconda industria, «soddisfa
cendo per tal modo ad un sentito pubblico desi
derio « (3).
La società doveva somministrare il gas a 45 cen
tesimi il metro cubo ma il Municipio ribadiva di non
assumere impegni circa l’esclusiva concessione del sot
tosuolo, onde evitare monopoli. Il contratto era stato
stilato per 9 anni e il costo preventivato per 250 fanali
era pari a 30.000 lire.
Tale è dunque il numero dei fanali che il i° ot
tobre 1846 illuminavano, col sistema ordinario della
semplice fiamma a ventaglio, di nuova splendente
luce Dora Grossa (via Garibaldi) (fino alla chiesa dei
SS. Martiri), via Nuova (via Roma) e poco dopo
anche via Po, Piazza Castello, via S. Teresa,
Piazza S. Carlo e Piazza Vittorio Emanuele. Essi sal
gono a 438 nell’anno successivo, a 462 nel 1848, con
una spesa annua di L. 162.270. Il resto della città era
ancora illuminato da 469 lanterne ad olio, sistema ini
ziato nel 1675 e migliorato nel 1782 e 1826 quando
per le spese di mantenimento s’impose un dazio sulla
paglia e sul fieno (4). Col 1852 si accingeva il Comune
ad illuminare a gas anche «alcune parti più rimotc
della città e borghi *(5). Ma i fanali ad olio resiste
ranno per oltre mezzo secolo e nel 1899 ne esistevano
ancora 133 nelle regioni di Luccnto, Madonna di
Campagna, Pozzo Strada, Bertoulla, Mirafiori. Ma
intanto a 481 erano saliti fin dal 1849 i lampioni a
gas e ridotti quelli ad olio a 386 e la città concordava
coi fratelli Gaudenzio e Francesco Albani di impian
tare un nuovo gasomctro in Borgo Dora costituen-
(1)
A .
I
'ingHo.
Torino
•
i Torinesi,
Tonno, Lattei, 1898.
(
2
)
OrJuu/i
dei Municipio di Torino,
•
Conàglio Generale
».
1846,
pag. 155 e 434. Archivio del Municipio.
(
3
) IbUm . Archivio tiri Municipio, «Ordinati». c«.
(4)
D.
Bertolotti. P u e r i l i » di
Torino.
Pomba.
1840,
pag.
63
.
(}) .Atti 4rl Municipio ii Torme,
17
gennaio
1852,
pag. J9*.
tf


















