
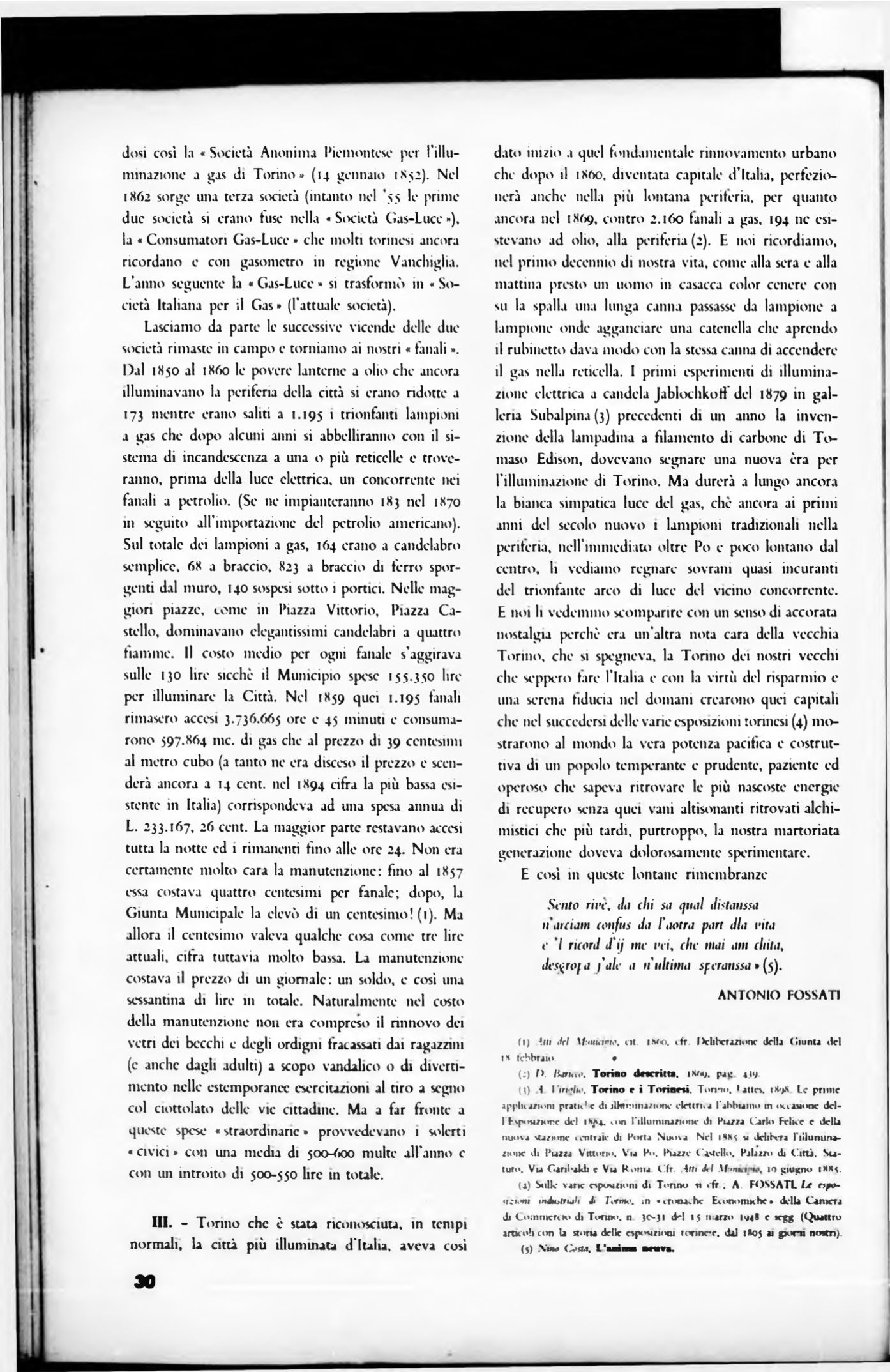
dosi così la « Società Anonima Piemontese per l’illu
minazione a gas di Torino* (14 gennaio 1S52). Nel
1862 sorge una terza società (intanto nel 55 le prime
due società si erano fuse nella * Società Gas-Luce »),
la « Consumatori Gas-Luce » che molti torinesi ancora
ricordano e con gasometro in regione Vanchiglia.
L’anno seguente la
•
Gas-Luce » si trasformò in « So
cietà Italiana per il Gas » (l’attuale società).
Lasciamo da parte le successive vicende delle due
società rimaste in campo e torniamo ai nostri « fanali ».
Dal 1850 al 1860 le povere lanterne a olio che ancora
illuminavano la periferia della città si erano ridotte a
173 mentre erano saliti a 1.195 > trionfanti lampioni
a gas che dopo alcuni anni si abbelliranno con il si
stema di incandescenza a una o più reticelle e trove
ranno, prima della luce elettrica, un concorrente nei
fanali a petrolio. (Se ne impianteranno 183 nel 1870
111 seguito aU’importazionc del petrolio americano).
Sul totale dei lampioni a gas, 164 erano a candelabro
semplice, 68 a braccio, 823 a braccio di ferro spor
genti dal muro, 140 sospesi sotto i portici. Nelle mag
giori piazze, come in Piazza Vittorio, Piazza Ca
stello, dominavano elegantissimi candelabri a quattro
fiamme. Il costo medio per ogni fanale s’aggirava
sulle 130 lire sicché il Municipio spese 155.350 lire
per illuminare la Città. Nel 1859 quei 1.195 fanali
rimasero accesi 3.736.665 ore e 45 minuti e consuma
rono 597*864 me. di gas che al prezzo di 39 centesimi
al metro cubo (a tanto ne era disceso il prezzo e scen
derà ancora a 14 cent, nel 1894 cifra la più bassa esi
stente in Italia) corrispondeva ad una spesa annua di
L. 233.167, 26 cent. La maggior parte restavano accesi
tutta la notte ed 1 rimanenti fino alle ore 24. Non era
certamente molto cara la manutenzione: fino al 1857
essa costava quattro centesimi per fanale; dopi, la
Giunta Municipale la elevò di un centesimo! (1). Ma
allora il centesimo valeva qualche cosa come tre lire
attuali, atra tuttavia molto bassa. La manutenzione
costava il prezzo di un giornale: un soldo, c così una
sessantina di lire 111 totale. Naturalmente nel costo
della manutenzione 11011 era compreso il rinnovo dei
vetri dei becchi e degli ordigni fracassati dai ragazzini
(e anche dagli adulti) a scopo vandalico o di diverti
mento nelle estemporanee esercitazioni al nro a segno
col ciottolato delle vie cittadine. Ma a far fronte a
queste spese «straordinarie » provvedevano 1 solerti
«civici » con una media di 500-600 multe all’anno e
con un introito di 500-550 lire 111 toulc.
III.
- Torino che è stata riconosciuta, in tempi
normali, la città più illuminata d'Italia, aveva così
dato inizio a quel fondamentale rinnovamento urbano
che dopo il 1N60, diventata capitale d’ Italia, perfezio-
nerà anche nella piti lontana periferia, per quanto
ancora nel 1869, contro 2.160 fanali a gas, 194 ne esi
stevano ad olio, alla periferia (2). E noi ricordiamo,
nel primo decennio di nostra vita, come alla sera e alla
mattina presto un uomo in casacca color cenere con
su la spalla una lunga canna passasse da lampione a
lampione onde agganciare una catenella che aprendo
il rubinetto dava modo con la stessa canna di accendere
il gas nella reticella. I primi esperimenti di illumina
zione elettrica a candela Jablochkotf del 1879 in gal
leria Subalpina (3) precedenti di 1111 anno la inven
zione della lampadina a filamento di carbone di To
maso Edison, dovevano segnare una nuova èra per
l'illuminazione di Torino. Ma durerà a lungo ancora
la bianca simpatica luce del gas, che ancora ai primi
anni del secolo nuovo 1 lampioni tradizionali nella
periferia, nell’immediato oltre Po e piKo lontano dal
centro, li vediamo regnare sovrani quasi incuranti
del trionfante arco di luce del vicino concorrente.
E noi li vedemmo scomparire con un senso di accorata
nostalgia perchè era un’altra nota cara della vecchia
Torino, che si spegneva, la Torino dei nostri vecchi
che seppero tare l’Italia e con la virtù del risparmio e
una serena fiducia nel domani crearono quei capitali
che nel succedersi delle varie esposizioni torinesi (4) mo
strarono al mondo la vera potenza pacifica e costrut
tiva di un popolo temperante e prudente, paziente ed
operoso che sapeva ritrovare le più nascoste energie
di recupero senza quei vani altisonanti ritrovati alchi
mistici che più tardi, purtroppo, la nostra martoriata
generazione doveva dolorosamente sperimentare.
E così in queste lontane rimembranze
Sento rive, da chi sa qual distanssa
u arridili confus da l'aotra part dia vita
e l ricord d'ij me
1
ri, che mai am cliita,
destrofa fate a n'ultima spiranssa
» (5).
ANTONIO FOSSATI
(
1
)
itti M Munitimi»,
n t . im o , ifr. D eliberinone delta (ìiu nta ilei
1H febbraio.
•
(:)
lì. lijru.o,
T orino detcritta. lH/.y. pai: ■».»<>■
O) 1
l'irr*/
k
*.
T orino
c
i T n rinw i. T om o , •atte».
iH>S Le
prime
appbcazioni p rilli'e <ii iUflmmazionc e lfttm i l‘abbuino in occasione del-
l'Esposizione de! li*/*, i t a l'illuminazione di Puzza C irio Felice e della
nuova via/mne tentrale di Porta Nuova. Nel iHKs
u
delibera l'iìluniuu-
zione di l'uzza Vittorio. Via Po, Piazze l'anello. Palazzo di O t t i, S u
turo, V u G arii'ildi e V u Rom a. O r .
Atti <kl M i m i
io giugno iHXv
U)
Sulle vane esposizioni di Tonno si efr ; A. FOSSATI.
Lt r*po-
risumi inthutruh Ji iormo.
in
•
cronache Economiche» della
Canteri
di Commercio di Tonno, n
30
-
3 1
«H
15
marzo
1^48
e
srgg (Quattro
articoli con la « o ru delle esp<>siziom torino r. dal
1*05
ai (p o n i noitn).
(
5
)
\
mo
O tf.
1
, L'anima Beava.
30


















