
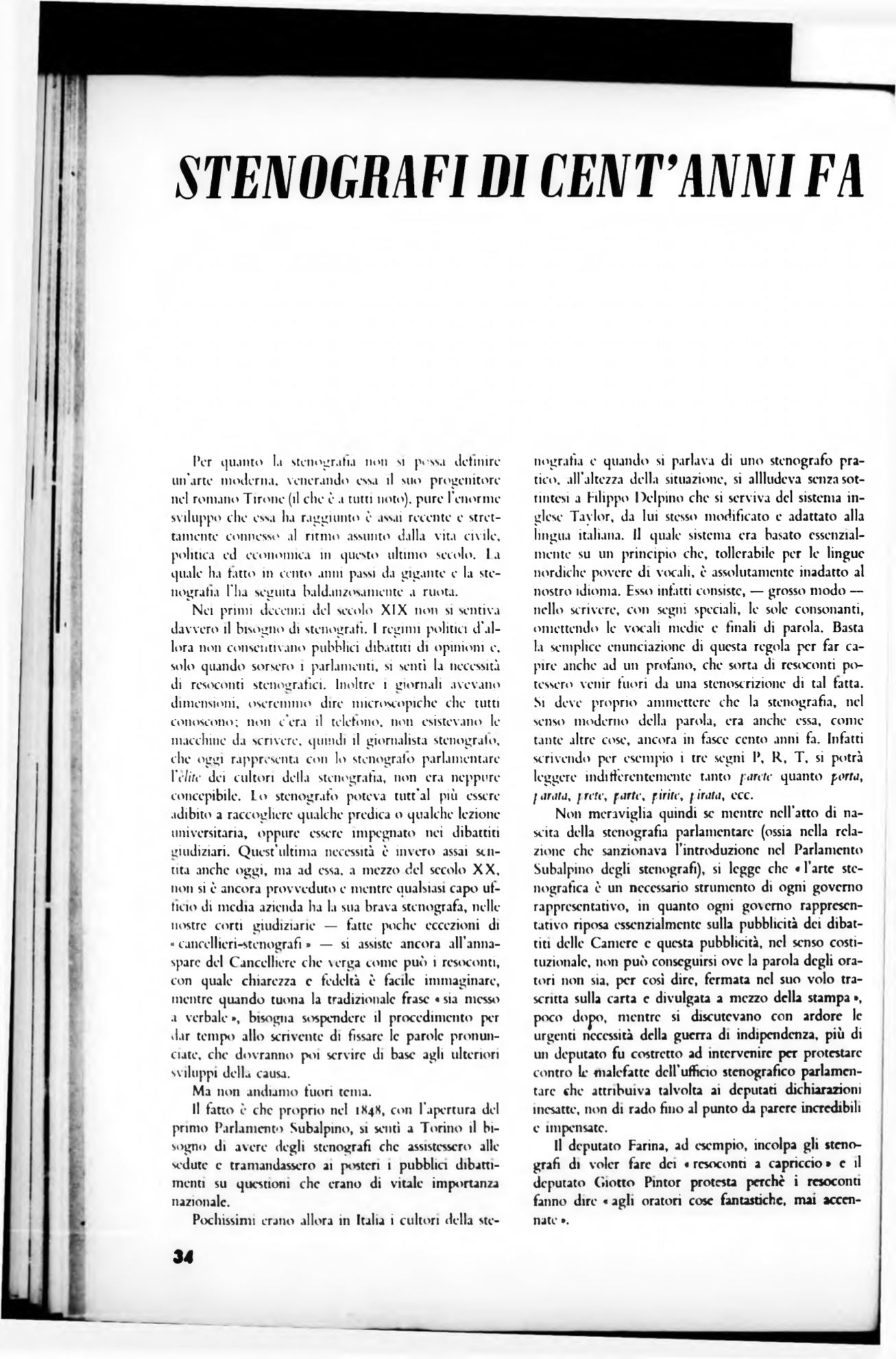
STENOGRAFIDICENT’ANNIFA
IVr quanto la stenografia non
m
possa definire
un’arte moderna, venerando essa il suo progenitore
nel romano Tirone (il che è a tutti noto), pure l'enorme
sviluppo che essa ha raggiunto è assai recente e stret
tamente connesso al ritmo assunto dalla vita civile,
politica ed economica in questo ultimo secolo. I a
quale ha fatto in cento anni passi da gigante e la ste
nografia l’ha seguita baldanzosamente a ruota.
Nei primi decenni del secolo XIX non si sentiva
davvero il bisogno di stenografi. I regimi politici d’al-
lora non consentivano pubblici dibattiti di opinioni e,
solo quando sorsero 1 parlamenti, si sentì la necessità
di resoconti stenografici. Inoltre i giornali avevano
dimensioni, oseremmo dire microscopiche che tutti
conoscono; non c era il telefono, non esistevano le
macchine da scrivere, quindi il giornalista stenografo,
che oggi rappresenta con lo stenografo parlamentare
l’
elite
dei cultori della stenografia, non era neppure
concepibile. Lo stenografo poteva tutt’al più essere
adibito a raccogliere qualche predica o qualche lezione
universitaria, oppure essere impegnato nei dibattiti
giudiziari. Quest’ultima necessità è invero assai sen
tita anche oggi, ma ad essa, a mezzo del secolo XX ,
non si è ancora provveduto e mentre qualsiasi capo uf
ficio di media azienda ha la sua brava stenografa, nelle
nostre corti giudiziarie — fatte poche eccezioni di
«cancellieri-stenografi » — si assiste ancora all’anna-
sparc del Cancelliere che \erga come può i resoconti,
con quale chiarezza e fedeltà è facile immaginare,
mentre quando tuona la tradizionale frase «sia messo
.1 verbale », bisogna sospendere il procedimento per
dar tempo allo scrivente di fissare le parole pronun
ciate, che dovranno poi servire di base agli ulteriori
sviluppi della causa.
Ma non andiamo fuori tema.
Il fatto è che proprio nel 1848, con l’apertura del
primo Parlamento Subalpino, si senti a Torino il bi
sogno di avere degli stenografi che assistessero alle
sedute e tramandassero ai posteri 1 pubblio dibatti
menti su questioni che erano di vitale importanza
nazionale.
Pochissimi erano allora in Italia i cultori della ste
nografia e quando si parlava di uno stenografo pra
tico, all’altezza della situazione, si allludeva senza sot
tintesi a Filippo Oclpino che si serviva del sistema in
glese Taylor, da lui stesso modificato e adattato alla
lingua italiana. Il quale sistema era basato essenzial
mente su un principio che, tollerabile per le lingue
nordiche povere di vocali, è assolutamente inadatto al
nostro idioma. Esso infatti consiste, — grosso modo —
nello scrivere, con segni speciali, le sole consonanti,
omettendo le vocali medie e finali di parola. Basta
la semplice enunciazione di questa regola per far ca
pire anche ad un profano, che sorta di resoconti po
tessero venir fuori da una stcnoscrizionc di tal fatta.
Si deve proprio ammettere che la stenografia, nel
senso moderno della parola, era anche essa, come
tante altre cose, ancora in fasce cento anni fa. Infatti
scrivendo per esempio i tre segni P, R , T, si potrà
leggere indifferentemente tanto
parete
quanto
porta,
Iarata, prete, parte, pirite, pirata,
ecc.
Nmi meraviglia quindi se mentre nell’atto di na
scita della stenografia parlamentare (ossia nella rela
zione che sanzionava l’introduzione nel Parlamento
Subalpino degli stenografi), si legge che
•
l’arte ste
nografica è un necessario strumento di ogni governo
rappresentativo, in quanto ogni governo rappresen
tativo riposa essenzialmente sulla pubblicità dei dibat
titi delle Camere e questa pubblicità, nel senso costi
tuzionale, non può conseguirsi ove la parola degli ora
tori non sia, per così dire, fermata nel suo volo tra
scritta sulla carta e divulgata a mezzo della stampa »,
poco dopo, mentre si discutevano con ardore le
urgenti necessità della guerra di indipendenza, più di
un deputato fu costretto ad intervenire per protestare
contro le malefatte dcH’ ufficio stenografico parlamen
tare che attribuiva talvolta ai deputati dichiarazioni
inesatte, non di rado fino al punto da parere incredibili
e impensate.
Il deputato Farina, ad esempio, incolpa gli steno
grafi di voler fare dei « resoconti a capriccio * e il
deputato Ciotto Pintor protesta perchè i resoconti
fanno dire « agli oratori cose fantastiche, mai accen
nate ».
34


















