
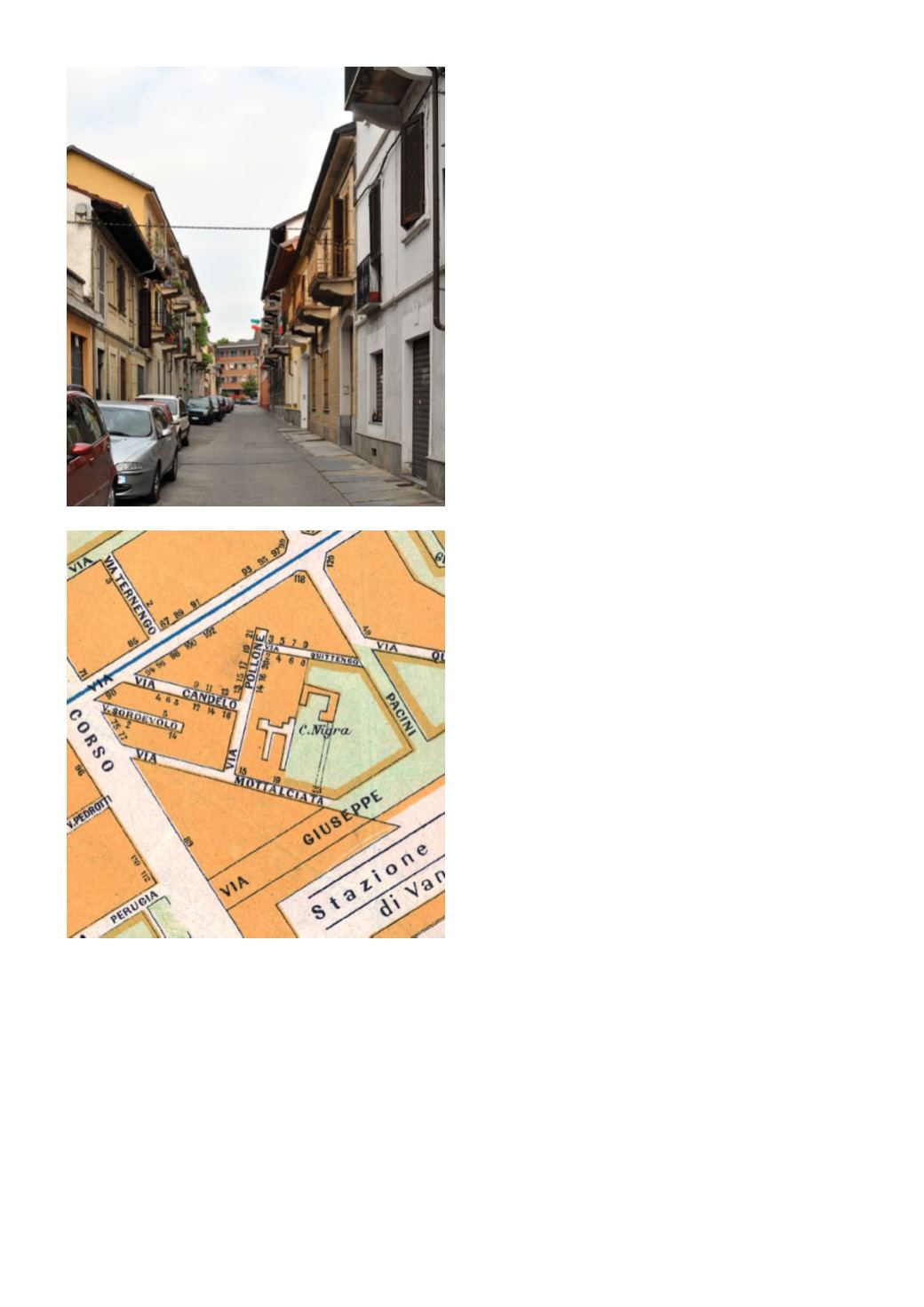
18
subisce poi ampliamenti normati, tali da rendere non
sempre facile l’individuazione topologica d’origine.
Per i borghi di Torino, l’innesco cronologico risul-
ta essere diramato: in quanto può partire da fonda-
zioni relative alle epoche medievale o moderna, che
appaiono filtrate dalla pace di Aquisgrana (1748), in
una sorta di rifondazione codificata da nuove norme,
cui si legano nuovi usi ed esiti in aree territoriali vi-
cine o lontane rispetto alla città fortificata; oppure,
tale innesco può partire dal primo Ottocento, dopo la
battaglia di Marengo (1800), in concomitanza sia con
l’ordine di Napoleone per lo spianamento della cer-
chia fortificata, ormai desueta infrastruttura di difesa,
sia – più tardi, nella Restaurazione – con la successiva
possibilità di ampliamento urbano per parti borghi-
giane, esterne o tangenti alla città esistente non più
chiusa dalle fortificazioni.
In generale, l’appartenenza a una sorta di area cul-
turale romanza (per esempio, la Francia meridionale
e l’Italia) fa sì che, nel medioevo, il termine di borgo
assuma, fondamentalmente, il significato di una real-
tà insediativa non urbana (ma, talora, vicina alla città)
e sprovvista di elementi di difesa (ma di tipo compatto
e agglomerato). Diversa è, invece, la situazione per le
zone europee settentrionali (per esempio, Germania,
Inghilterra, Francia del Nord), dove, nel medioevo,
il termine di borgo conserva il significato originario
di fortificazione, e in particolare di nucleo urbano
fortificato.
Tornando all’area culturale romanza, è possibile
sostenere che una tendenziale assenza di difesa ren-
da quei borghi vulnerabili e soggetti a distruzioni, sino
a quando, dopo Aquisgrana – come s’è detto – si può
dire che il territorio diventi luogo sicuro per la resi-
denza e per le attività produttive.
Per valutare la morfologia dei borghi, si deve far
riferimento a due tipi di localizzazione: essere
extra
muros
o essere entro cinta. Quando i borghi sono
esterni alle cortine delle mura o alle cerchie delle for-
tificazioni risultano quali agglomerati la cui forma è
legata sia a un asse stradale importante o a un corso
d’acqua, sia alla presenza di manifatture o di chiese,
che fungono o da assi portanti per lo sviluppo o da
nuclei di aggregazione. Dopo l’inclusione nella cinta
daziaria, i borghi mantengono, di norma, un tipo di morfologia che manifesta una “durez-
za” strutturale di tipo intrinseco (per destinazioni d’uso e forma urbana), che non risulta
piegarsi agli schemi di pianificazione regolare dell’ampliamento urbano normato.
Per le borgate di Torino, l’innesco cronologico è nell’Ottocento, in connessione con le
barriere – cioè, le aperture per il passaggio – della prima cinta daziaria (1853-1912). Lo
stratificarsi fisico e funzionale delle borgate è dovuto alla capacità di aggregazione che, in
forma di piccoli nuclei, svolgono gli spazi urbani delle barriere; attorno a tali spazi, risulta
avviarsi un processo di edificazione, che è più o meno lento e definito a seconda di casi di-
versi, che sono, sia legati al carattere delle barriere – di prim’ordine, di second’ordine o di
minore importanza –, sia connessi a fenomeni specifici, relativi alla presenza di fabbricati
industriali, di nuove chiese o di lottizzazioni private su grandi aree esterne alla cinta. Si può
dire che la lentezza e l’eterogeneità di costruzione delle borgate siano fatti dovuti, fonda-
mentalmente, a scelte di tipo economico: vivere fuori cinta costava poco (meno, rispetto
al costo della vita entro cinta, su cui gravavano le varie imposte del dazio), e poi, vicino alla


















