
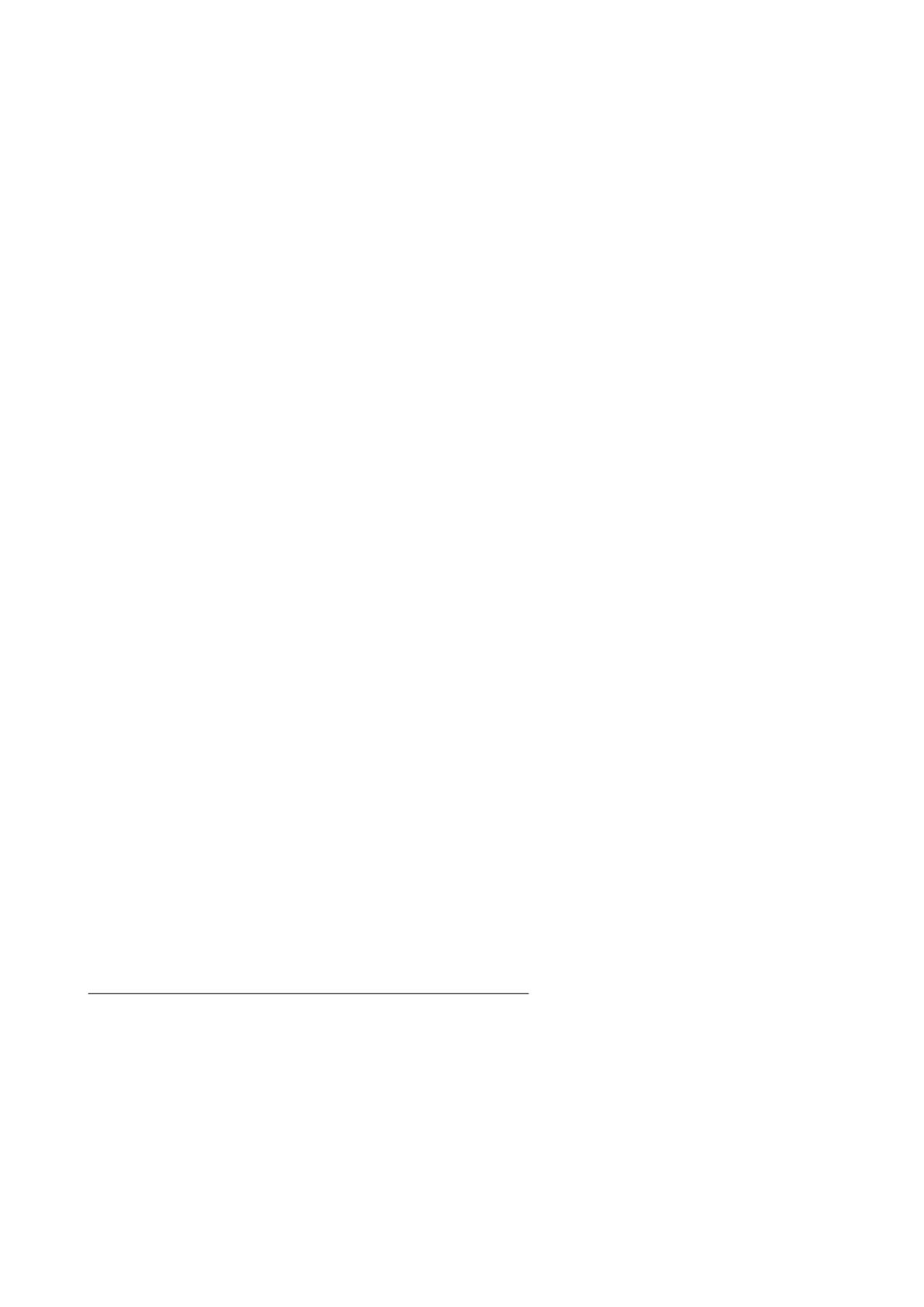
Connotazione dei luoghi non centrali
attraverso la cartografia storica
Chiara Devoti
Rispetto al cosiddetto “nucleo di più antica acculturazione”
1
della città capitale, i luoghi
non centrali rappresentano settori urbani di crescente rilievo, che tuttavia spesso sfuggo-
no all’attenzione generale nonostante la loro ragguardevole estensione e il loro risvolto
sostanziale nella gestione stessa della città. Ritracciarne le origini, comprenderne il peso
nello sviluppo cittadino, sono i fini di questa ricerca, nell’ambito della quale l’analisi della
cartografia storica ha occupato un ruolo di tutto rilievo, nella convinzione dell’importanza
del mostrare, nel disegno preciso del rilevamento, o nella previsione del progetto, il ruolo
fondamentale dei segni territoriali e urbani per la comprensione delle scelte urbanistiche,
delle costrizioni topografiche (con il relativo violarle o viceversa assecondarle), dei lacerti
di strutture più antiche in grado di condizionare il reticolo viario e la composizione urbana.
Nel contesto di una città ipernormata, nata come capitale e come tale sempre conside-
rata
2
, la cartografia storica appare ricchissima
3
, sicché più che una lista – che rischierebbe
sempre di tralasciare qualche dato più che significativo – si propone qui una disamina di
alcuni segmenti di periodizzazione urbanistica con il relativo appoggio di una selezione di
mappe reputate emblematiche. Otto di queste, fondamentali per l’analisi, sono oggetto
anche di una schedatura minuziosa in allegato.
La cartografia del Settecento, dalla città capitale al contado
La cartografia storica, anche quando sia concentrata soprattutto sul nucleo più propria-
mente cittadino o sulla cerchia della fortificazione – compiuta per settori successivi tra la
seconda metà del Cinquecento e gli anni venti del Settecento e ormai alla metà di questo
secolo
oeuvre architecturale achevée
4
– non trascura sovente l’immagine del territorio
circostante, contribuendo in modo determinante alla individuazione di quegli elementi
morfogenetici (cascine, bealere, strade extraforanee, complessi religiosi) che sono alla
base dello sviluppo dei borghi e delle borgate. Se infatti, la struttura storica della città
5
, alle
soglie del passaggio dalla connotazione di capitale di un semplice, per quanto strategico,
ducato a quella di
caput
di un regno (con il trattato di Utrecht del 1713)
6
, non annovera
che i due borghi della Dora e del Po, i fattori che porteranno alla formazione degli altri
1
Il termine, che definisce in modo estremamente chiaro quale sia il ruolo generatore e polarizzante del
settore centrale della città, sostituendo e integrando il concetto di centro storico, è stato introdotto in occa-
sione delle analisi per il PRG cittadino del 1980, poi non attuato, ed è criticamente discusso in
Beni Culturali
Ambientali
, 1984, p. 17.
2
Comoli Mandracci, 2000, p. 11.
3
Per uno sguardo completo alla produzione cartografica relativa alla città si veda Lupo, 1989.
4
Comoli Mandracci, 1983.
5
Ancora per questa definizione, si rimanda all’Introduzione, in
Beni Culturali Ambientali
, 1984, pp. 17-22.
6
Si tratta non di un solo trattato, ma di una serie di trattati di pace, firmati a Utrecht tra marzo e aprile del
1713, al termine della guerra di successione spagnola. A Vittorio Amedeo II di Savoia è concesso il titolo di re
di Sicilia (poi scambiato con quello di Sardegna qualche anno dopo, nel 1718), è reso il contado di Nizza, viene
assegnata la Sicilia (da cui deriva appunto la regalità), il Monferrato, Alessandria, Valenza, tutta l’alta valle di
Susa, Pinerolo, le vallate alpine di frontiera a questa piazzaforte connesse, e alcune parti del territorio già mi-
lanese, fino al confine naturale rappresentato dalla Sesia.


















