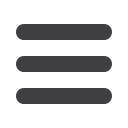
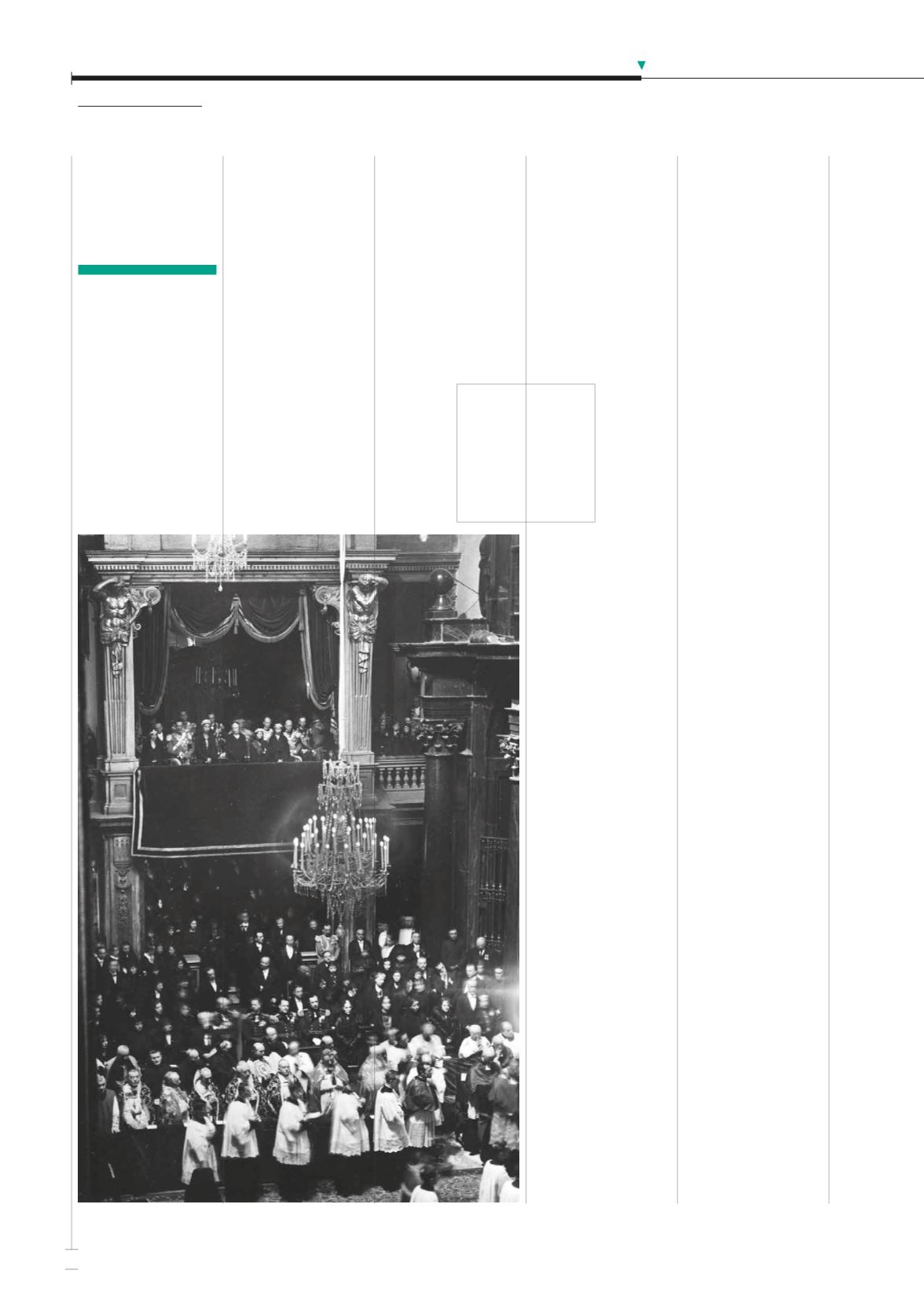
Rivista MuseoTorino / n.8
Le ostensioni
nella storia della città
di
Fulvio Peirone
el
1562Emanuele Filiberto trasferì la
capitale del ducato di Savoia da Chambéry
a Torino; sedici anni più tardi giunse anche
la Sindone. Ufficialmente il trasferimento
della reliquia era un atto di cortesia per
risparmiare la fatica del viaggio attraverso le
Alpi a Carlo Borromeo, che aveva espresso
il desiderio di recarsi a venerarla, ma in
pratica il trasporto del sudario sanciva
definitivamente il ruolo di Torino capitale: Emanuele
Filiberto e i suoi successori ne promossero il culto per
accrescere il prestigio del proprio casato. Anche la Città di
Torino fu coinvolta nei preparativi: il verbale del Consiglio
decurionale (l’attuale Consiglio comunale) del 9 settembre
1578 attesta gli sforzi compiuti dal Municipio per garantire
il trasporto in processione della reliquia da Lucento al
palazzo ducale e consentirne l’ostensione venti giorni dopo,
la prima nella nuova capitale.
La Sindone veniva offerta in vista al popolo e alla
venerazione dei fedeli il 4 maggio di ogni anno, ricorrenza
liturgica fissata dal papa Giulio II a partire dal 1506 e
ribadita da Gregorio XIII con «breve pontificio» il 12 aprile
1582. Il documento, sontuosamente ornato con l’immagine
del sudario e lo stemma papale, oltre a concedere «plenaria
indulgenza e remissione di tutti i peccati» ai fedeli presenti
all’ostensione, formalizzava la liturgia anche al di qua delle
Alpi. Tuttavia epidemie, guerre, carestie e avvenimenti
eccezionali impedirono la regolare cadenza delle ostensioni.
Il 1° aprile 1633 Vittorio Amedeo I annunciava la ripresa
della festa del 4 maggio «tralasciata gli anni passati per
l’universale calamità del Contagio», la terribile peste nera
descritta da Alessandro Manzoni che colpì le principali
città d’Europa. Di fronte al dilagare dell’epidemia anche
la comunità torinese, riconosciutasi inerme, si rivolse
all’Altissimo: «Dalla peste dalla guerra e dalla fame ci liberi
nostro Dio onnipotente» è la laconica quanto disperata
invocazione che apre il libro dei verbali del Consiglio
comunale del 1630.
Non di rado i duchi di Savoia associavano le ostensioni
a spettacolari gesti di magnanimità volti a consolidare il
consenso popolare. Il 20 aprile 1656 Carlo Emanuele II
accordò l’immunità a tutti i visitatori,
ancorché
ricercati
,
vietando il sequestro di animali e oggetti in loro possesso.
In quegli anni le massime attenzioni del duca erano tuttavia
rivolte al «Castigo de Dios», una nuova ondata pestilenziale
proveniente dalla Spagna e propagatasi nel nostro Paese
a partire dal 1642, dapprima in Sardegna, poi nell’Italia
centro-meridionale e infine a Genova. Carlo Emanuele II,
con manifesto del 4 aprile 1658, «per impetrare dalla Divina
Provvidenza l’abbondanza delle sue celesti grazie» invitava la
N
Da privilegio di pochi
a pellegrinaggio di massa
La solenne Ostensione
della Santa Sindone alla
presenza dei Principi di
Piemonte e di Casa Reale
,
3 maggio 1931. Archivio
Storico della Città di Torino.
Le ostensioni
/
The exhibitions
18
















