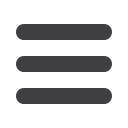
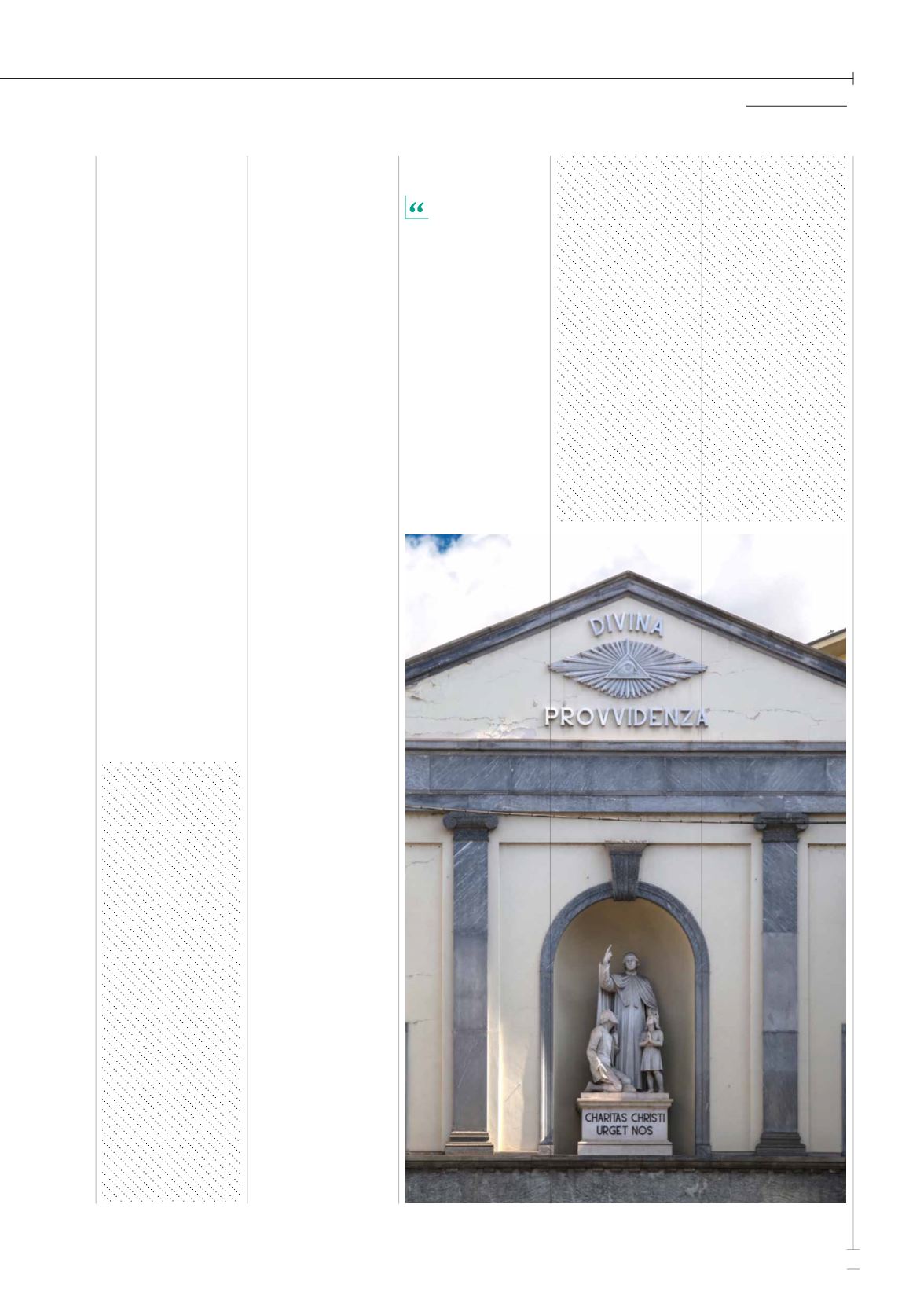 www.museotorino.it
www.museotorino.it
a 3.187. Nacque allora, per gli adulti, l’equivalente dei cantieri
lavoro per disoccupati: furono impiegati per il trasporto terra,
iniziando lo sterro per i grandi corsi ottocenteschi.
La Restaurazione determinò immediatamente un aumento
della popolazione: poco più di 84.000 individui nella
primavera del 1814. Ma nel 1830 si superavano già i 122.000
e i 125.000 nel 1848. È difficile ipotizzare che questo
eccezionale sviluppo demografico sia stato provocato da
un parallelo sviluppo economico. Questo era stato per
buona parte il meccanismo che aveva fatto crescere altre
città europee, come Parigi e Londra. A Torino, invece, si era
verificato innanzitutto il ritorno di coloro che se ne erano
allontanati con l’arrivo dei francesi: basti pensare alla Corte
sabauda e al suo grande indotto. Inoltre Torino si ritrovava
capitale di uno Stato più vasto, dopo l’annessione dell’intera
Liguria. La città ritornava ad essere un importante centro
militare, con un aumento notevole dell’indotto, per il ritorno
alla piena attività delle relative manifatture, a partire dalla
siderurgia. Inoltre non bisogna dimenticare che Torino, come
altri grandi centri urbani coevi, svolgeva un ulteriore compito
di volano per assorbire i malanni della società preindustriale
che determinavano le migrazioni interne, soprattutto quelle
stagionali. Nel periodo dei raccolti il contado richiamava i
poveri per la presenza di probabili eccedenze alimentari, che
invece d’inverno erano maggiormente disponibili in città
dopo che vi erano state immagazzinate. La città, comunque,
vedeva la compresenza di nobiltà e borghesia con un’ampia
massa di poveri e diseredati, soprattutto nei sobborghi
particolarmente degradati lungo il perimetro del vecchio
insediamento settecentesco e i corsi dei fiumi.
Se si seguono i segni e i documenti lasciati dalle opere
sociali di quel periodo, insieme con le testimonianze dei
rapporti interpersonali fra i cosiddetti operatori del sociale
e i rappresentanti delle pubbliche istituzioni – Chiesa,
Monarchia, Governo e Municipio – pare di intravedere un
progetto generale, entro il quale essi svolsero la loro opera
Il Cottolengo
: la Chiesa
Grande. Fotografia di Roberto
Cortese, 2015. Archivio
Storico della Città di Torino.
Un’ampia massa di poveri
e diseredati, soprattutto
nei sobborghi particolarmente
degradati lungo il perimetro
del vecchio insediamento
settecentesco e i corsi
dei fiumi
23
















