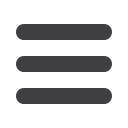
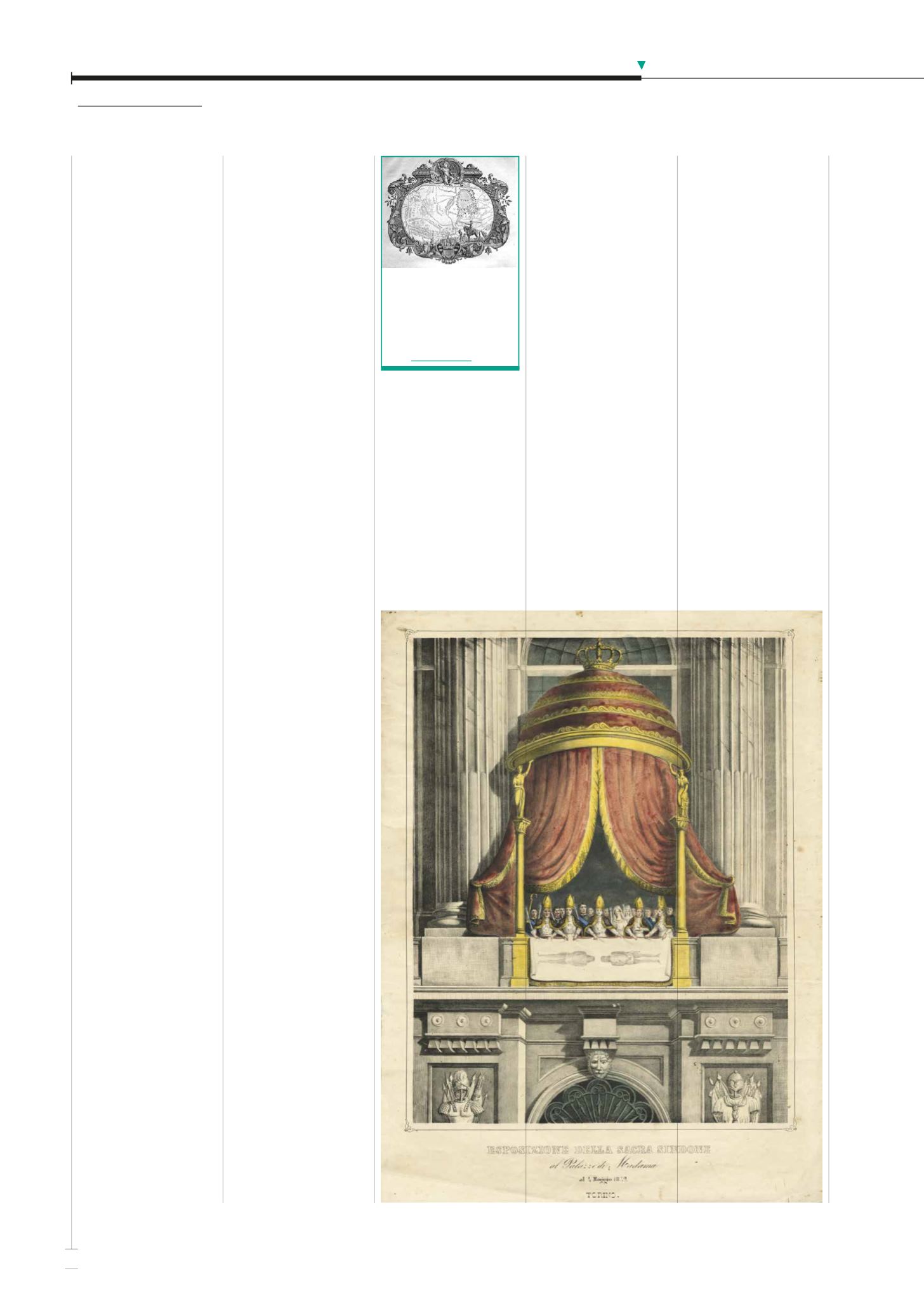
Rivista MuseoTorino / n.8
esposizioni private, in particolare quelle avvenute nel 1798
nell’appartamento reale di Carlo Emanuele IV poco prima
del suo esilio, e nel 1804, quando la reliquia fu mostrata a
papa Pio VII di passaggio a Torino alla volta di Parigi per la
consacrazione di Napoleone a imperatore.
La Sindone veniva mostrata al popolo dal padiglione in legno
che chiudeva la piazzetta Reale: il sudario era esposto sopra
la porta centrale, un edificio a forma di torre con cupola. Nel
1811 un incendio distrusse la struttura: di lì in poi il meticoloso
cerimoniale subì sostanziali variazioni e l’ostensione della
reliquia fu compiuta dai balconi di Palazzo Madama, anche
per consentirne la visione alla folla accalcata nelle vie adiacenti
piazza Castello. Così avvenne la mattina del 21 maggio
1815 alle ore otto: protagonista, ancora una volta, Pio VII di
ritorno dalla prigionia di Fontainbleau. Una curiosità: le aste
del baldacchino utilizzato per il trasporto della Sindone a
Palazzo Madama furono sostenute dal re Vittorio Emanuele
I e da Carlo Alberto. L’ultima ostensione del secolo avvenne
nel 1898, anno dell’Esposizione nazionale nel cinquantenario
dello Statuto albertino a cui si affiancò la mostra di Arte
Sacra, allestita per festeggiare varie ricorrenze religiose tra cui
il terzo «centenario della traslazione della Santa Sindone da
Chambéry a Torino», evento celebrato con vent’anni di ritardo.
La prima del nuovo secolo avvenne nel 1931, in occasione
del matrimonio di Umberto di Savoia con Maria José del
Belgio, e la successiva nel 1933, «Anno Santo straordinario»:
il regime non mancò di far propria l’iniziativa esaltando le
«solenni manifestazioni patriottiche e fasciste» tra cui appunto
l’ostensione della Sindone, «l’avvenimento che le coronò».
La reliquia, trasferita dal 1939 al 1946 presso l’Abbazia
di Montevergine in provincia di Avellino per sottrarla ai
bombardamenti, per molto tempo non fu offerta alla vista
dei fedeli: l’ostensione televisiva del 1973, primo evento
mediatico nell’era della globalizzazione, pose fine alla celata
custodia. Fecero seguito quella del 1978, la più imponente
per numero di visitatori; 1998, la prima dell’era internet con
oltre centomila contatti registrati sul sito ufficiale; 2000,
l’anno del giubileo; 2010, la prima del terzo millennio; infine
quella del 30 marzo 2013, nel corso di una liturgia in diretta
televisiva.
Un epocale fenomeno di massa si rivelò l’ostensione del 26
agosto - 8 ottobre 1978, la prima dal dopoguerra e la prima
a permettere una valutazione in chiave sociologica. L’evento
si inserì in un quadro di lotta politica, in atto da anni, che
contrapponeva fazioni estremistiche che rischiarono di
trascinare il Paese alle soglie di una guerra civile e posero
i presupposti per l’insorgenza del terrorismo politico:
alla fine gli arrestati furono migliaia, i morti e i feriti
centinaia.
Il 1978 fu costellato da un’alternanza di eventi,
perlopiù drammatici, entrati nella storia del nostro Paese:
il sequestro di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della
scorta (16 marzo), i 55 giorni più lunghi della Repubblica e
l’assassinio dello statista (9 maggio), l’omicidio di mafia di
Peppino Impastato (9 maggio), le dimissioni di Giovanni
Leone dalla Presidenza della Repubblica (15 giugno), la
conclusione a Torino del processo alle Brigate Rosse (24
giugno), l’elezione di Sandro Pertini a Capo dello Stato (8
luglio), la morte di papa Paolo VI (6 agosto), i trentatré
giorni di pontificato di Giovanni Paolo I (26 agosto-28
settembre), l’elezione di Karol Wojtyla (16 ottobre). Non
sorprende dunque il numero dei visitatori, tre milioni e
mezzo, il più alto di sempre: il rapido incedere degli eventi
fu esorcizzato dai cattolici con la riscoperta del «sacro»
quale condizione di conforto spirituale, e dai laici con
la condivisione di un’«icona» recepita quale elemento
aggregante culturale, fatta propria dalla quasi totalità dei
membri di una società variegata ma non ancora multietnica.
Come testimoniano i titoli della rassegna stampa, accanto
alle classiche tematiche religiose emersero questioni di
tutt’altra natura: «Torino rossa si trasforma nella città del
pellegrino», «Il restauro della città costerà un miliardo»,
«La Sindone, un appuntamento religioso che ha fatto
riscoprire cultura e arte», «Le spese dei turisti, almeno 17
miliardi», «Il malumore dei commercianti per lo scarso
volume di affari»… Una ricerca durata quattro anni e
coordinata da Franco Garelli ricomprese i visitatori in varie
categorie sociali, su tutti laureati e diplomati, provenienti
principalmente dalle grandi città e dalle regioni “rosse” della
Toscana e dell’Emilia Romagna. L’organizzazione ecclesiale
incise solo parzialmente nel convogliare i pellegrini a
Torino: circa la metà dei visitatori si spostò infatti con mezzi
propri e seicentomila sfilarono davanti alla Sindone senza
avere una particolare fede o credenza religiosa; il
business
toccò Torino in maniera massiccia per un giro di affari
pari a circa trenta miliardi di lire. L’ostensione del 1978
fu dunque un ponte tra passato e futuro, il crinale di una
società martoriata dagli eventi, ancorata alle tradizioni, ma
ormai avviata verso una fase di totale evoluzione.
■
Assedio del 1706
Da giugno a settembre 1706 Torino
fu cinta nell’assedio delle truppe
francesi. La Sindone lasciò Torino
alla volta di Genova.
leggi su
www.museotorino.itEsposizione
della Sacra Sindone
a Palazzo Madama
, 1842.
Archivio Storico della
Città di Torino.
Le ostensioni
/
The exhibition
20
















