
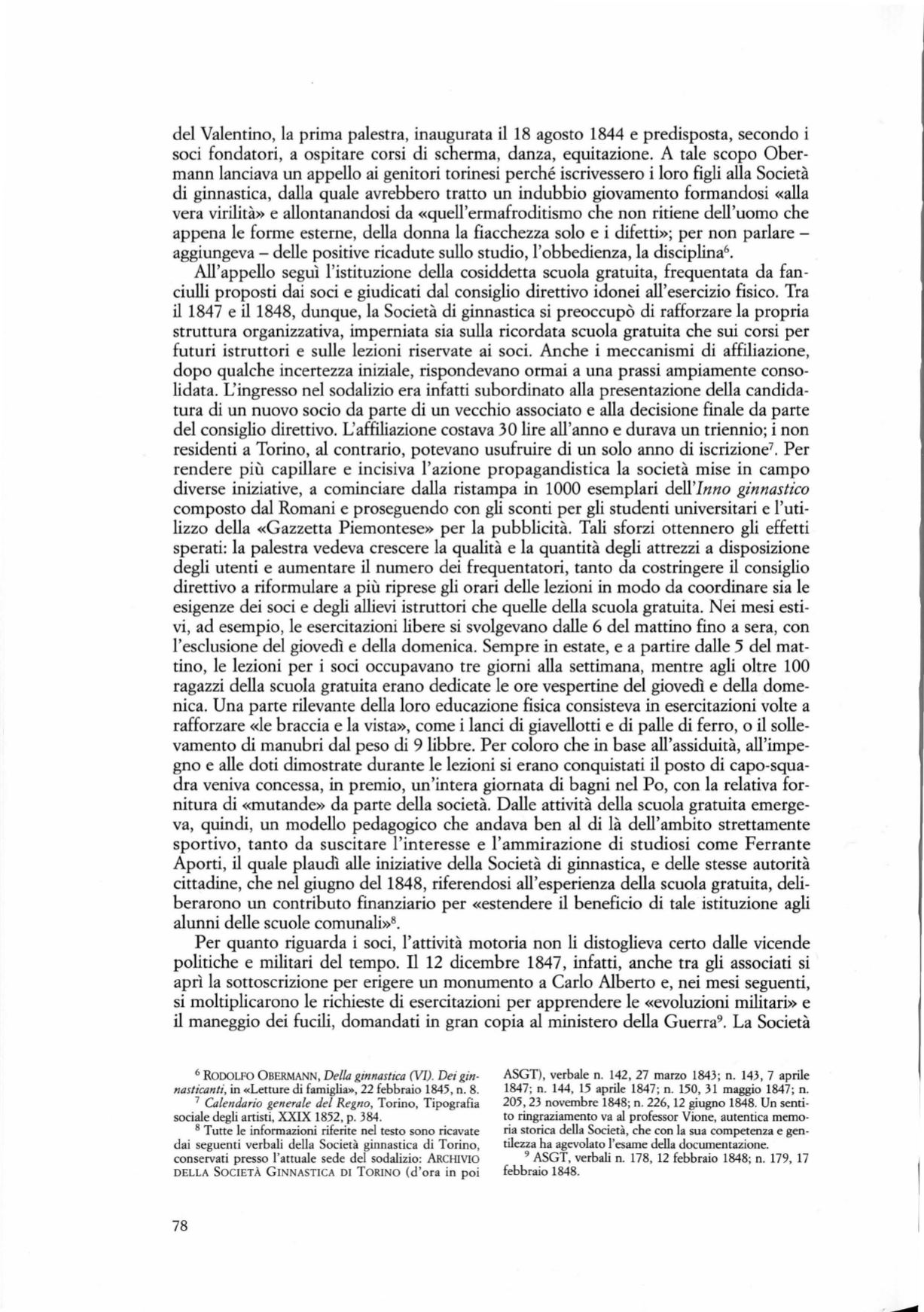
del Valentino, la prima palestra, inaugurata il
18
agosto
1844
e predisposta, secondo i
soci fondatori , a ospitare corsi di scherma, danza, equitazione. A tale scopo Ober–
mann lanciava un appello ai genitori torinesi perché iscrivessero i loro figli alla Società
di ginnastica, dalla quale avrebbero tratto un indubbio giovamento formandosi «alla
vera virilità» e allontanandosi da «quell'ermafroditismo che non ritiene dell'uomo che
appena le forme esterne, della donna la fiacchezza solo e i difetti»; per non parlare -
aggiungeva - delle positive ricadute sullo studio, l'obbedienza, la disciplina
6 •
All'appello seguì l'istituzione della cosiddetta scuola gratuita, frequentata da fan–
ciulli proposti dai soci e giudicati dal consiglio direttivo idonei all'esercizio fisico. Tra
il
1847
e il
1848,
dunque, la Società di ginnastica si preoccupò di rafforzare la propria
struttura organizzativa, imperniata sia sulla ricordata scuola gratuita che sui corsi per
futuri istruttori e sulle lezioni riservate ai soci. Anche i meccanismi di affiliazione,
dopo qualche incertezza iniziale, rispondevano ormai a una prassi ampiamente conso–
lidata. L'ingresso nel sodalizio era infatti subordinato alla presentazione della candida–
tura di un nuovo socio da parte di un vecchio associato e alla decisione finale da parte
del consiglio direttivo. L'affiliazione costava 30 lire all'anno e durava un triennio; i non
residenti a Torino, al contrario, potevano usufruire di un solo anno di iscrizione
7 •
Per
rendere più capillare e incisiva l'azione propagandistica la società mise in campo
diverse iniziative, a cominciare dalla ristampa in 1000 esemplari
dell'Inno ginnastico
composto dal Romani e proseguendo con gli sconti per gli studenti universitari e l'uti–
lizzo della «Gazzetta Piemontese» per la pubblicità. Tali sforzi ottennero gli effetti
sperati: la palestra vedeva crescere la qualità e la quantità degli attrezzi a disposizione
degli utenti e aumentare il numero dei frequentatori, tanto da costringere il consiglio
direttivo a riformulare a più riprese gli orari delle lezioni in modo da coordinare sia le
esigenze dei soci e degli allievi istruttori che quelle della scuola gratuita. Nei mesi esti–
vi, ad esempio, le esercitazioni libere si svolgevano dalle 6 del mattino fino a sera, con
l'esclusione del giovedì e della domenica. Sempre in estate, e a partire dalle 5 del mat–
tino, le lezioni per i soci occupavano tre giorni alla settimana, mentre agli oltre 100
ragazzi della scuola gratuita erano dedicate le ore vespertine del giovedì e della dome–
nica. Una parte rilevante della loro educazione fisica consisteva in esercitazioni volte a
rafforzare «le braccia e la vista», come i lanci di giavellotti e di palle di ferro, o il solle–
vamento di manubri dal peso di 9 libbre. Per coloro che in base all'assiduità, all'impe–
gno e alle doti dimostrate durante le lezioni si erano conquistati il posto di capo-squa–
dra veniva concessa, in premio, un'intera giornata di bagni nel Po, con la relativa for–
nitura di «mutande» da parte della società. Dalle attività della scuola gratuita emerge–
va, quindi, un modello pedagogico che andava ben al di là dell'ambito strettamente
sportivo, tanto da suscitare l'interesse e l'ammirazione di studiosi come Ferrante
Aporti, il quale plaudì alle iniziative della Società di ginnastica, e delle stesse autorità
cittadine, che nel giugno del
1848,
riferendosi all'esperienza della scuola gratuita, deli–
berarono un contributo finanziario per «estendere il beneficio di tale istituzione agli
alunni delle scuole comunali»8.
Per quanto riguarda i soci, l'attività motoria non li distoglieva certo dalle vicende
politiche e militari del tempo. Il
12
dicembre
1847,
infatti, anche tra gli associati si
aprì la sottoscrizione per erigere un monumento a Carlo Alberto e, nei mesi seguenti,
si moltiplicarono le richieste di esercitazioni per apprendere le «evoluzioni militari» e
il maneggio dei fucili , domandati in gran copia al ministero della Guerra
9 .
La Società
6
RODOLFO OBERMANN,
Della ginnastica (VI). Dei gin–
nasticanti,
in «Letture di famiglia», 22 febbraio 1845, n. 8.
7
Calendario generale del Regno,
Torino, Tipografia
sociale degli artisti, XXIX 1852, p. 384.
8
Tutte le informazioni riferite nel testo sono ricavate
dai seguenti verbali della Società ginnastica di Torino,
conservati presso l'attuale sede del sodalizio: ARCHIVIO
DELLA SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO (d'ora in poi
78
ASGT), verbale n. 142, 27 marzo 1843; n. 143, 7 aprile
1847; n. 144, 15 aprile 1847; n. 150,31 maggio 1847; n.
205,23 novembre 1848; n. 226, 12 giugno 1848. Un senti–
to ringraziamento va
al
professor Vione, autentica memo–
ria storica della Società, che con la sua competenza e gen–
tilezza ha agevolato l'esame della documentazione.
9
ASGT, verbali n. 178, 12 febbraio 1848; n. 179, 17
febbraio 1848.


















