
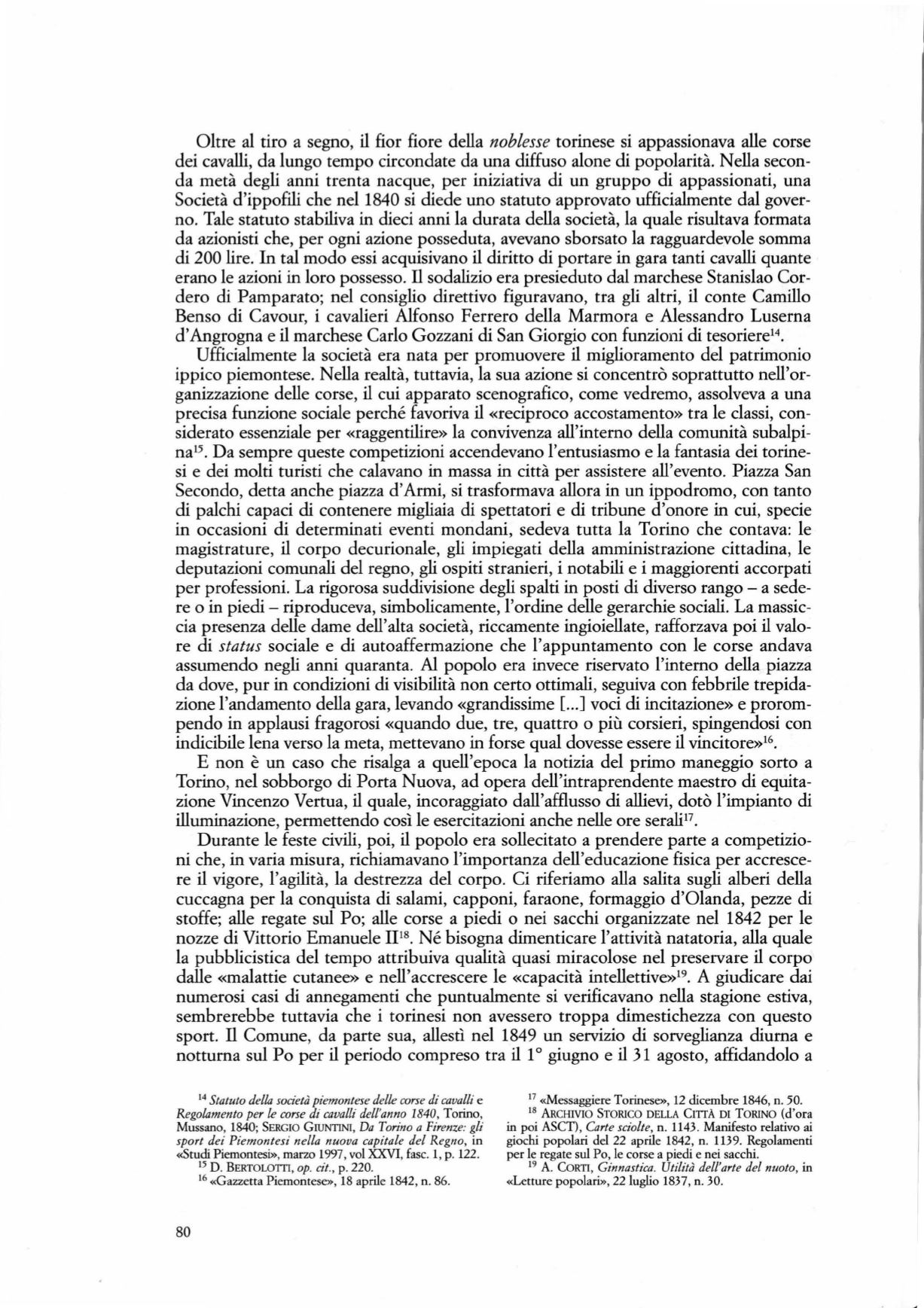
Oltre al tiro a segno, il fior fiore della
noblesse
torinese si appassionava alle corse
dei cavalli, da lungo tempo circondate da una diffuso alone di popolarità. Nella secon–
da metà degli anni trenta nacque, per iniziativa di un gruppo di appassionati, una
Società d'ippofili che nel 1840 si diede uno statuto approvato ufficialmente dal gover–
no. Tale statuto stabiliva in dieci anni la durata della società, la quale risultava formata
da azionisti che, per ogni azione posseduta, avevano sborsato la ragguardevole somma
di 200 lire. In tal modo essi acquisivano il diritto di portare in gara tanti cavalli quante
erano le azioni in loro possesso.
li
sodalizio era presieduto dal marchese Stanislao Cor–
dero di Pamparato; nel consiglio direttivo figuravano, tra gli altri, il conte Camillo
Benso di Cavour, i cavalieri Alfonso Ferrero della Marmora e Alessandro Luserna
d'Angrogna e il marchese Carlo Gozzani di San Giorgio con funzioni di tesoriere 14.
Ufficialmente la società era nata per promuovere il miglioramento del patrimonio
ippico piemontese. Nella realtà, tuttavia, la sua azione si concentrò soprattutto nell'or–
ganizzazione delle corse, il cui apparato scenografico, come vedremo, assolveva a una
precisa funzione sociale perché favoriva il «reciproco accostamento» tra le classi, con–
siderato essenziale per «raggentilire» la convivenza all'interno della comunità subalpi–
na 15. Da sempre queste competizioni accendevano l'entusiasmo e la fantasia dei torine–
si e dei molti turisti che calavano in massa in città per assistere all'evento. Piazza San
Secondo, detta anche piazza d'Armi, si trasformava allora in un ippodromo, con tanto
di palchi capaci di contenere migliaia di spettatori e di tribune d'onore in cui, specie
in occasioni di determinati eventi mondani, sedeva tutta la Torino che contava: le
magistrature, il corpo decurionale, gli impiegati della amministrazione cittadina, le
deputazioni comunali del regno, gli ospiti stranieri, i notabili e i maggiorenti accorpati
per professioni. La rigorosa suddivisione degli spalti in posti di diverso rango - a sede–
re o in piedi - riproduceva, simbolicamente, l'ordine delle gerarchie sociali. La massic–
cia presenza delle dame dell' alta società, riccamente ingioiellate, rafforzava poi il valo–
re di
status
sociale e di autoaffermazione che l'appuntamento con le corse andava
assumendo negli anni quaranta. Al popolo era invece riservato l'interno della piazza
da dove, pur in condizioni di visibilità non certo ottimali, seguiva con febbrile trepida–
zione l'andamento della gara, levando «grandissime [...
J
voci di incitazione» e prorom–
pendo in applausi fragorosi «quando due, tre, quattro o più corsieri, spingendosi con
indicibile lena verso la meta, mettevano in forse qual dovesse essere il vincitore»16.
E non
è
un caso che risalga a quell'epoca la notizia del primo maneggio sorto a
Torino, nel sobborgo di Porta Nuova, ad opera dell'intraprendente maestro di equita–
zione Vincenzo Vertua, il quale, incoraggiato dall'afflusso di allievi, dotò l'impianto di
illuminazione, permettendo così le esercitazioni anche nelle ore serali
17 •
Durante le feste civili, poi, il popolo era sollecitato a prendere parte a competizio–
ni che, in varia misura, richiamavano l'importanza dell'educazione fisica per accresce–
re il vigore, l'agilità, la destrezza del corpo.
Ci
riferiamo alla salita sugli alberi della
cuccagna per la conquista di salami, capponi, faraone , formaggio d'Olanda, pezze di
stoffe; alle regate sul Po; alle corse a piedi o nei sacchi organizzate nel 1842 per le
nozze di Vittorio Emanuele 11
18 •
Né bisogna dimenticare l'attività natatoria, alla quale
la pubblicistica del tempo attribuiva qualità quasi miracolose nel preservare il corpo
dalle «malattie cutanee» e nell' accrescere le «capacità intellettive»19. A giudicare dai
numerosi casi di annegamenti che puntualmente si verificavano nella stagione estiva,
sembrerebbe tuttavia che i torinesi non avessero troppa dimestichezza con questo
sport.
li
Comune, da parte sua, allestì nel 1849 un servizio di sorveglianza diurna e
notturna sul Po per il periodo compreso tra il
1
0
giugno e il
31
agosto, affidandolo a
14
Statuto della società piemontese delle corse di cavalli
e
Regolamento per le corse di cavalli dell'anno 1840,
Torino,
Mussano, 1840; SERGIO GIUNTINI,
Da Torino a Firenze: gli
sport dei Piemontesi nella nuova capitale del Regno,
in
«Studi PiemontesD>, marzo 1997, voI XXVI, fase. 1, p. 122.
15
D.
BERTOLOTTI,
op. cit. ,
p. 220.
16
«Gazzetta Piemontese», 18 aprile 1842, n. 86.
80
17
<<Messaggiere Torinese», 12 dicembre 1846, n. 50.
18
ARCHIVIO STORICO
DELLA
CITTA
DI
TORINO (d'ora
in
poi ASCT),
Carte sciolte,
n. 1143. Manifesto rdativo
ai
giochi popolari dd 22 aprile 1842, n. 1139. Regolamenti
per le regate sul Po, le corse a piedi e nei sacchi.
19
A.
CORTI,
Ginnastica. Utilità dell'arte del nuoto,
in
«Letture popolari», 22 luglio 1837, n. 30.


















