
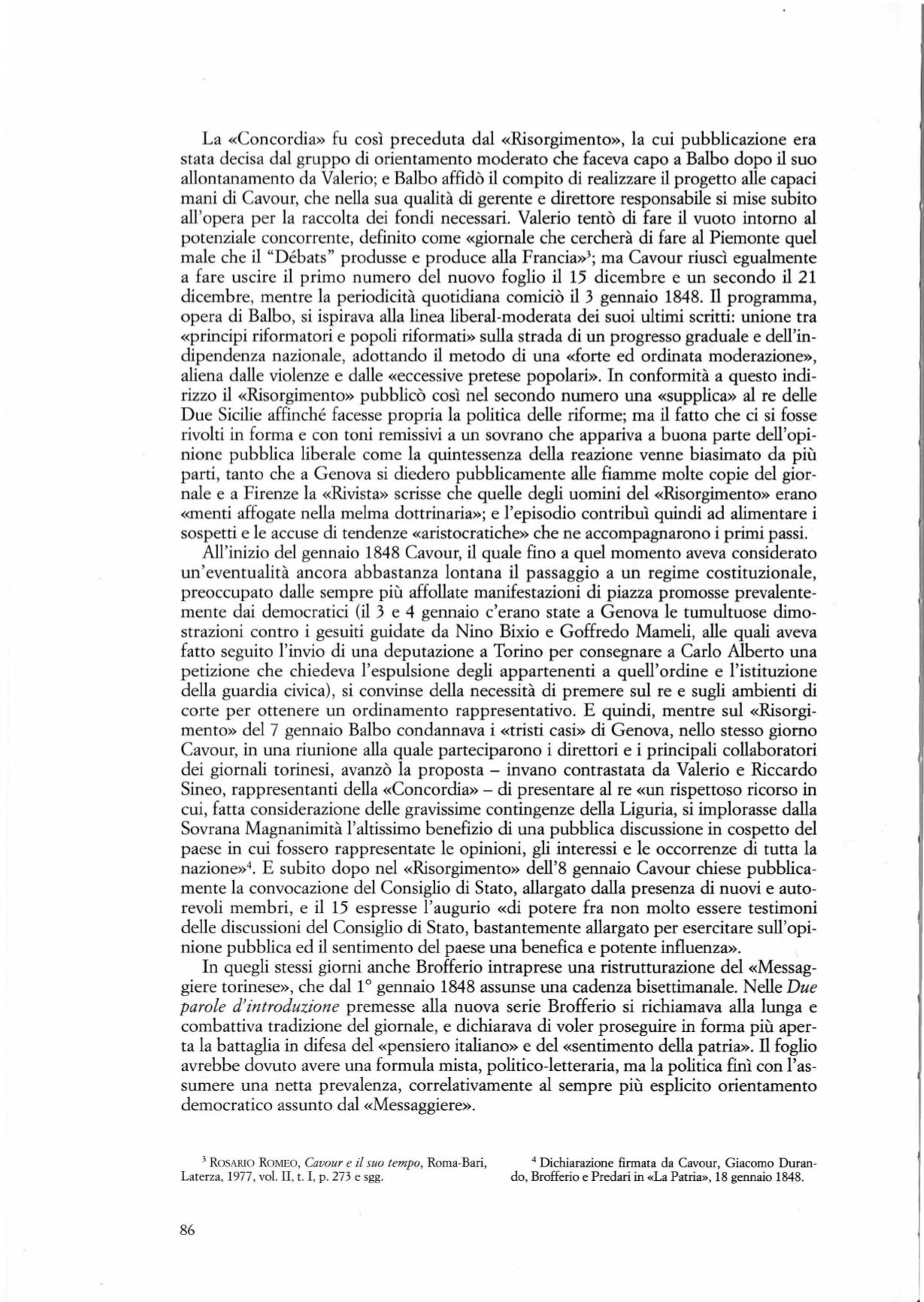
La «Concordia» fu così preceduta dal «Risorgimento», la cui pubblicazione era
stata decisa dal gruppo di orientamento moderato che faceva capo a Balbo dopo il suo
allontanamento da Valerio; e Balbo affidò il compito di realizzare il progetto alle capaci
mani di Cavour, che nella sua qualità di gerente e direttore responsabile si mise subito
all'opera per la raccolta dei fondi necessari. Valerio tentò di fare il vuoto intorno al
potenziale concorrente, definito come «giornale che cercherà di fare al Piemonte quel
male che il "Débats" produsse e produce alla Francia»3; ma Cavour riuscì egualmente
a fare uscire
il
primo numero del nuovo foglio il 15 dicembre e un secondo il 21
dicembre, mentre la periodicità quotidiana comiciò il 3 gennaio 1848.
il
programma,
opera di Balbo, si ispirava alla linea liberaI-moderata dei suoi ultimi scritti: unione tra
«principi riformatori e popoli riformati» sulla strada di un progresso graduale e dell'in–
dipendenza nazionale, adottando il metodo di una «forte ed ordinata moderazione»,
aliena dalle violenze e dalle «eccessive pretese popolari». In conformità a questo indi–
rizzo il «Risorgimento» pubblicò così nel secondo numero una «supplica» al re delle
Due Sicilie affinché facesse propria la politica delle riforme; ma il fatto che ci si fosse
rivolti in forma e con toni remissivi a un sovrano che appariva a buona parte dell'opi–
nione pubblica liberale come la quintessenza della reazione venne biasimato da più
parti, tanto che a Genova si diedero pubblicamente alle fiamme molte copie del gior–
nale e a Firenze la «Rivista» scrisse che quelle degli uomini del «Risorgimento» erano
«menti affogate nella melma dottrinaria»; e l'episodio contribuì quindi ad alimentare i
sospetti e le accuse di tendenze «aristocratiche» che ne accompagnarono i primi passi.
All'inizio del gennaio 1848 Cavour,
il
quale fino a quel momento aveva considerato
un'eventualità ancora abbastanza lontana il passaggio a un regime costituzionale,
preoccupato dalle sempre più affollate manifestazioni di piazza promosse prevalente–
mente dai democratici
(il
3 e 4 gennaio c'erano state a Genova le tumultuose dimo–
strazioni contro i gesuiti guidate da Nino Bixio e Goffredo Mameli, alle quali aveva
fatto seguito l'invio di una deputazione a Torino per consegnare a Carlo Alberto una
petizione che chiedeva l'espulsione degli appartenenti a quell' ordine e l'istituzione
della guardia civica), si convinse della necessità di premere sul re e sugli ambienti di
corte per ottenere un ordinamento rappresentativo. E quindi, mentre sul «Risorgi–
mento» del
7
gennaio Balbo condannava i «tristi casi» di Genova, nello stesso giorno
Cavour, in una riunione alla quale parteciparono i direttori e i principali collaboratori
dei giornali torinesi, avanzò la proposta - invano contrastata da Valerio e Riccardo
Sineo, rappresentanti della «Concordia» - di presentare al re «un rispettoso ricorso in
cui, fatta considerazione delle gravissime contingenze della Liguria, si implorasse dalla
Sovrana Magnanimità 1'altissimo benefizio di una pubblica discussione in cospetto del
paese in cui fossero rappresentate le opinioni, gli interessi e le occorrenze di tutta la
nazione»4. E subito dopo nel «Risorgimento» dell'8 gennaio Cavour chiese pubblica–
mente la convocazione del Consiglio di Stato, allargato dalla presenza di nuovi e auto–
revoli membri, e
il
15 espresse 1'augurio «di potere fra non molto essere testimoni
delle discussioni del Consiglio di Stato, bastantemente allargato per esercitare sull'opi–
nione pubblica ed
il
sentimento del paese una benefica e potente influenza».
In quegli stessi giorni anche Brofferio intraprese una ristrutturazione del «Messag–
giere torinese», che dalI
o
gennaio 1848 assunse una cadenza bisettimanale. Nelle
Due
parole d'introduzione
premesse alla nuova serie Brofferio si richiamava alla lunga e
combattiva tradizione del giornale, e dichiarava di voler proseguire in forma più aper–
ta la battaglia in difesa del «pensiero italiano» e del «sentimento della patria».
il
foglio
avrebbe dovuto avere una formula mista, politico-letteraria, ma la politica finì con 1'as–
sumere una netta prevalenza, correlativamente al sempre più esplicito orientamento
democratico assunto dal «Messaggiere».
) RosARIo ROMEo,
Cavour e
il
suo tempo,
Roma-Bari,
4
Dichiarazione firmata da Cavour, Giacomo Duran-
Laterza, 1977, voI. II, t. I, p. 273 e sgg.
do, Brofferio e Predari in «La Patria», 18 gennaio 1848.
86


















