
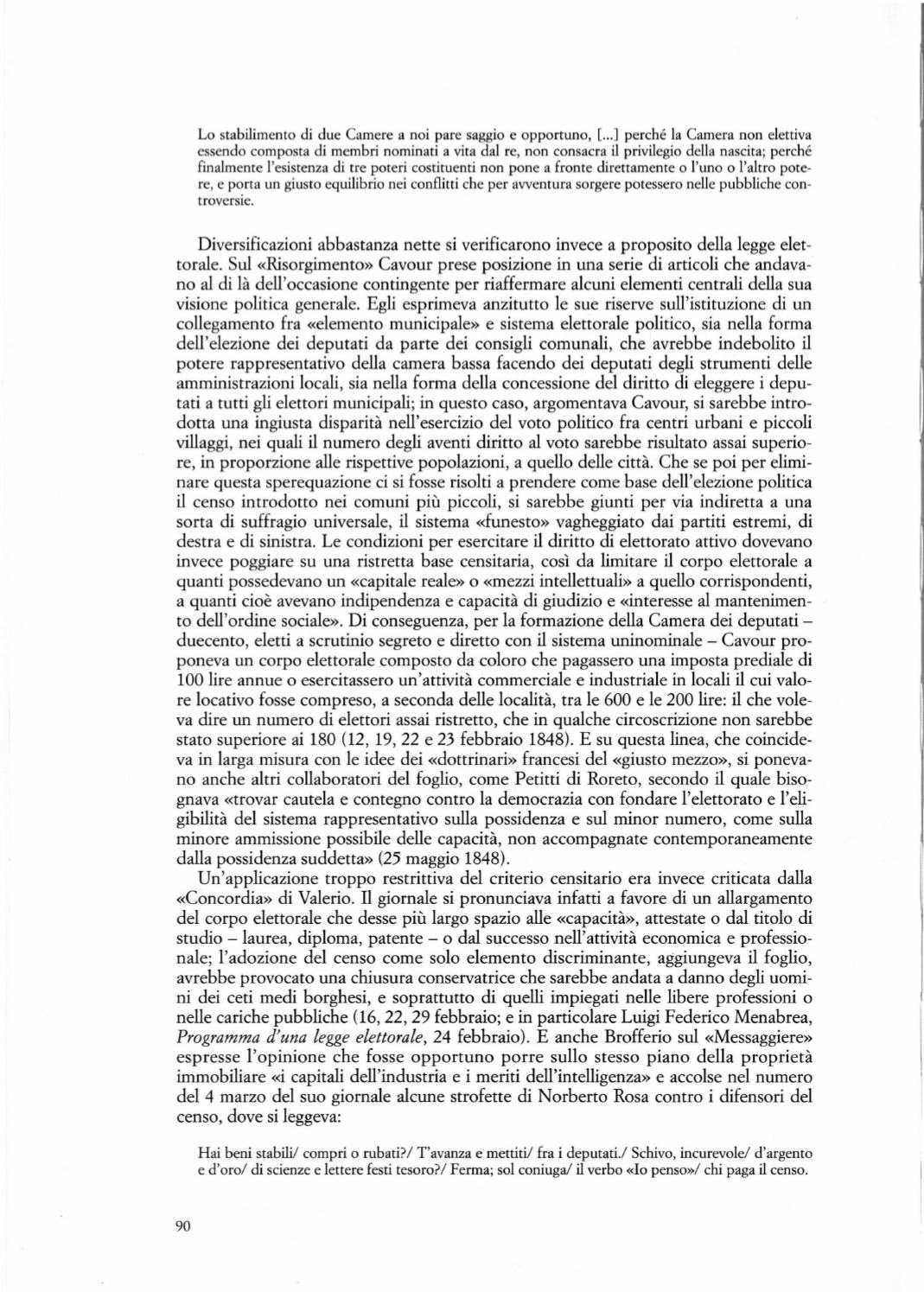
Lo stabilimento di due Camere a noi pare saggio e opportuno, [. ..] perché la Camera non elettiva
essendo composta di membri nominati a vita dal re, non consacra il privilegio della nascita; perché
finalmente l'esistenza di tre poteri costituenti non pone a fronte direttamente o l'uno o l'altro pote–
re, e porta un giusto equilibrio nei conflitti che per avventura sorgere potessero nelle pubbliche con–
troversie.
Diversificazioni abbastanza nette si verificarono invece a proposito della legge elet–
torale. Sul «Risorgimento» Cavour prese posizione in una serie di articoli che andava–
no al di là dell'occasione contingente per riaffermare alcuni elementi centrali della sua
visione politica generale. Egli esprimeva anzitutto le sue riserve sull'istituzione di un
collegamento fra «elemento municipale» e sistema elettorale politico, sia nella forma
dell' elezione dei deputati da parte dei consigli comunali, che avrebbe indebolito il
potere rappresentativo della camera bassa facendo dei deputati degli strumenti delle
amministrazioni locali, sia nella forma della concessione del diritto di eleggere i depu–
tati a tutti gli elettori municipali; in questo caso, argomentava Cavour, si sarebbe intro–
dotta una ingiusta disparità nell'esercizio del voto politico fra centri urbani e piccoli
villaggi, nei quali il numero degli aventi diritto al voto sarebbe risultato assai superio–
re, in proporzione alle rispettive popolazioni, a quello delle città. Che se poi per elimi–
nare questa sperequazione ci si fosse risolti a prendere come base dell'elezione politica
il censo introdotto nei comuni più piccoli, si sarebbe giunti per via indiretta a una
sorta di suffragio universale, il sistema «funesto» vagheggiato dai partiti estremi, di
destra e di sinistra. Le condizioni per esercitare il diritto di elettorato attivo dovevano
invece poggiare su una ristretta base censitaria, così da limitare il corpo elettorale a
quanti possedevano un «capitale reale» o «mezzi intellettuali» a quello corrispondenti,
a quanti cioè avevano indipendenza e capacità di giudizio e «interesse al mantenimen–
to dell'ordine sociale». Di conseguenza, per la formazione della Camera dei deputati -
duecento, eletti a scrutinio segreto e diretto con il sistema uninominale - Cavour pro–
poneva un corpo elettorale composto da coloro che pagassero una imposta prediale di
100 lire annue o esercitassero un' attività commerciale e industriale in locali il cui valo–
re locativo fosse compreso, a seconda delle località, tra le 600 e le 200 lire: il che vole–
va dire un numero di elettori assai ristretto, che in qualche circoscrizione non sarebbe
stato superiore ai 180 (12, 19, 22 e 23 febbraio 1848). E su questa linea, che coincide–
va in larga misura con le idee dei «dottrinari» francesi del «giusto mezzo», si poneva–
no anche altri collaboratori del foglio, come Petitti
di
Roreto, secondo il quale biso–
gnava «trovar cautela e contegno contro la democrazia con fondare l'elettorato e l'eli–
gibilità del sistema rappresentativo sulla possidenza e sul minor numero, come sulla
minore ammissione possibile delle capacità, non accompagnate contemporaneamente
dalla possidenza suddetta» (25 maggio 1848).
Un' applicazione troppo restrittiva del criterio censitario era invece criticata dalla
«Concordia» di Valerio. TI giornale si pronunciava infatti a favore di un allargamento
del corpo elettorale che desse più largo spazio alle «capacità», attestate o dal titolo di
studio - laurea, diploma, patente - o dal successo nell' attività economica e professio–
nale; l'adozione del censo come solo elemento discriminante, aggiungeva il foglio,
avrebbe provocato una chiusura conservatrice che sarebbe andata a danno degli uomi–
ni dei ceti medi borghesi, e soprattutto
di
quelli impiegati nelle libere professioni o
nelle cariche pubbliche (16,22,29 febbraio; e in particolare Luigi Federico Menabrea,
Programma d'una legge elettorale,
24 febbraio). E anche Brofferio sul «Messaggiere»
espresse l'opinione che fosse opportuno porre sullo stesso piano della proprietà
immobiliare «i capitali dell'industria e i meriti dell'intelligenza» e accolse nel numero
del 4 marzo del suo giornale alcune strofette di Norberto Rosa contro i difensori del
censo, dove si leggeva:
90
Hai beni stabili! compri o rubati?/ T'avanza e mettiti! fra i deputati.! Schivo, incurevole/ d'argento
e d'oro/ di scienze e lettere festi tesoro?/ Ferma; sol coniugai il verbo «lo penso»/ chi paga il censo.


















