
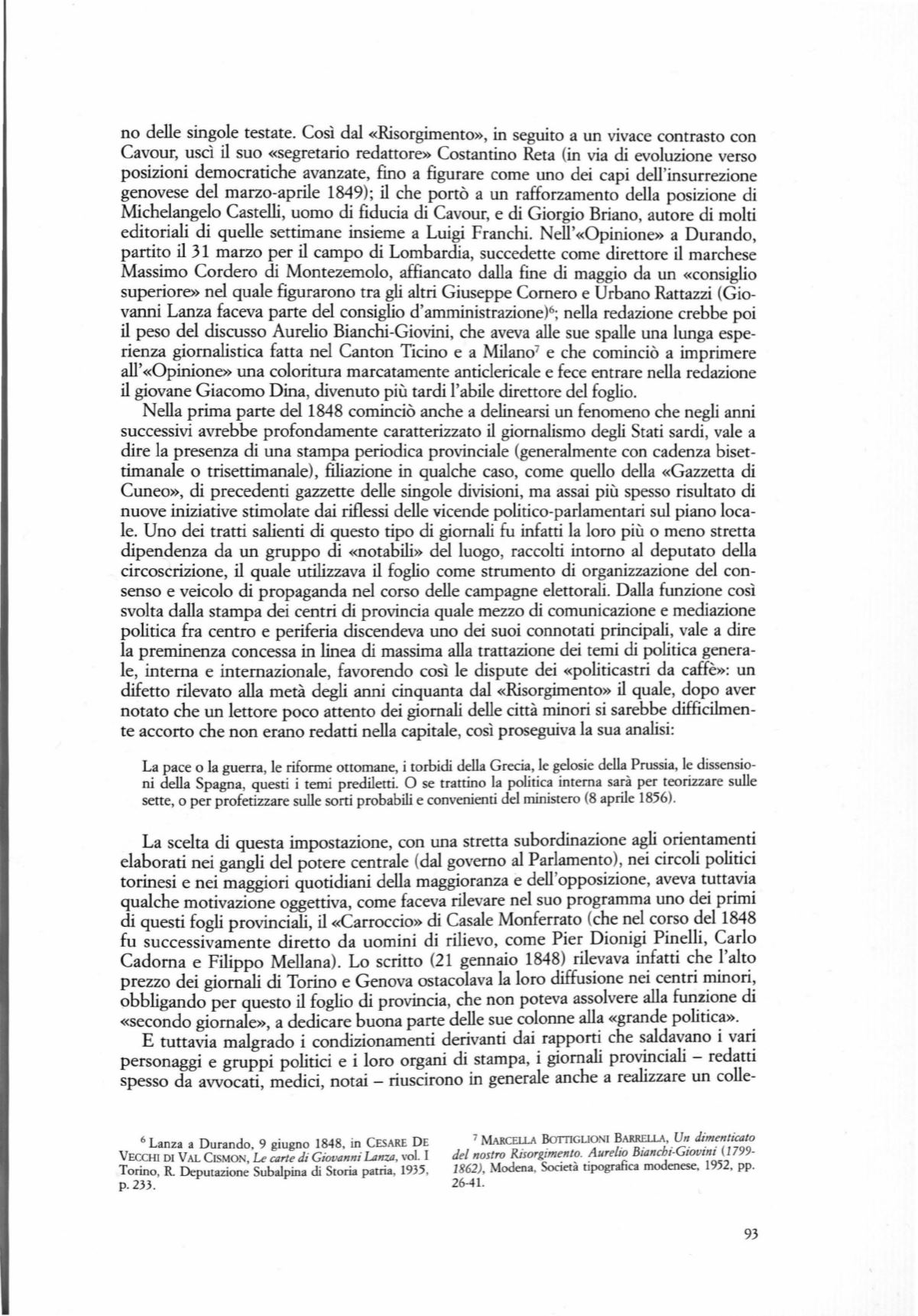
no delle singole testate. Così dal «Risorgimento», in seguito a un vivace contrasto con
Cavour, uscì il suo «segretario redattore» Costantino Reta (in via di evoluzione verso
posizioni democratiche avanzate, fino a figurare come uno dei capi dell 'insurrezione
genovese del marzo-aprile 1849); il che portò a un rafforzamento della posizione di
Michelangelo Castelli, uomo di fiducia di Cavour, e di Giorgio Briano, autore di molti
editoriali di quelle settimane insieme a Luigi Franchi. Nell'«Opinione» a Durando,
partito il 31 marzo per il campo di Lombardia, succedette come direttore il marchese
Massimo Cordero di Montezemolo, affiancato dalla fine di maggio da un «consiglio
superiore» nel quale figurarono tra gli altri Giuseppe Cornero e Urbano Rattazzi (Gio–
vanni Lanza faceva parte del consiglio d'amministrazione)6; nella redazione crebbe poi
il peso del discusso Aurelio Bianchi-Giovini, che aveva alle sue spalle una lunga espe–
rienza giornalistica fatta nel Canton Ticino e a Milan0
7
e che cominciò a imprimere
all'«Opinione» una coloritura marcatamente anticlericale e fece entrare nella redazione
il giovane Giacomo Dina, divenuto più tardi l'abile direttore del foglio.
Nella prima parte del 1848 cominciò anche a delinearsi un fenomeno che negli anni
successivi avrebbe profondamente caratterizzato
il
giornalismo degli Stati sardi, vale a
dire la presenza di una stampa periodica provinciale (generalmente con cadenza biset–
timanale o trisettimanale), filiazione in qualche caso, come quello della «Gazzetta di
Cuneo», di precedenti gazzette delle singole divisioni, ma assai più spesso risultato di
nuove iniziative stimolate dai riflessi delle vicende politico-parlamentari sul piano loca–
le. Uno dei tratti salienti di questo tipo di giornali fu infatti
la
loro più o meno stretta
dipendenza da un gruppo di «notabili» del luogo, raccolti intorno al deputato della
circoscrizione, il quale utilizzava il foglio come strumento di organizzazione del con–
senso e veicolo di propaganda nel corso delle campagne elettorali. Dalla funzione così
svolta dalla stampa dei centri di provincia quale mezzo di comunicazione e mediazione
politica fra centro e periferia discendeva uno dei suoi connotati principali, vale a dire
la preminenza concessa in linea di massima alla trattazione dei temi di politica genera–
le, interna e internazionale, favorendo così le dispute dei «politicastri da caffè»: un
difetto rilevato alla metà degli anni cinquanta dal «Risorgimento» il quale, dopo aver
notato che un lettore poco attento dei giornali delle città minori si sarebbe difficilmen–
te accorto che non erano redatti nella capitale, così proseguiva la sua analisi:
La pace o la guerra, le riforme ottomane, i torbidi della Grecia, le gelosie della Prussia, le dissensio–
ni della Spagna, questi i temi prediletti. O se trattino la politica interna sarà per teorizzare sulle
sette, o per profetizzare sulle sorti probabili e convenienti del ministero (8 aprile 1856).
La scelta di questa impostazione, con una stretta subordinazione agli orientamenti
elaborati nei gangli del potere centrale (dal governo al Parlamento), nei circoli politici
torinesi e nei maggiori quotidiani della maggioranza
e
dell'opposizione, aveva tuttavia
qualche motivazione oggettiva, come faceva rilevare nel suo programma uno dei primi
di questi fogli provinciali, il «Carroccio» di Casale Monferrato (che nel corso del 1848
fu successivamente diretto da uomini di rilievo, come Pier Dionigi Pinelli, Carlo
Cadorna e Filippo Mellana). Lo scritto (21 gennaio
1848~ ril~vava ~fatti c~e
!'alt?
prezzo dei giornali di Torino e Genova ostacolava la loro diffUSiOne nel centrI
r.nmorI~
obbligando per questo il foglio di provincia, che non poteva assolvere alla
fun.z~one
dI
«secondo giornale», a dedicare buona parte delle sue colonne alla «grande politica».
E tuttavia malgrado i condizionamenti derivanti dai .
ra?port~
che
~al~av.ano
i
var~
personaggi e gruppi politici e i loro organi di stampa, l gIornali
pro~Clali
- redatti
spesso da avvocati, medici, notai - riuscirono in generale anche a realizzare un colle-
6
Lanza a Durando, 9 giugno 1848, in
CESARE
DE
VECCHI DI VAL CISMON,
Le carte di Giovanni Lanza,
voI.
I
Torino,
R.
Deputazione Subalpina
di
Storia patria, 1935,
p.233.
7
MARCELLA BOITIGLIONI BARRELLA,
Un dimenticato
del nostro Risorgimento. Aurelio Bianchi-Giovini (1799-
1862), Modena, Società tipografica modenese, 1952, pp.
26-41.
93


















