
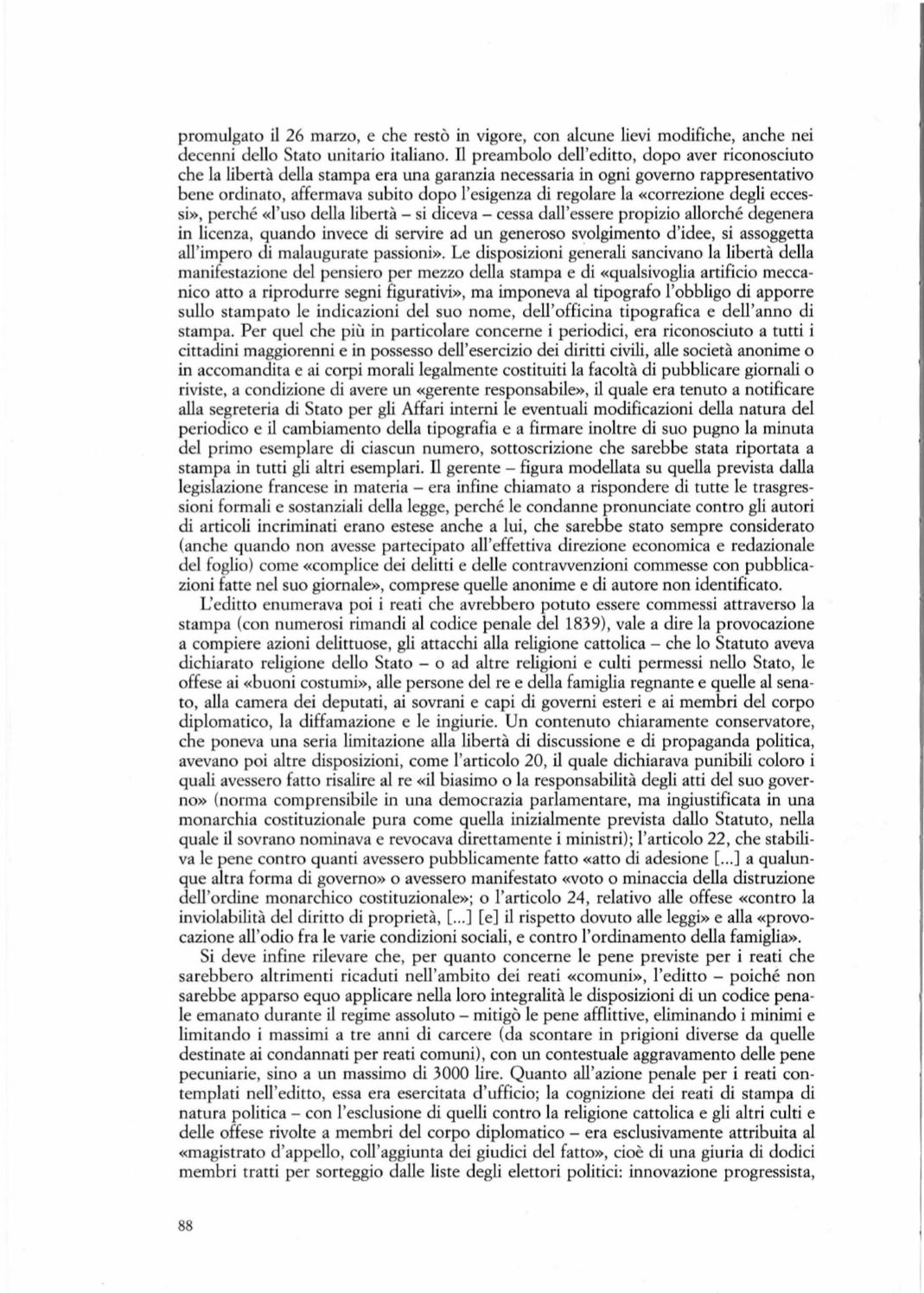
promulgato il 26 marzo, e che restò in vigore, con alcune lievi modifiche, anche nei
decenni dello Stato unitario italiano. Il preambolo dell'editto, dopo aver riconosciuto
che la libertà della stampa era una garanzia necessaria in ogni governo rappresentativo
bene ordinato, affermava subito dopo l'esigenza di regolare
la
«correzione degli ecces–
si», perché «l'uso della libertà - si diceva - cessa dall'essere propizio allorché degenera
in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta
all'impero di malaugurate passioni». Le disposizioni generali sancivano la libertà della
manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di «qualsivoglia artificio mecca–
nico atto a riprodurre segni figurativi», ma imponeva al tipografo l'obbligo di apporre
sullo stampato le indicazioni del suo nome, dell'officina tipografica e dell 'anno di
stampa. Per quel che più in particolare concerne i periodici, era riconosciuto a tutti i
cittadini maggiorenni e in possesso dell'esercizio dei diritti civili, alle società anonime o
in accomandita e ai corpi morali legalmente costituiti la facoltà di pubblicare giornali o
riviste, a condizione di avere un «gerente responsabile», il quale era tenuto a notificare
alla segreteria di Stato per gli Affari interni le eventuali modificazioni della natura del
periodico e il cambiamento della tipografia e a firmare inoltre di suo pugno la minuta
del primo esemplare di ciascun numero, sottoscrizione che sarebbe stata riportata a
stampa in tutti gli altri esemplari. Il gerente - figura modellata su quella prevista dalla
legislazione francese in materia - era infine chiamato a rispondere di tutte le trasgres–
sioni formali e sostanziali della legge, perché le condanne pronunciate contro gli autori
di articoli incriminati erano estese anche a lui, che sarebbe stato sempre considerato
(anche quando non avesse partecipato all'effettiva direzione economica e redazionale
del foglio) come «complice dei delitti e delle contravvenzioni commesse con pubblica–
zioni fatte nel suo giornale», comprese quelle anonime e di autore non identificato.
L'editto enumerava poi i reati che avrebbero potuto essere commessi attraverso la
stampa (con numerosi rimandi al codice penale del 1839), vale a dire la provocazione
a compiere azioni delittuose, gli attacchi alla religione cattolica - che lo Statuto aveva
dichiarato religione dello Stato - o ad altre religioni e culti permessi nello Stato, le
offese ai «buoni costumi», alle persone del re e della famiglia regnante e quelle al sena–
to, alla camera dei deputati, ai sovrani e capi di governi esteri e ai membri del corpo
diplomatico, la diffamazione e le ingiurie. Un contenuto chiaramente conservatore,
che poneva una seria limitazione alla libertà di discussione e di propaganda politica,
avevano poi altre disposizioni, come l'articolo 20, il quale dichiarava punibili coloro i
quali avessero fatto risalire al re «il biasimo o la responsabilità degli atti del suo gover–
no» (norma comprensibile in una democrazia parlamentare, ma ingiustificata in una
monarchia costituzionale pura come quella inizialmente prevista dallo Statuto, nella
quale il sovrano nominava e revocava direttamente i ministri); l'articolo 22 , che stabili–
va le pene contro quanti avessero pubblicamente fatto «atto di adesione [... ] a qualun–
que altra forma di governo» o avessero manifestato «voto o minaccia della distruzione
dell 'ordine monarchico costituzionale»; o l'articolo 24 , relativo alle offese «contro la
inviolabilità del diritto di proprietà, [... ] [e] il rispetto dovuto alle leggi» e alla «provo–
cazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia».
Si deve infine rilevare che, per quanto concerne le pene previste per i reati che
sarebbero altrimenti ricaduti nell'ambito dei reati «comuni», l'editto - poiché non
sarebbe apparso equo applicare nella loro integralità le disposizioni di un codice pena–
le emanato durante il regime assoluto - mitigò le pene afflittive, eliminando i minimi e
limitando i massimi a tre anni di carcere (da scontare in prigioni diverse da quelle
destinate ai condannati per reati comuni), con un contestuale aggravamento delle pene
pecuniarie, sino a un massimo di 3000 lire. Quanto all'azione penale per i reati con–
templati nell' editto, essa era esercitata d 'ufficio; la cognizione dei reati di stampa
di
natura politica - con l'esclusione di quelli contro la religione cattolica e gli altri culti e
delle offese rivolte a membri del corpo diplomatico - era esclusivamente attribuita al
«magistrato d'appello, coll'aggiunta dei giudici del fatto», cioè di una giuria di dodici
membri tratti per sorteggio dalle liste degli elettori politici: innovazione progressista,
88


















