
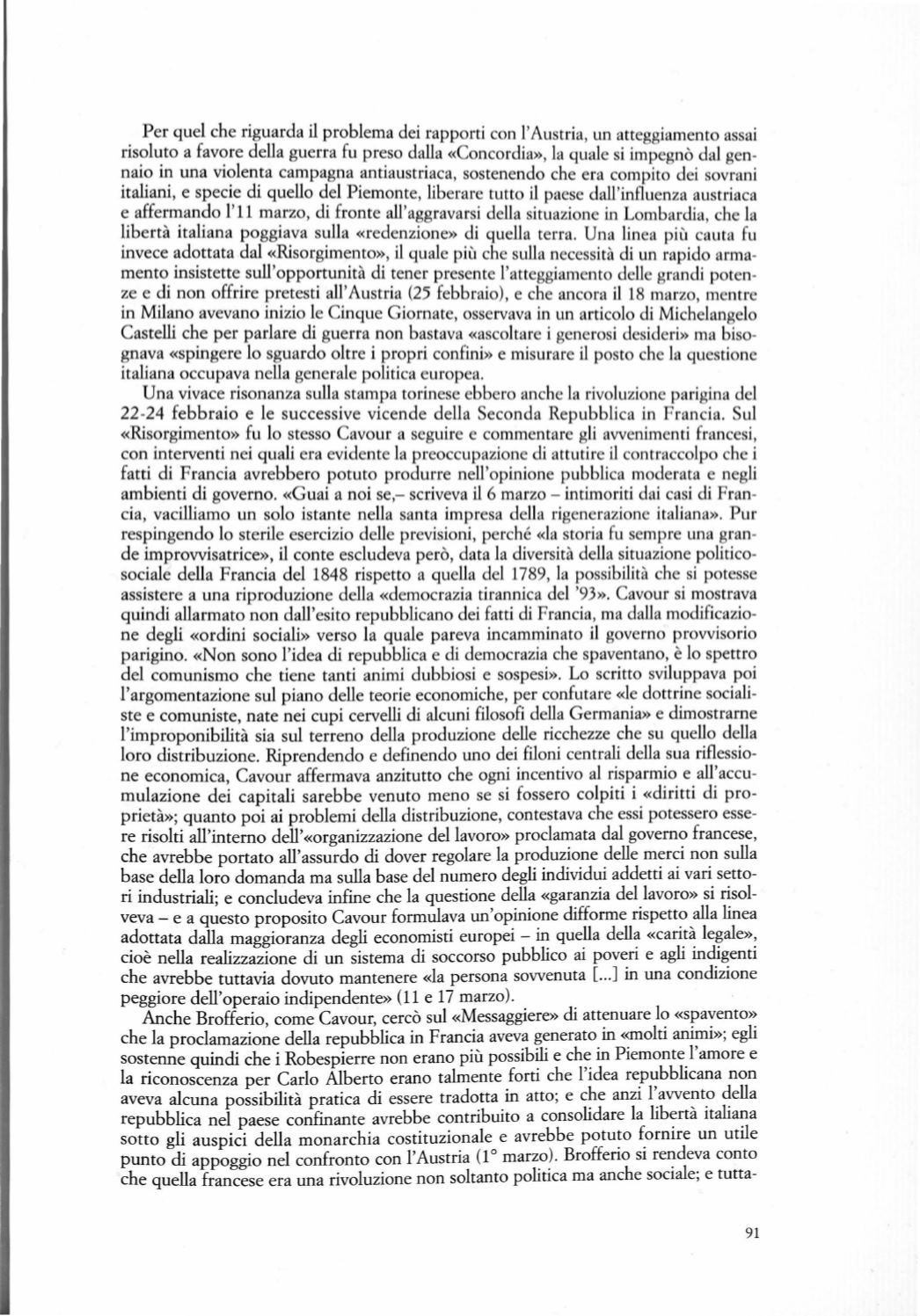
· Per quel che riguarda il problema dei rapporti con l'Austria, un atteggiamento assai
ns?l~to
a
fav~re
della guerra fu
pr~so da~a
«Concordia», la quale si impegnò dal gen–
naIO
In
una vIolenta campagna antlaustnaca, sostenendo che era compito dei sovrani
italiani, e specie di quello del Piemonte, liberare tutto il paese dall'influenza austriaca
e affermando
1'11
marzo, di fronte all'aggravarsi della situazione in Lombardia, che la
libertà italiana poggiava sulla «redenzione» di quella terra. Una linea più cauta fu
invece adottata dal «Risorgimento», il quale più che sulla necessità di un rapido arma–
mento insistette sull'opportunità di tener presente l'atteggiamento delle grandi poten–
ze e di non offrire pretesti all'Austria (25 febbraio), e che ancora il 18 marzo, mentre
in Milano avevano inizio le Cinque Giornate, osservava in un articolo di Michelangelo
Castelli che per parlare di guerra non bastava «ascoltare i generosi desideri» ma biso–
gnava «spingere lo sguardo oltre i propri confini» e misurare il posto che la questione
italiana occupava nella generale politica europea.
Una vivace risonanza sulla stampa torinese ebbero anche la rivoluzione parigina del
22-24 febbraio e le successive vicende della Seconda Repubblica in Francia. Sul
«Risorgimento» fu lo stesso Cavour a seguire e commentare gli avvenimenti francesi,
con interventi nei quali era evidente la preoccupazione di attutire il contraccolpo che i
fatti di Francia avrebbero potuto produrre nell'opinione pubblica moderata e negli
ambienti di governo. «Guai a noi se,- scriveva il6 marzo - intimoriti dai casi di Fran–
cia, vacilliamo un solo istante nella santa impresa della rigenerazione italiana». Pur
respingendo lo sterile esercizio delle previsioni, perché «la storia fu sempre una gran–
de improvvisatrice», il conte escludeva però, data la diversità della situazione politico–
sociale della Francia del 1848 rispetto a quella del 1789, la possibilità che si potesse
assistere a una riproduzione della «democrazia tirannica del '93». Cavour si mostrava
quindi allarmato non dall'esito repubblicano dei fatti di Francia, ma dalla modificazio–
ne degli «ordini sociali» verso la quale pareva incamminato il governo provvisorio
parigino. «Non sono l'idea di repubblica e di democrazia che spaventano, è lo spettro
del comunismo che tiene tanti animi dubbiosi e sospesi». Lo scritto sviluppava poi
l'argomentazione sul piano delle teorie economiche, per confutare «le dottrine sociali–
ste e comuniste, nate nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania» e dimostrarne
l'improponibilità sia sul terreno della produzione delle ricchezze che su quello della
loro distribuzione. Riprendendo e definendo uno dei filoni centrali della sua riflessio–
ne economica, Cavour affermava anzitutto che ogni incentivo al risparmio e all'accu–
mulazione dei capitali sarebbe venuto meno se si fossero colpiti i «diritti di pro–
prietà»; quanto poi ai problemi della distribuzione, contestava che essi potessero esse–
re risolti all'interno dell'«organizzazione del lavoro» proclamata dal governo francese,
che avrebbe portato all'assurdo di dover regolare la produzione delle merci non sulla
base della loro domanda ma sulla base del numero degli individui addetti ai vari setto–
ri industriali; e concludeva infine che la questione della «garanzia del lavoro» si risol–
veva - e a questo proposito Cavour formulava un'opinione difforme rispetto alla linea
adottata dalla maggioranza degli economisti europei - in quella della «carità legale»,
cioè nella realizzazione di un sistema di soccorso pubblico ai poveri e agli indigenti
che avrebbe tuttavia dovuto mantenere «la persona sovvenuta [. .. ] in una condizione
peggiore dell'operaio indipendente» (11 e 17 marzo).
Anche Brofferio, come Cavour, cercò sul «Messaggiere» di attenuare lo «spavento»
che la proclamazione della repubblica in Francia aveva generato in «molti animi»; egli
sostenne quindi che i Robespierre non erano più possibili e che in Piemonte l'amore e
la riconoscenza per Carlo Alberto erano talmente forti che l'idea repubblicana non
aveva alcuna possibilità pratica di essere tradotta in atto; e c?e anzi l'.avve?t?
~ella
repubblica nel paese confinante avrebbe contribuito a consolIdare la
lib~rta
ltalia?a
sotto gli auspici della monarchia costituzionale e avrebbe
potu~o ~ornIre
un utile
punto di appoggio nel confronto con l'Austria (10
marz.oì. Broffeno SI
re~deva
conto
che quella francese era una rivoluzione non soltanto poliuca ma anche SOCIale; e tutta-
91


















