
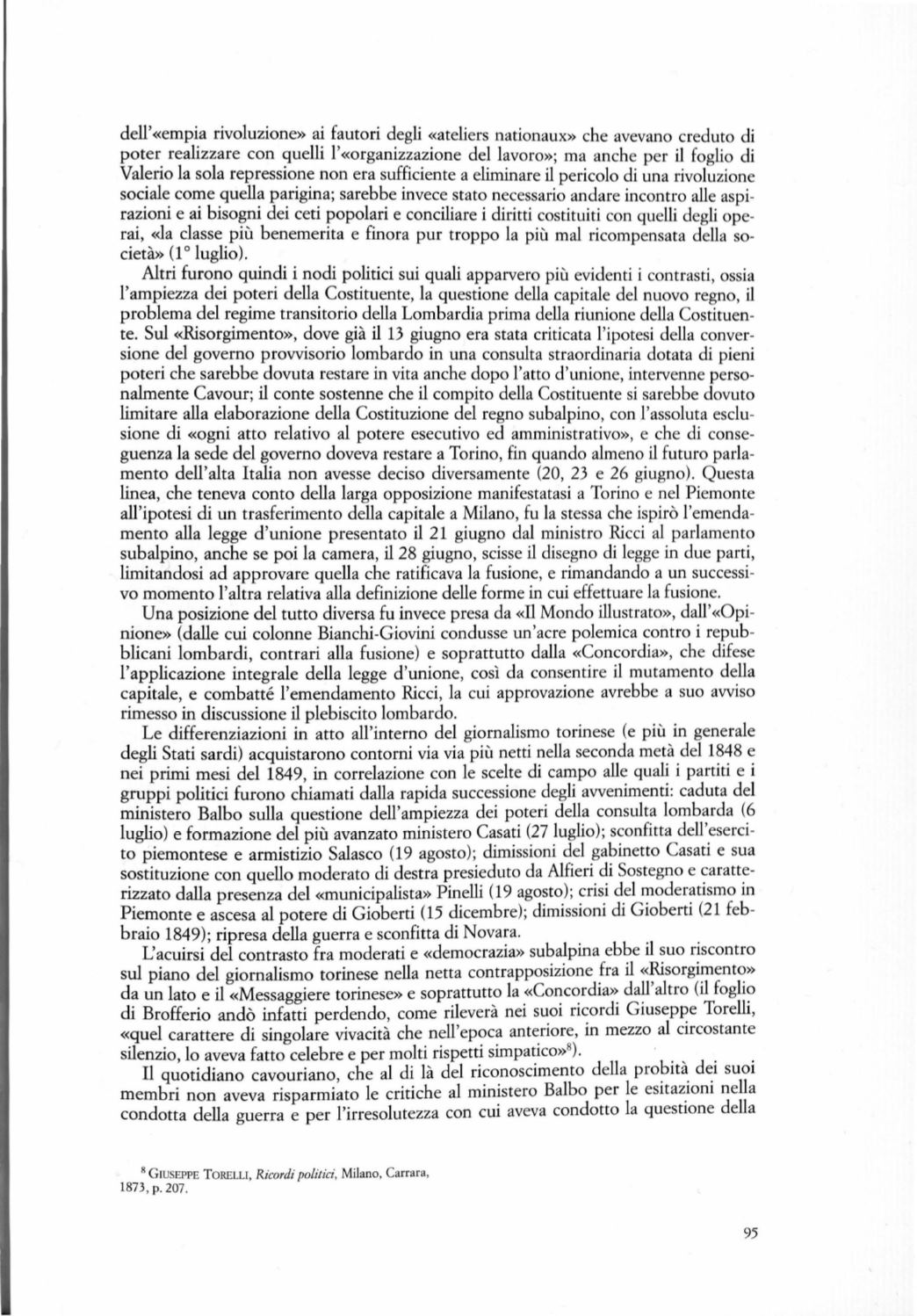
dell'«empia rivoluzione» ai fautori degli «ateliers nationaux» che avevano creduto di
poter realizzare con quelli l'«organizzazione del lavoro»; ma anche per il foglio di
Valerio la sola repressione non era sufficiente a eliminare il pericolo di una rivoluzione
sociale come quella parigina; sarebbe invece stato necessario andare incontro alle aspi–
razioni e ai bisogni dei ceti popolari e conciliare i diritti costituiti con quelli degli ope–
rai, «la classe più benemerita e finora pur troppo la più mal ricompensata della so–
cietà»
(1
0
luglio).
Altri furono quindi i nodi politici sui quali apparvero più evidenti i contrasti, ossia
l'ampiezza dei poteri della Costituente, la questione della capitale del nuovo regno, il
problema del regime transitorio della Lombardia prima della riunione della Costituen–
te. Sul «Risorgimento», dove già il 13 giugno era stata criticata l'ipotesi della conver–
sione del governo provvisorio lombardo in una consulta straordinaria dotata di pieni
poteri che sarebbe dovuta restare in vita anche dopo l'atto d'unione, intervenne perso–
nalmente Cavour; il conte sostenne che il compito della Costituente si sarebbe dovuto
limitare alla elaborazione della Costituzione del regno subalpino, con l'assoluta esclu–
sione di «ogni atto relativo al potere esecutivo ed amministrativo», e che di conse–
guenza la sede del governo doveva restare a Torino, fin quando almeno il futuro parla–
mento dell'alta Italia non avesse deciso diversamente (20, 23 e 26 giugno). Questa
linea, che teneva conto della larga opposizione manifestatasi a Torino e nel Piemonte
all'ipotesi di un trasferimento della capitale a Milano, fu la stessa che ispirò l'emenda–
mento alla legge d'unione presentato il 21 giugno dal ministro Ricci al parlamento
subalpino, anche se poi la camera, il
28
giugno, scisse il disegno di legge in due parti,
limitandosi ad approvare quella che ratificava la fusione, e rimandando a un successi–
vo momento l'altra relativa alla definizione delle forme in cui effettuare la fusione.
Una posizione del tutto diversa fu invece presa da «Il Mondo illustrato», dall'«Opi–
nione» (dalle cui colonne Bianchi-Giovini condusse un'acre polemica contro i repub–
blicani lombardi, contrari alla fusione) e soprattutto dalla «Concordia», che difese
l'applicazione integrale della legge d'unione, cosÌ da consentire il mutamento della
capitale, e combatté l'emendamento Ricci, la cui approvazione avrebbe a suo avviso
rimesso in discussione il plebiscito lombardo.
Le differenziazioni in atto all'interno del giornalismo torinese (e più in generale
degli Stati sardi) acquistarono contorni via via più netti nella seconda metà del
1848
e
nei primi mesi del
1849,
in correlazione con le scelte di campo alle quali i partiti e i
gruppi politici furono chiamati dalla rapida successione degli avvenimenti: caduta del
ministero Balbo sulla questione dell'ampiezza dei poteri della consulta lombarda (6
luglio) e formazione del più avanzato ministero Casati (27 luglio); sconfitta dell'eserci–
to piemontese e armistizio Salasco
(19
agosto); dimissioni del gabinetto Casati e sua
sostituzione con quello moderato di destra presieduto da Alfieri di Sostegno e caratte–
rizzato dalla presenza del «municipalista» Pinelli
(19
agosto) ; crisi del moderatismo in
Piemonte e ascesa al potere di Gioberti (15 dicembre); dimissioni di Gioberti (21 feb–
braio
1849);
ripresa della guerra e sconfitta di Novara.
L'acuirsi del contrasto fra moderati e «democrazia» subalpina ebbe il suo riscontro
sul piano del giornalismo torinese nella netta contrapposizione
~ra
il
«~sorg~ent~»
d~
un lato e il «Messaggiere torinese» e
sop~attutt.?
la
.«Co~c~rdla>~ da~
altro (il fogli?
dI Brofferio andò infatti perdendo, come rilevera nel
S~OI n~ordi GlUsep~e
Torelll,
«quel carattere di singolare vivacità che nell'epoca antenore, m mezzo al CIrcostante
silenzio, lo aveva fatto celebre e per molti rispetti simpatico»8).
. . ,
.
.
Il quotidiano cavouriano, che al di là del riconoscimento della pro?1ta.
d~1
SUOI
membri non aveva risparmiato le critiche al ministero Balbo per le eSItaz.10111 nella
condotta della guerra e per l'irresolutezza con cui aveva condotto la questione della
8 GIUSEPPE T ORELL!,
Ricordi politici,
Milano, Carrara,
1873 , p. 207.
95


















