
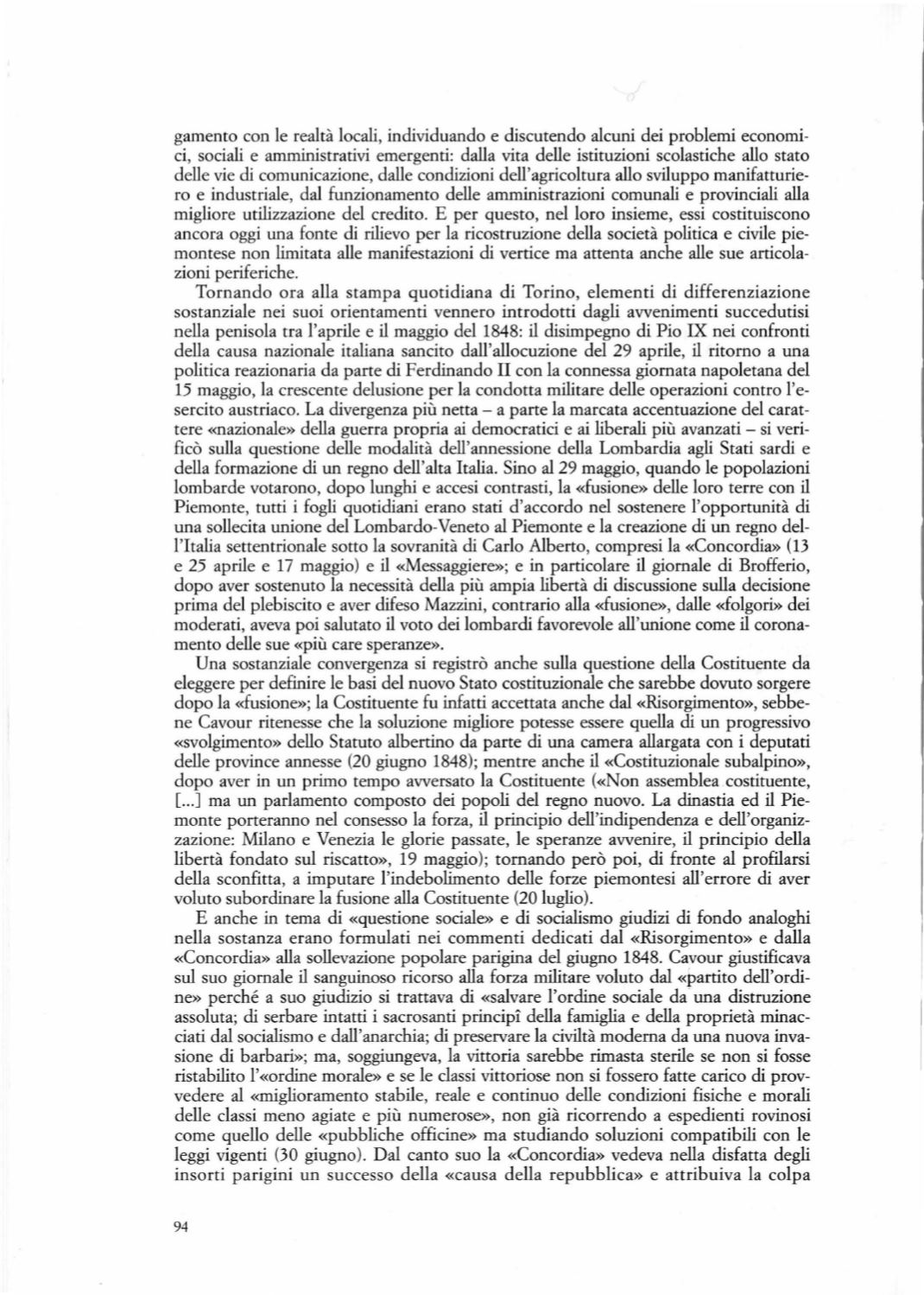
gamento con le realtà locali, individuando e discutendo alcuni dei problemi economi–
ci, sociali e amministrativi emergenti: dalla vita delle istituzioni scolastiche allo stato
delle vie di comunicazione, dalle condizioni dell'agricoltura allo sviluppo manifatturie–
ro e industriale, dal funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali alla
migliore utilizzazione del credito. E per questo, nel loro insieme, essi costituiscono
ancora oggi una fonte di rilievo per la ricostruzione della società politica e civile pie–
montese non limitata alle manifestazioni di vertice ma attenta anche alle sue articola–
zioni periferiche.
Tornando ora alla stampa quotidiana di Torino, elementi di differenziazione
sostanziale nei suoi orientamenti vennero introdotti dagli avvenimenti succedutisi
nella penisola tra l'aprile e il maggio del
1848:
il disimpegno di Pio IX nei confronti
della causa nazionale italiana sancito dall' allocuzione del 29 aprile, il ritorno a una
politica reazionaria da parte di Ferdinando II con la connessa giornata napoletana del
15
maggio, la crescente delusione per la condotta militare delle operazioni contro l'e–
sercito austriaco. La divergenza più netta - a parte la marcata accentuazione del carat–
tere «nazionale» della guerra propria ai democratici e ai liberali più avanzati - si veri–
ficò sulla questione delle modalità dell' annessione della Lombardia agli Stati sardi e
della formazione di un regno dell' alta Italia. Sino al 29 maggio, quando le popolazioni
10mbarde votarono, dopo lunghi e accesi contrasti, la «fusione» delle loro terre con il
Piemonte, tutti i fogli quotidiani erano stati d'accordo nel sostenere l'opportunità di
una sollecita unione del Lombardo-Veneto al Piemonte e la creazione di un regno del–
l'Italia settentrionale sotto la sovranità di Carlo Alberto, compresi la «Concordia» (13
e 25 aprile e
17
maggio) e il «Messaggiere»; e in particolare il giornale di Brofferio,
dopo aver sostenuto la necessità della più ampia libertà di discussione sulla decisione
prima del plebiscito e aver difeso Mazzini, contrario alla «fusione», dalle «folgori» dei
moderati, aveva poi salutato il voto dei 10mbardi favorevole all'unione come il corona–
mento delle sue «più care speranze».
Una sostanziale convergenza si registrò anche sulla questione della Costituente da
eleggere per definire le basi del nuovo Stato costituzionale che sarebbe dovuto sorgere
dopo la «fusione»; la Costituente fu infatti accettata anche dal «Risorgimento», sebbe–
ne Cavour ritenesse che la soluzione migliore potesse essere quella
di
un progressivo
«svolgimento» dello Statuto albertino da parte di una camera allargata con i deputati
delle province annesse
(20
giugno
1848);
mentre anche il «Costituzionale subalpino»,
dopo aver in un primo tempo avversato la Costituente (<<Non assemblea .costituente,
[... ] ma un parlamento composto dei popoli del regno nuovo. La dinastia ed il Pie–
monte porteranno nel consesso la forza, il principio dell'indipendenza e dell'organiz–
zazione: Milano e Venezia le glorie passate, le speranze avvenire, il principio della
libertà fondato sul riscatto», 19 maggio); tornando però poi, di fronte al profilarsi
della sconfitta, a imputare l'indebolimento delle forze piemontesi all'errore di aver
voluto subordinare la fusione alla Costituente
(20
luglio).
E anche in tema di «questione sociale» e di socialismo giudizi di fondo analoghi
nella sostanza erano formulati nei commenti dedicati dal «Risorgimento» e dalla
«Concordia» alla sollevazione popolare parigina del giugno
1848.
Cavour giustificava
sul suo giornale il sanguinoso ricorso alla forza militare voluto dal «partito dell'ordi–
ne» perché a suo giudizio si trattava di «salvare l'ordine sociale da ' una distruzione
assoluta; di serbare intatti i sacrosanti principi della famiglia e della proprietà minac–
ciati dal socialismo e dall'anarchia; di preservare la civiltà moderna da una nuova inva–
sione di barbari»; ma, soggiungeva, la vittoria sarebbe rimasta sterile se non si fosse
ristabilito l'«ordine morale» e se le classi vittoriose non si fossero fatte carico di prov–
vedere al «miglioramento stabile, reale e continuo delle condizioni fisiche e morali
delle classi meno agiate e più numerose», non già ricorrendo a espedienti rovinosi
come quello delle «pubbliche officine» ma studiando soluzioni compatibili con le
leggi vigenti
(30
giugno). Dal canto suo la «Concordia» vedeva nella disfatta degli
insorti parigini un successo della «causa della repubblica» e attribuiva la colpa
94


















