
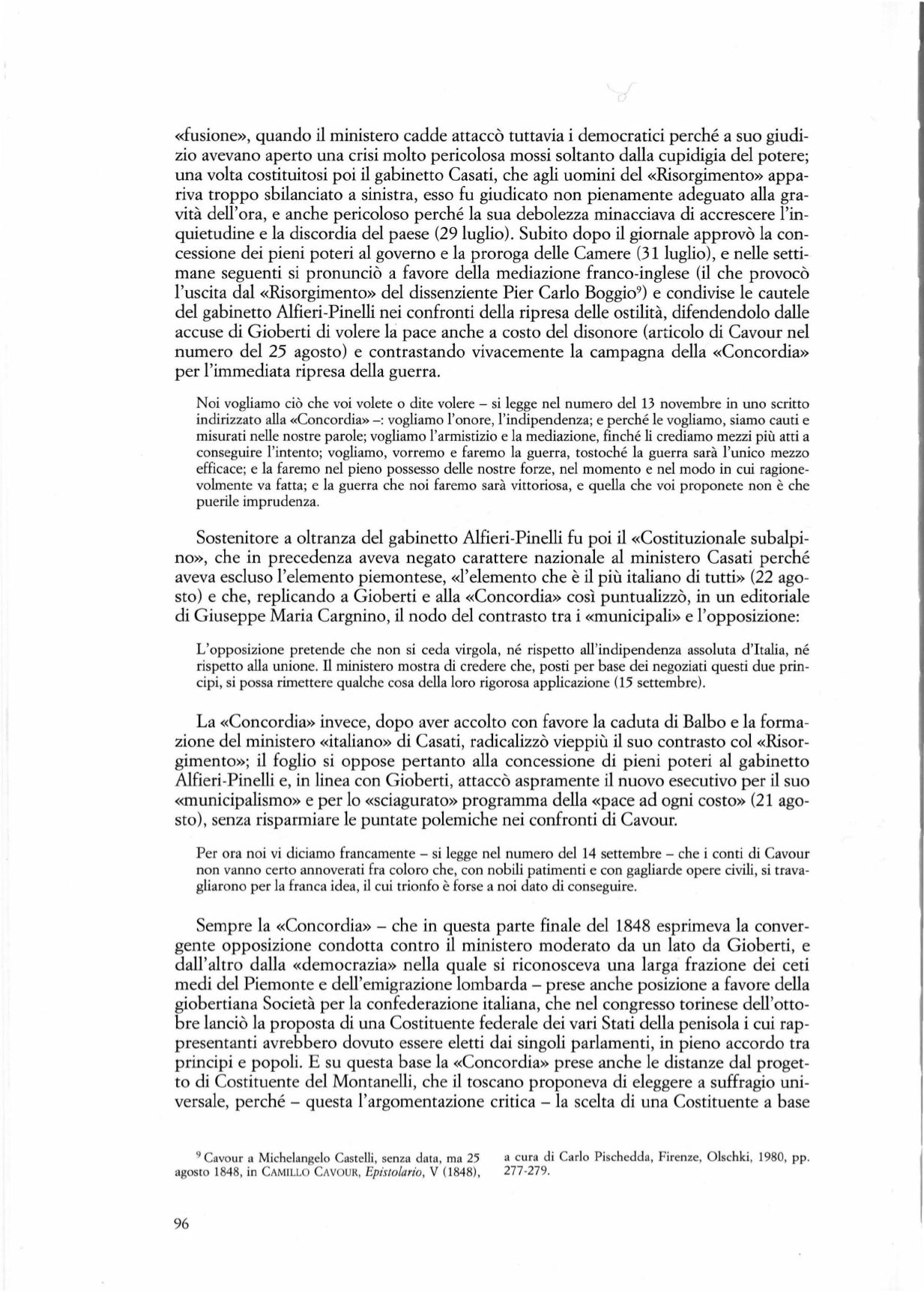
«fusione», quando il ministero cadde attaccò tuttavia i democratici perché a suo giudi–
zio avevano aperto una crisi molto pericolosa mossi soltanto dalla cupidigia del potere;
una volta costituitosi poi il gabinetto Casati, che agli uomini del «Risorgimento» appa–
riva troppo sbilanciato a sinistra, esso fu giudicato non pienamente adeguato alla gra–
vità dell'ora, e anche pericoloso perché la sua debolezza minacciava di accrescere l'in–
quietudine e la discordia del paese (29 luglio) . Subito dopo il giornale approvò la con–
cessione dei pieni poteri al governo e la proroga delle Camere (31 luglio), e nelle setti–
mane seguenti si pronunciò a favore della mediazione franco-inglese
(il
che provocò
l'uscita dal «Risorgimento» del dissenziente Pier Carlo Boggi0
9 )
e condivise le cautele
del gabinetto Alfieri-Pinelli nei confronti della ripresa delle ostilità, difendendolo dalle
accuse di Gioberti di volere
la:
pace anche a costo del disonore (articolo di Cavour nel
numero del 25 agosto) e contrastando vivacemente la campagna della «Concordia»
per l'immediata ripresa della guerra.
Noi vogliamo ciò che voi volete o dite volere - si legge nel numero del 13 novembre in uno scritto
indirizzato alla «Concordia» -: vogliamo l'onore, l'indipendenza; e perché le vogliamo, siamo cauti e
misurati nelle nostre parole; vogliamo l'armistizio e la mediazione, finché li crediamo mezzi più atti a
conseguire l'intento; vogliamo, vorremo e faremo la guerra, tostoché la guerra sarà l'unico mezzo
efficace; e la faremo nel pieno possesso delle nostre forze, nel momento e nel modo in cui ragione–
volmente va fatta ; e la guerra che noi faremo sarà vittoriosa, e quella che voi proponete non
è
che
puerile imprudenza.
Sostenitore a oltranza del gabinetto Alfieri-Pinelli fu poi il «Costituzionale subalpi–
no», che in precedenza aveva negato carattere nazionale al ministero Casati perché
aveva escluso l'elemento piemontese, «l'elemento che è il più italiano di tutti» (22 ago–
sto) e che, replicando a Gioberti e alla «Concordia» cosÌ puntualizzò, in un editoriale
di Giuseppe Maria Cargnino, il nodo del contrasto tra i «municipali» e l'opposizione:
L'opposizione pretende che non si ceda virgola, né rispetto all'indipendenza assoluta d'Italia, né
rispetto alla unione.
li
ministero mostra di credere che, posti per base dei negoziati questi due prin–
cipi, si possa rimettere qualche cosa della loro rigorosa applicazione (15 settembre).
La «Concordia» invece, dopo aver accolto con favore la caduta di Balbo e la forma–
zione del ministero «italiano» di Casati, radicalizzò vieppiù il suo contrasto col «Risor–
gimento»;
il
foglio si oppose pertanto alla concessione di pieni poteri al gabinetto
Alfieri-Pinelli e, in linea con Gioberti, attaccò aspramente il nuovo esecutivo per il suo
«municipalismo» e per lo «sciagurato» programma della «pace ad ogni costo»
(21
ago–
sto), senza risparmiare le puntate polemiche nei confronti di Cavour.
Per ora noi vi diciamo francamente - si legge nel numero del 14 settembre - che i conti di Cavour
non vanno certo annoverati fra coloro che, con nobili patimenti e con gagliarde opere civili, si trava–
gliarono per la franca idea, il cui trionfo è forse a noi dato di conseguire.
Sempre la «Concordia» - che in questa parte finale del 1848 esprimeva la conver–
gente opposizione condotta contro
il
ministero moderato da un lato da Gioberti, e
dall' altro dalla «democrazia» nella quale si riconosceva una larga frazione dei ceti
medi del Piemonte e dell'emigrazione lombarda - prese anche posizione a favore della
giobertiana Società per la confederazione italiana, che nel congresso torinese dell'otto–
bre lanciò la proposta di una Costituente federale dei vari Stati della penisola i cui rap–
presentanti avrebbero dovuto essere eletti dai singoli parlamenti, in pieno accordo tra
principi e popoli. E su questa base la «Concordia» prese anche le distanze dal proget–
to di Costituente del Montanelli, che il toscano proponeva di eleggere a suffragio uni–
versale, perché - questa l'argomentazione critica - la scelta di una Costituente a base
9
Cavour a Michelangelo Castelli, senza data, ma 25
a cura di Carlo Pischedda, Firenze, Olschki, 1980, pp.
agosto 1848,
in
CAMILLO CAVOUR,
Epistolario,
V
(1848) ,
277·279.
96


















