
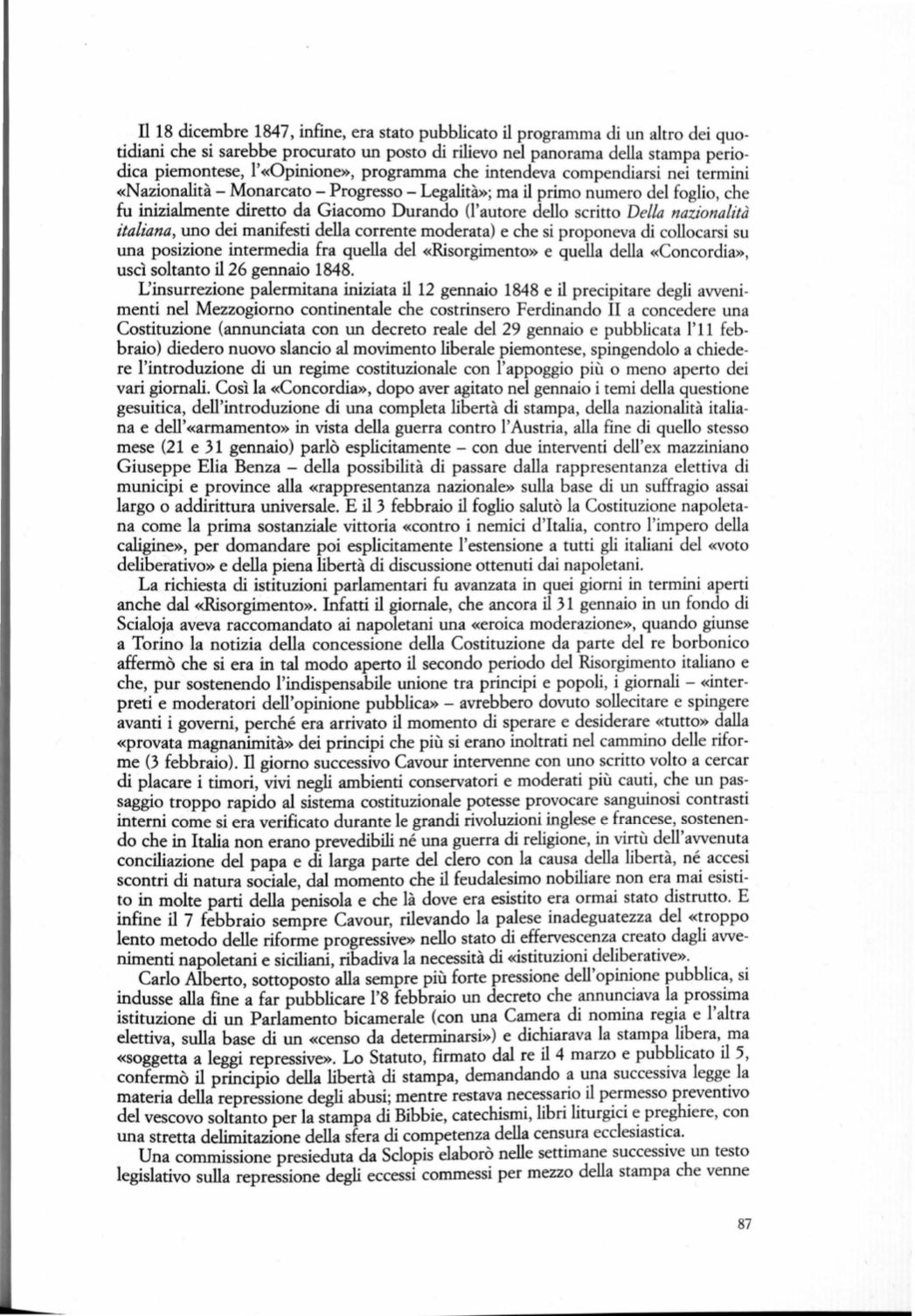
·
~
1.8
dice~bre
1847,
infine, era stato pubblicato
il
programma di un altro dei quo–
t1~han1.
che SI sareb,be
p~o~urato
un posto di rilievo nel panorama della stampa perio–
dIca pIemontese, l «OpIn10ne», programma che intendeva compendiarsi nei termini
«N~z.i~nalità
-
M~marcato
-
~rogresso
-
Legalit~»;
ma
il
primo numero del foglio, che
fu
ffiIzialmente diretto da GIacomo Durando
(l
autore dello scritto
Della nazionalità
italt'ana,
uno dei manifesti della corrente moderata) e che si proponeva di collocarsi su
una posizione intermedia fra quella del «Risorgimento» e quella della «Concordia»
uscì soltanto
il
26
gennaio
1848.
'
L'insurrezione palermitana iniziata
il
12
gennaio
1848
e
il
precipitare degli avveni–
menti nel Mezzogiorno continentale che costrinsero Ferdinando II a concedere una
Costituzione (annunciata con un decreto reale del 29 gennaio e pubblicata 1'11 feb–
braio) diedero nuovo slancio al movimento liberale piemontese, spingendolo a chiede–
re l'introduzione di un regime costituzionale con l'appoggio più o meno aperto dei
vari giornali. Così la «Concordia», dopo aver agitato nel gennaio i temi della questione
gesuitica, dell'introduzione di una completa libertà di stampa, della nazionalità italia–
na e dell'«armamento» in vista della guerra contro l'Austria, alla fine di quello stesso
mese
(21
e
31
gennaio) parlò esplicitamente - con due interventi dell'ex mazziniano
Giuseppe Elia Benza - della possibilità di passare dalla rappresentanza elettiva di
municipi e province alla «rappresentanza nazionale» sulla base di un suffragio assai
largo o addirittura universale. E il 3 febbraio il foglio salutò la Costituzione napoleta–
na come la prima sostanziale vittoria «contro i nemici d'Italia, contro l'impero della
caligine», per domandare poi esplicitamente l'estensione a tutti gli italiani del «voto
deliberativo» e della piena libertà di discussione ottenuti dai napoletani.
La richiesta di istituzioni parlamentari
fu
avanzata in quei giorni in termini aperti
anche dal «Risorgimento». Infatti il giornale, che ancora
il
31
gennaio in un fondo di
Scialoja aveva raccomandato ai napoletani una «eroica moderazione», quando giunse
a Torino la notizia della concessione della Costituzione da parte del re borbonico
affermò che si era in tal modo aperto il secondo periodo del Risorgimento italiano e
che, pur sostenendo l'indispensabile unione tra principi e popoli, i giornali - «inter–
preti e moderatori dell'opinione pubblica» - avrebbero dovuto sollecitare e spingere
avanti i governi, perché era arrivato il momento di sperare e desiderare «tutto» dalla
«provata magnanimità» dei principi che più si erano inoltrati nel cammino delle rifor–
me (3 febbraio).
li
giorno successivo Cavour intervenne con uno scritto volto a cercar
di placare i timori, vivi negli ambienti conservatori e moderati più cauti, che un pas–
saggio troppo rapido al sistema costituzionale potesse provocare sanguinosi contrasti
interni come si era verificato durante le grandi rivoluzioni inglese e francese, sostenen–
do che in Italia non erano prevedibili né una guerra di religione, in virtù dell'avvenuta
conciliazione del papa e di larga parte del clero con la causa della libertà, né accesi
scontri di natura sociale, dal momento che il feudalesimo nobiliare non era mai esisti–
to in molte parti della penisola e che là dove era esistito era ormai stato distrutto. E
infine il 7 febbraio sempre Cavour, rilevando la palese inadeguatezza del «troppo
lento metodo delle riforme progressive» nello stato di effervescenza creato dagli avve–
nimenti napoletani e siciliani, ribadiva la necessità di «istituzioni deliberative».
Carlo Alberto, sottoposto alla sempre più forte pressione dell'opinione pubblica, si
indusse alla fine a far pubblicare 1'8 febbraio un decreto che annunciava la prossima
istituzione di un Parlamento bicamerale (con una Camera di nomina regia e l'altra
elettiva, sulla base di un «censo da determinarsi») e dichiarava la stampa libera, ma
«soggetta a leggi repressive». Lo Statuto, firmato dal re il 4 marzo e pub?licato il 5,
confermò il principio della libertà di stampa, demandando a una succeSSIva legge la
materia della repressione degli abusi; mentre restava necessario il permesso preventivo
del vescovo soltanto per la stampa di Bibbie, catechismi, libri liturgici
~ pr~ghiere,
con
una stretta delimitazione della sfera di competenza della censura eccleSIastica.
Una commissione presieduta da Sclopis elaborò nelle settimane successive un testo
legislativo sulla repressione degli eccessi commessi per mezzo della stampa che venne
87


















