
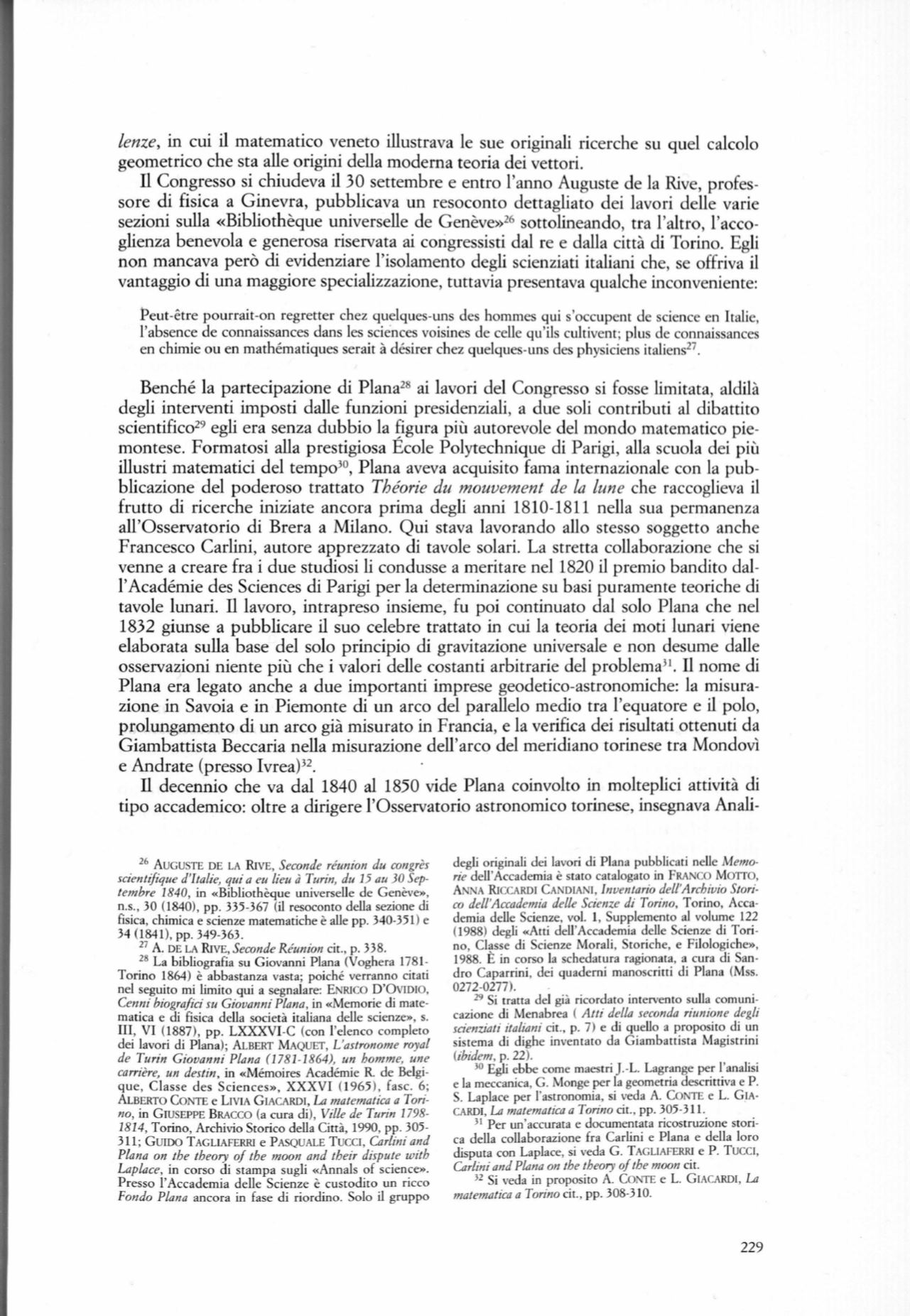
lenze,
in cui il matematico veneto illustrava le sue originali ricerche su quel calcolo
geometrico che sta alle origini della moderna teoria dei vettori.
Il Congresso si chiudeva il 30 settembre e entro l'anno Auguste de la Rive, profes–
sore di fisica a Ginevra, pubblicava un resoconto dettagliato dei lavori delle varie
sezioni sulla «Bibliothèque universelle de Genève»26 sottolineando, tra 1'altro, l'acco–
glienza benevola e generosa riservata ai congressisti dal re e dalla città di Torino. Egli
non mancava però di evidenziare l'isolamento degli scienziati italiani ch, offriva il
vantaggio di una maggiore specializzazione, tuttavia presentava qualche inconveni
nt :
Peut-etre pourrait-on regretter chez quelques-uns des hommes qui s'occupent de sci nce en Itali ,
l'absence de connaissances dans les sciences voisines de celle qu'ils cultivent; plu d connai ance
en chimie ou en mathématiques serait
à
désirer chez quelques-uns des phy iciens italien
27.
Benché la partecipazione di Plana 28 ai lavori del Congresso si fosse limitata, aldilà
degli interventi imposti dalle funzioni presidenziali, a due soli contributi al dibattito
scientific0 29 egli era senza dubbio la figura più autorevole del mondo matematico pie–
montese. Formatosi alla prestigiosa Ecole Polytechnique di Parigi, alla scuola dei più
illustri matematici del temp0
30,
Plana aveva acquisito fama internazionale con la pub–
blicazione del poderoso trattato
Théorie du mouvement de la lune
che raccoglieva
il
frutto di ricerche iniziate ancora prima degli anni 1810-1811 nella sua permanenza
all'Osservatorio di Brera a Milano. Qui stava lavorando allo stesso soggetto anche
Francesco Carlini, autore apprezzato di tavole solari. La stretta collaborazione che si
venne a creare fra i due studiosi li condusse a meritare nel 1820 il premio bandito dal–
l'Académie des Sciences di Parigi per la determinazione su basi puramente teoriche di
tavole lunari. Il lavoro, intrapreso insieme, fu poi continuato dal solo Plana che nel
1832 giunse a pubblicare il suo celebre trattato in cui la teoria dei moti lunari viene
elaborata sulla base del solo principio di gravitazione universale e non desume dalle
osservazioni niente più che i valori delle costanti arbitrarie del problema
31 •
Il nome di
Plana era legato anche a due importanti imprese geodetico-astronomiche: la misura–
zione in Savoia e in Piemonte di un arco del parallelo medio tra l'equatore e il polo,
prolungamento di un arco già misurato in Francia, e la verifica dei risultati ottenuti da
Giambattista Beccaria nella misurazione dell' arco del meridiano torinese tra Mondovì
e Andrate (presso Ivrea)32.
Il decennio che va dal 1840 al 1850 vide Plana coinvolto in molteplici attività di
tipo accademico: oltre a dirigere l'Osservatorio astronomico torinese, insegnava Anali-
26
AUGUSTE DE LA RIVE,
Seconde réunion du congrès
scientlfique d'Italie, qui a eu lieu
à
Turin, du
15
au 30 Sep–
tembre 1840,
in «Bibliothèque universelle de Genève»,
n.s., 30 (1840), pp. 335-367
(il
resoconto della sezione di
fisica, chimica e scienze matematiche è alle pp. 340-350 e
34 (1841), pp. 349-363.
27
A.
DE LARIVE,
Seconde Réunion
cit., p. 338.
28
La bibliografia su Giovanni Plana (Voghera 1781-
Torino 1864) è abbastan za vasta; poiché verranno citati
nel seguito mi limito qui a segnalare: ENRlCO D'OVIDIO,
Cenni biografici su Giovanni Plana,
in «Memorie di mate–
matica e di fisica della società italiana delle scienze», s.
III,
VI (1887), pp. LXXXVI-C (con l'elenco completo
dei lavori di Plana); ALBERT MAQUET,
L'astronome royal
de Turin Giovanni Plana
(1781-1864),
un homme, une
carrière, un destin,
in «Mémoires Académie
R.
de Belgi–
que , Classe des Sciences» , XXXVI (1965), fasc. 6;
ALBERTO CONTE e LrvlAGIACARDI,
La
matematica a Tori–
no,
in GIUSEPPE BRACCO (a cura
di ), Ville de Turin 1798-
1814,
Torino, Archivio Storico della Città, 1990, pp. 305-
311; GUIDO TAGLlAFERRl e PASQUALE TUCCI,
Carlini and
Plana on the theory of the moon and their dispute with
Laplace,
in corso di stampa sugli «Annals of science».
Presso
l'Accademia
delle Scienze è custodito un ricco
Fondo Plana
ancora in fase di riordino. Solo
il
gruppo
degli originali dei lavori di Plana pubblicati nelle
Memo–
rie
dell'Accademia è stato catalogato in FRANCO MOTTO,
ANNA RICCARDI CANDIANI,
Inventario dell'Archivio Stori–
co dell'Accademia delle Scienze di Torino,
Torino, Acca–
demia delle Scienze, val. l, Supplemento al volume 122
(1988) degli «Atti dell'Accademia delle Scienze di Tori–
no, Classe di Scienze Morali , toriche, e Filologiche» ,
1988.
È
in corso la schedatura ragionata, a cura di San–
dro Caparrini, dei quaderni manoscritti di P lana (Mss.
0272-0277).
29
Si tratta de.! già ricordato intervento sulla comuni–
cazione di Menabrea (
Atti della seconda riunione degli
scienziati italiani
cit., p.
7)
e di quello a proposito di un
sistema di dighe inventato da Giambattista Magistrini
(ibidem,
p. 22).
lO
Egli ebbe come maestri
J.-L.
Lagrange per l'anaUsi
e la meccanica, G. Monge per la geometria descrittiva e P.
S. Laplace per l'astronomia, si veda A. CONTE e
L.
GIA–
CARDI,
La
matematica a Torino
cit., pp. 305-311.
l I
Per un 'accurata e documentata ricostruzione stori–
ca della collaborazione fra Carlini e P lana e della loro
disputa con Laplace, si veda G. TAGLiAFERRl e P. TUCCI,
Carlini and Plana on the theory ofthe moon
cit.
}2
Si veda
in
proposito
A.
CONTE e
L.
GIACARDI,
La
matematica a Torino
cit., pp. 308-310.
229


















