
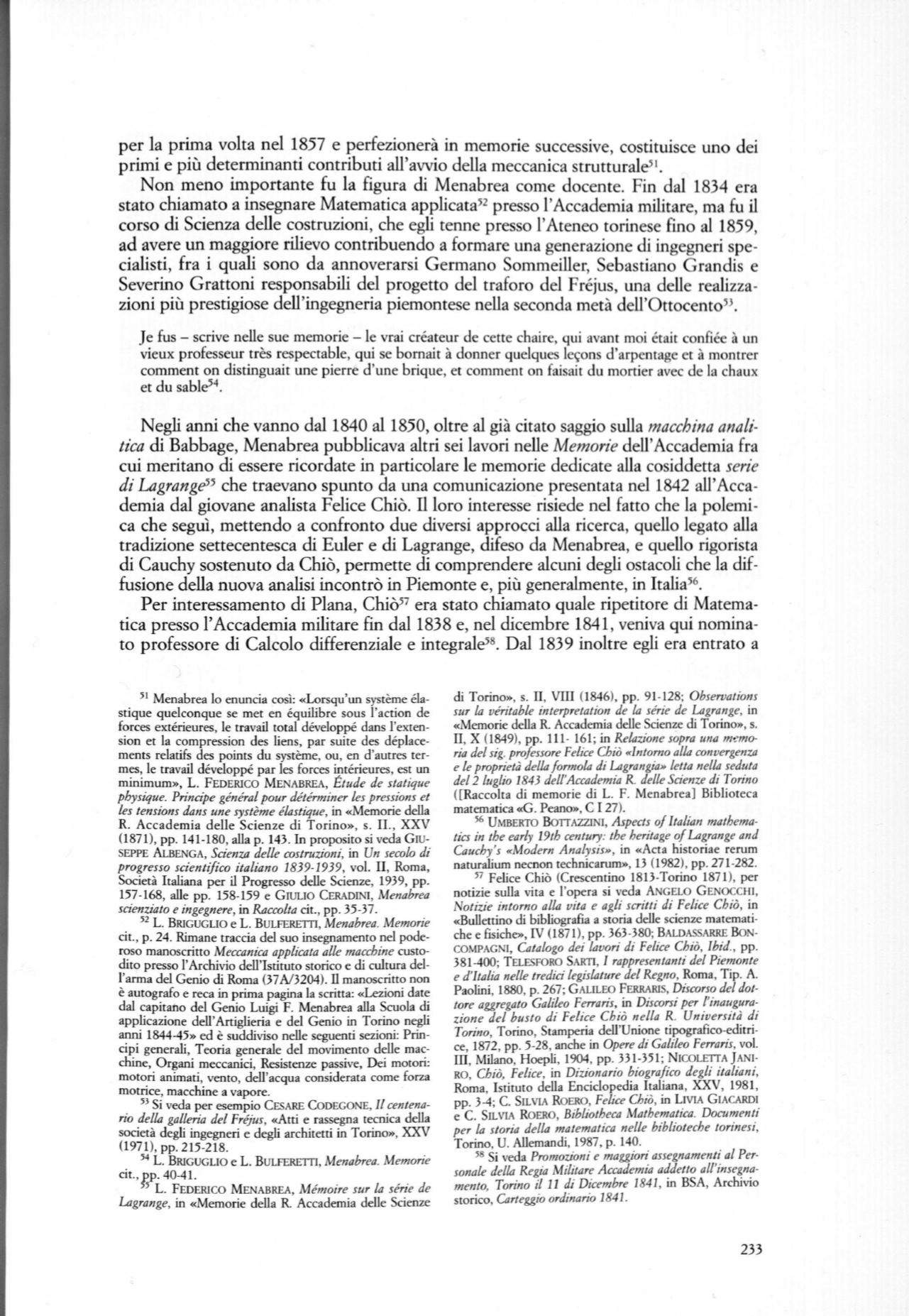
per la prima volta nel 1857 e perfezionerà in memorie successive, costituisce uno dei
primi e più determinanti contributi all'avvio della meccanica strutturale5
l .
Non meno importante fu la figura di Menabrea come docente. Fin dal 1834 era
stato chiamato a insegnare Matematica applicata
52
presso l'Accademia militare, ma fu il
corso
di
Scienza delle costruzioni, che egli tenne presso l'Ateneo torinese fino al 1859,
ad avere un maggiore rilievo contribuendo a formare una generazione
di
ingegneri pe–
cialisti, fra i quali sono da annoverarsi Germano Sommeiller, ebastiano randi
Severino Grattoni responsabili del progetto del traforo del Fréjus, una delle r alizza–
zioni più prestigiose dell'ingegneria piemontese nella seconda metà dell'Ottocento'}.
Je fus - scrive nelle sue memorie -le vrai créateur de cette chaire, qui avant moi était confié
à
un
vieux professeur très respectable, qui se bornait
à
donner quelques leçons d'arpentage et
à
m ntr r
comment on distinguait une pierre d'une brique, et comment on faisait du mortier avec de la chaux
et du sable5
4 .
Negli anni che vanno dal 1840 al 1850, oltre al già citato saggio sulla
macchina anali–
tica
di Babbage, Menabrea pubblicava altri sei lavori nelle
Memorie
dell'Accademia fra
cui meritano di essere ricordate in particolare le memorie dedicate alla cosiddetta
serie
di Lagrange'5
5
che traevano spunto da una comunicazione presentata nel 1842 all'Acca–
demia dal giovane analista Felice Chiò. Il loro interesse risiede nel fatto che la polemi–
ca che seguì, mettendo a confronto due diversi approcci alla ricerca, quello legato alla
tradizione settecentesca di Euler e di Lagrange, difeso da Menabrea, e quello rigorista
di Cauchy sostenuto da Chiò, permette di comprendere alcuni degli ostacoli che la
dif–
fusione della nuova analisi incontrò in Piemonte e, più generalmente, in ltalia'6.
Per interessamento di Plana, Chiò
57
era stato chiamato quale ripetitore di Matema–
tica presso l'Accademia militare fin dal 1838 e, nel dicembre 1841, veniva qui nomina–
to professore di Calcolo differenziale e integrale
58 •
Dal 1839 inoltre egli era entrato a
51
Menabrea lo enuncia cosÌ: «Lorsqu'un système éla–
stique quelconque se met en équi!ibre sous l'action de
forces extérieures, le travai! total développé dans l'exten–
sion et la compression des liens, par suite des déplace–
ments relatifs des points du système, ou, en d 'autres ter–
mes, le travai! développé par les forces intérieures, est un
minimum» ,
L.
FEDERICO MENABREA,
Étude de statique
physique. Principe général pour détérminer les pressions et
les tensions dans une système élastique,
in «Memorie della
R. Accademia delle Scienze di Torino», s. II.,
XXV
(1871), pp. 141-180, alla p. 143.
In
proposito si veda GIU–
SEPPE ALBENGA,
Scienza delle costruzioni,
in
Un secolo di
progresso scientifico italiano
1839-1939, voI. II, Roma ,
Società Italiana per i! Progresso delle Scienze, 1939, pp.
157-168, alle pp. 158-159 e GIULIO CERADlNI,
Menabrea
scienziato e ingegnere,
in
Raccolta
cit., pp. 35-37.
52
L.
BRIGUGLIO e
L.
BULFERETTI,
Menabrea. Memorie
cit., p. 24. Rimane traccia del suo insegnamento nel pode–
roso manoscritto
Meccanica applicata alle macchine
custo–
dito presso l'Archivio dell'Istituto storico e di cultura del–
l'arma del Genio di Roma (37
Al3
204).
TI
manoscritto non
è autografo e reca in prima pagina la scritta: «Lezioni date
dal capitano del Genio Luigi
F.
Menabrea alla Scuola di
applicazione dell'Artiglieria e del Genio in Torino negli
anni 1844-45» ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: Prin–
cipi generali, Teoria generale del movimento delle mac–
chine, Organi meccanici, Resistenze passive, Dei motori:
motori animati, vento, dell'acqua considerata come forza
motrice, macchine a vapore.
53
Si veda per esempio CESARE CODEGONE,
Il centena–
rio della galleria del Fréjus,
<<Atti e rassegna tecnica della
società degli ingegneri e degli architetti in Torino», XXV
(1971), pp. 215-218.
54
L.
BRIGUGLIO e
L.
BULFERETTI,
Menabrea. Memorie
cit.,
~p.
40-41.
5
L.
FEDERICO MENABREA,
Mémoire sur la série de
Lagrange,
in «Memorie della
R.
Accademia delle Scienze
di Torino», s.
II, VIII
(1846), pp. 91-128;
Observations
sur la véritable interpretation de la série de Lagrange,
in
«Memorie della
R.
Accademia delle cienze di Torino», s.
II, X
(1849), pp. 111- 161; in
Relazione sòpra una m.'mo–
ria del sig. professore Felice Chiò <dntorno alla convergenza
e le proprietà della formala di Lagrangia» letta nella seduta
del
2
luglio
1843
dell'Accademia
R.
delle Scienze di Torino
([Raccolta di memorie di
L.
F. Menabreal Biblioteca
matematica «G. Peano» , C
I
27).
56
UMBERTO BOTTAZZINI ,
Aspects of ltalian mathema–
tics in the early 19th century: the heritage
01
Lagrange and
Cauchy's «Modern Analysis»,
in «Acta historiae rerum
naturalium necnon technicarum»,
13
(1982), pp. 271 -282.
57
Felice Chiò (Crescentino 1813-Torino 1871), per
notizie sulla vita e l'opera si veda ANGELO GEN
Hl ,
Notizie intorno alla vita e agli scritti di Felice Chiò,
in
«Bullettino di bibliografia a storia delle scienze matemati–
che e fisiche» ,
IV
(1871), pp. 363-380; BALDASSARRE BON–
COMPAGNI,
Catalogo dei lavori di Felice Chiò, /bid.,
pp.
381-400; TELESFORO SARTI,
I rappresentanti del Piemonte
e d'Italia nelle tredici legislature del Regno,
Roma, Tip.
A.
Paolini, 1880, p. 267; GALILEO FERRARJS,
Discorso del dot–
tore aggregato Galileo Ferraris,
in
Discorsi per l'inaugura–
zione del busto di Felice Chiò nella
R.
Università di
Torino,
Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editri–
ce, 1872, pp. 5-28, anche in
Opere di Galileo Ferraris,
voI.
ID,
Milano, Hoepli, 1904, pp. 331-351; NICOLETTA ] ANI–
RO,
Chiò, Felice,
in
Dizionario biografico degli italiani,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, XXV, 1981,
pp. 3-4;
C.
SILVIA ROERO,
Felice Chiò,
in LIVIA GIACARDI
e
C.
SILVIA ROERO,
Bibliotheca Mathematica. Documenti
per la storia della matematica nelle biblioteche torinesi,
Torino, U. Allemandi, 1987, p. 140.
58
Si veda
Promozioni e maggiori assegnamenti al Per–
sonale della Regia Militare Accademia addetto all'insegna–
mento, Torino il
11
di Dicembre
1841, in BSA, Archivio
storico,
Carteggio ordinario 184 1.
233


















