
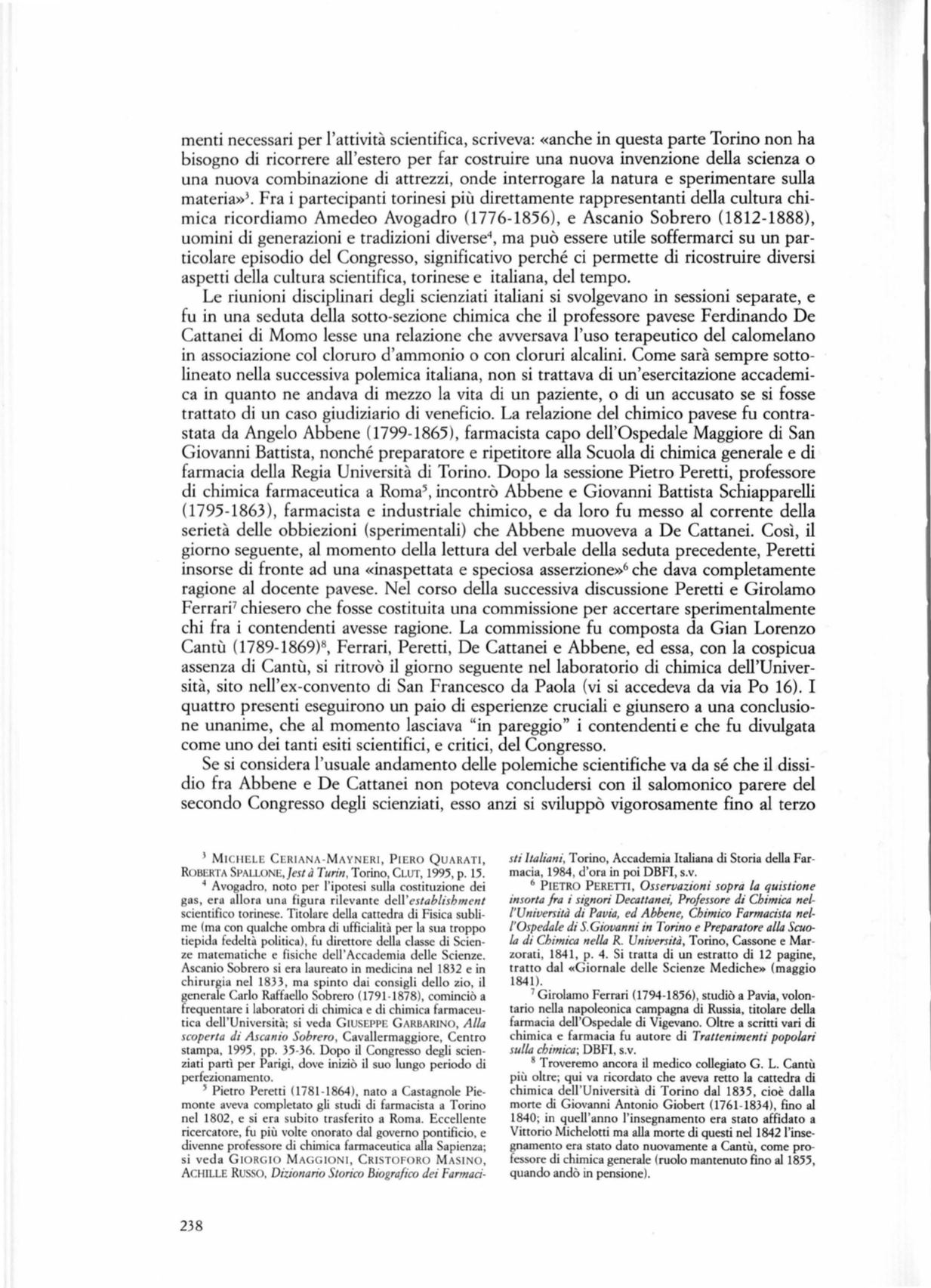
menti necessari per l'attività scientifica, scriveva: «anche in questa parte Torino non ha
bisogno di ricorrere all'estero per far costruire una nuova invenzione della scienza o
una nuova combinazione di attrezzi, onde interrogare la natura e sperimentare sulla
materia»3. Fra i partecipanti torinesi più direttamente rappresentanti della cultura chi–
mica ricordiamo Amedeo Avogadro
(1776-1856) ,
e Ascanio Sobrero
(1812-1888),
uomini di generazioni e tradizioni diverse
4 ,
ma può essere utile soffermarci su un par–
ticolare episodio del Congresso, significativo perché ci permette di ricostruire diversi
aspetti della cultura scientifica, torinese e italiana, del tempo_
Le riunioni disciplinari degli scienziati italiani si svolgevano in sessioni separate, e
fu in una seduta della sotto-sezione chimica che il professore pavese Ferdinando De
Cattanei di Momo lesse una relazione che avversava l'uso terapeutico del calomelano
in associazione col cloruro d'ammonio o con cloruri alcalini. Come sarà sempre sotto–
lineato nella successiva polemica italiana, non si trattava di un'esercitazione accademi–
ca in quanto ne andava di mezzo la vita di un paziente, o di un accusato se si fosse
trattato di un caso giudiziario di veneficio. La relazione del chimico pavese fu contra–
stata da Angelo Abbene
(1799-1865) ,
farmacista capo dell'Ospedale Maggiore di San
Giovanni Battista, nonché preparatore e ripetitore alla Scuola
di
chimica generale e di
farmacia della Regia Università di Torino. Dopo la sessione Pietro Peretti, professore
di chimica farmaceutica a Roma
5 ,
incontrò Abbene e Giovanni Battista Schiapparelli
(1795-1863) ,
farmacista e industriale chimico, e da loro fu messo al corrente della
serietà delle obbiezioni (sperimentali) che Abbene muoveva a De Cattanei_ Così,
il
giorno seguente, al momento della lettura del verbale della seduta precedente, Peretti
insorse di fronte ad una «inaspettata e speciosa asserzione»6che dava completamente
ragione al docente pavese. Nel corso della successiva discussione Peretti e Girolamo
Ferrari
7
chiesero che fosse costituita una commissione per accertare sperimentalmente
chi fra i contendenti avesse ragione. La commissione fu composta da Gian Lorenzo
Cantù
(1789-1869)8,
Ferrari, Peretti, De Cattanei e Abbene, ed essa, con la cospicua
assenza di Cantù, si ritrovò il giorno seguente nel laboratorio di chimica dell'Univer–
sità, sito nell 'ex-convento di San Francesco da Paola (vi si accedeva da via Po
16).
I
quattro presenti eseguirono un paio di esperienze cruciali e giunsero a una conclusio–
ne unanime, che al momento lasciava "in pareggio" i contendenti e che fu divulgata
come uno dei tanti esiti scientifici, e critici, del Congresso.
Se si considera l'usuale andamento delle polemiche scientifiche va da sé che il dissi–
dio fra Abbene e De Cattanei non poteva concludersi con il salomonico parere del
secondo Congresso degli scienziati, esso anzi si sviluppò vigorosamente fino al terzo
3
MI CHELE CER IANA- MAYNER I, PI ERO Q UARATI ,
ROBERTA SPALLONE, ]est
à Turin,
Torino, CLUT, 1995, p. 15.
4
Avogadro, noto per l'ipotesi sulla costituzione dei
gas, era allo ra una figura rilevante dell '
establishment
scientifico torinese. Titolare della cattedra di Fisica subli–
me (ma con qualche ombra di ufficialità per la sua troppo
tiepida fedeltà politica), fu direttore della classe di Scien–
ze matematiche e fisiche dell 'Accademia delle Scienze.
Ascanio Sobrero si era laureato in medicina nel 1832 e in
chirurgia nel 1833 , ma spinto dai consigli dello zio,
il
generale Carlo Raffaello Sobrero (1791-1878), cominciò a
frequentare i laboratori di chimica e di chimica farmaceu–
tica dell'Università; si veda G IUSEPPE GARBARINO,
Alla
scoperta di Ascanio Sobrero,
Cavallermaggiore, Centro
stampa, 1995, pp. 35-36. Dopo
il
Congresso degli scien–
ziati parti per Parigi, dove iniziò
il
suo lungo periodo di
perfezionamento.
, P ietro Peretti (1 781-1864), nato a Castagnole Pie–
monte aveva completato gli studi di fa rmacista a Torino
nel 1802, e si era subito trasferito a Roma. Eccellente
ricercatore,
fu
più volte onorato dal governo pontificio, e
divenne professore di chimica farmaceutica alla Sapienza;
si ved a G IORG IO MAGGIO I, CRISTOFORO MASI NO,
ACHILLE Russo,
Dizionario Storico Biografico dei Farmaci-
238
sti Italiani,
Torino, Accademia Italiana di Storia della Far–
macia, 1984, d'ora in poi DBFI, S.v.
6
PI ETRO P ERETTI ,
Osservazioni sopra la quistione
insorta fra
i
signori Decattanel; Professore di Chimica nel–
l'Università di Pavia, ed Abbene, Chimico Farmacista nel–
l'Ospedale di S.Giovanni in Torino e Preparatore alla Scuo–
la di Chimica nella
R.
Università,
Torino, Cassone e Mar–
zorati, 1841 , p. 4. Si tratta di un estratto di 12 pagine,
tratto dal «Giornale delle Scienze Mediche» (maggio
1841 ).
7
Girolamo Ferrari (1794-1856) , studiò a Pavia, volon–
tario nella napoleonica campagna di Russia, titolare della
farmacia dell'Ospedale di Vigevano. Oltre a scritti vari
di
chimica e farmacia fu autore di
Trattenimenti popolari
sulla chimica;
DBFI, S.v.
B
Troveremo ancora
il
medico collegiato G.
L.
Cantù
più oltre; qui va ricordato che aveva retto la cattedra
di
chimica dell 'Università di Torino dal 1835, cioè dalla
morte di Giovanni Antonio Giobert (1761-1834) , fino al
1840; in quell'anno l'insegnamento era stato affidato a
Vittorio Michelotti ma alla morte di questi nel 1842 l'inse–
gnamento era stato dato nuovamente a Cantù, come pro–
fessore
di
chimica generale (ruolo mantenuto fino al 1855,
quando andò in pensione).


















