
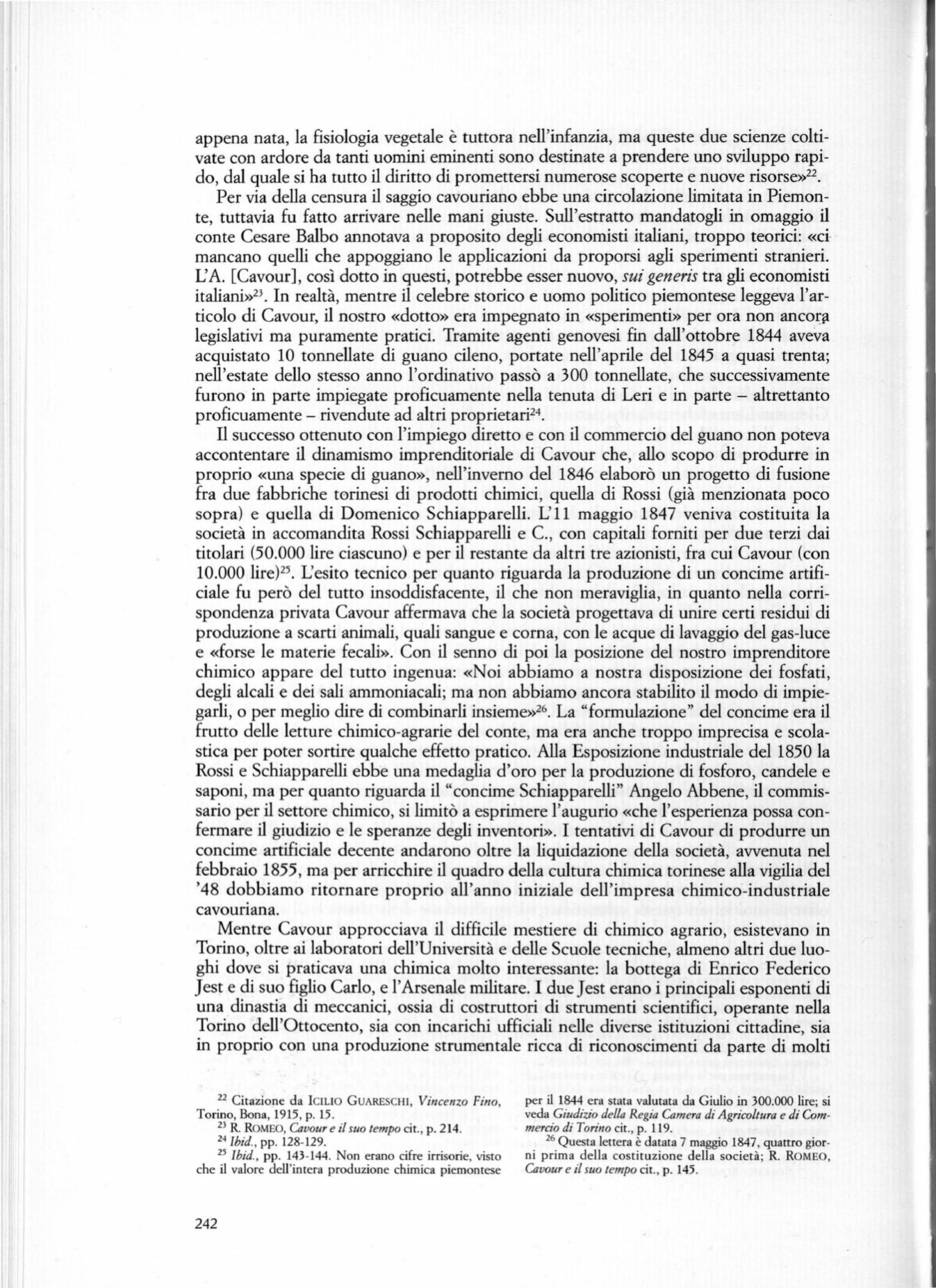
appena nata, la fisiologia vegetale è tuttora nell'infanzia, ma queste due scienze colti–
vate con ardore da tanti uomini eminenti sono destinate a prendere uno sviluppo rapi–
do, dal quale si ha tutto il diritto di promettersi numerose scoperte e nuove risorse»22.
Per via della censura il saggio cavouriano ebbe una circolazione limitata in Piemon–
te, tuttavia fu fatto arrivare nelle mani giuste. Sull'estratto mandatogli in omaggio il
conte Cesare Balbo annotava a proposito degli economisti italiani, troppo teorici: «ci
mancano quelli che appoggiano le applicazioni da proporsi agli sperimenti stranieri.
L'A. [Cavour], così dotto in questi, potrebbe esser nuovo,
sui generis
tra gli economisti
italiani»23 . In realtà, mentre il celebre storico e uomo politico piemontese leggeva l'ar–
ticolo di Cavour, il nostro «dotto» era impegnato in «sperimenti» per ora non
anco~~
legislativi ma puramente pratici. Tramite agenti genovesi fin dall'ottobre
1844
aveva
acquistato
lO
tonnellate di guano cileno, portate nell'aprile del
1845
a quasi trenta;
nell'estate dello stesso anno l'ordinativo passò a
300
tonnellate, che successivamente
furono in parte impiegate proficuamente nella tenuta di Leri e in parte - altrettanto
proficuamente - rivendute ad altri proprietari 24 .
TI successo ottenuto con l'impiego diretto e con il commercio del guano non poteva
accontentare il dinamismo imprenditoriale di Cavour che, allo scopo di produrre in
proprio «una specie di guano», nell'inverno del
1846
elaborò un progetto di fusione
fra due fabbriche torinesi di prodotti chimici, quella di Rossi (già menzionata poco
sopra) e quella di Domenico Schiapparelli. L'lI maggio
1847
veniva costituita la
società in accomandita Rossi Schiapparelli e
c.,
con capitali forniti per due terzi dai
titolari
(50.000
lire ciascuno) e per il restante da altri tre azionisti, fra cui Cavour (con
10.000
lire)25 . L'esito tecnico per quanto riguarda la produzione di un concime artifi–
ciale fu però del tutto insoddisfacente, il che non meraviglia, in quanto nella corri–
spondenza privata Cavour affermava che la società progettava di unire certi residui di
produzione a scarti animali, quali sangue e corna, con le acque di lavaggio del gas-luce
e «forse le materie fecali». Con il senno di poi la posizione del nostro imprenditore
chimico appare del tutto ingenua: «Noi abbiamo a nostra disposizione dei fosfati,
degli alcali e dei sali ammoniacali; ma non abbiamo ancora stabilito il modo di impie–
garli, o per meglio dire di combinarli insieme»26. La "formulazione" del concime era il
frutto delle letture chimico-agrarie del conte, ma era anche troppo imprecisa e scola–
stica per poter sortire qualche effetto pratico. Alla Esposizione industriale del
1850
la
Rossi e Schiapparelli ebbe una medaglia d'oro per la produzione di fosforo, candele e
saponi, ma per quanto riguarda il "concime Schiapparelli" Angelo Abbene, il commis–
sario per il settore chimico, si limitò a esprimere l'augurio «che l'esperienza possa con–
fermare il giudizio e le speranze degli inventori». I tentativi di Cavour di produrre un
concime artificiale decente andarono oltre la liquidazione della società, avvenuta nel
febbraio
1855,
ma per arricchire il quadro della cultura chimica torinese alla vigilia del
'48
dobbiamo ritornare proprio all' anno iniziale dell'impresa chimico'-industriale
cavounana.
Mentre Cavour approcciava il difficile mestiere di chimico agrario, esistevano in
Torino, oltre ai laboratori dell'Università e delle Scuole tecniche, almeno altri due luo–
ghi dove si praticava una chimica molto interessante: la bottega di Enrico Federico
J
est e di suo figlio Carlo, e l'Arsenale militare. I due
J
est erano i principali esponenti di
una dinastia di meccanici, ossia di costruttori di strumenti scientifici, operante nella
Torino dell'Ottocento, sia con incarichi ufficiali nelle diverse istituzioni cittadine, sia
in proprio con una produzione strumentale ricca di riconoscimenti da parte di molti
22
Citazione da
ICi LIO
GUARESCHI ,
Vincenzo Fino,
Torino, Bona, 1915, p. 15.
23
R.
ROMEO,
Cavour e il suo tempo
cit., p. 214.
24
Ibid. ,
pp. 128- 129.
2~
Ibid.,
pp. 143-144. Non erano cifre irrisorie, visto
che
il
valore dell'intera produzione chimica piemontese
242
per
il
1844 era stata valutata da Giulio in 300.000 lire; si
veda
Giudizio della Regia Camera di Agricoltura e di Com–
mercio di Torino
cit., p. 119.
26
Questa lettera è datata 7 maggio 1847, quattro gior–
ni prima della costituzione della società;
R.
ROMEO,
Cavour e il suo tempo
cit.,
p.
145.


















