
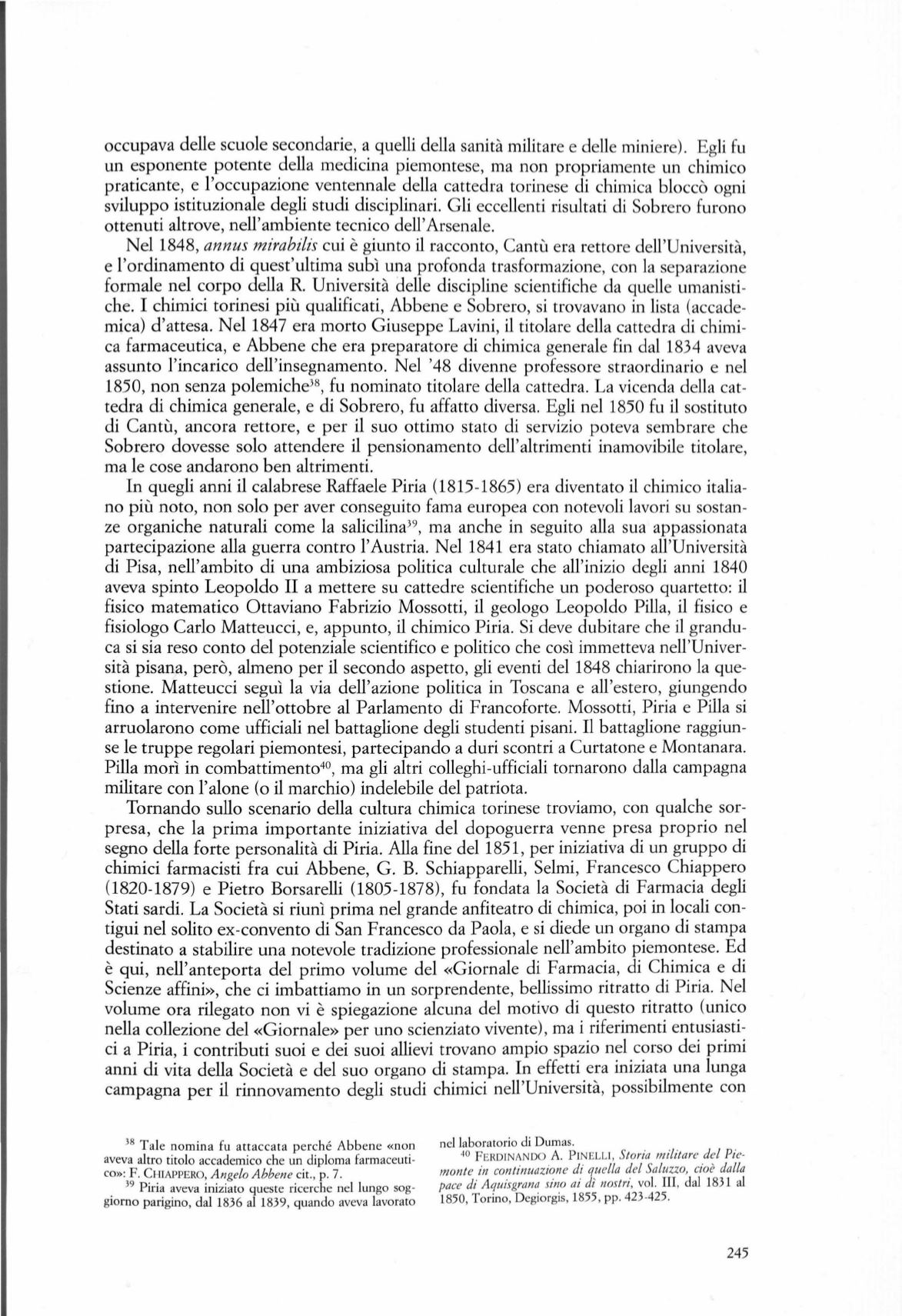
occupava delle scuole secondarie, a quelli della sanità militare e delle miniere). Egli fu
un esponente potente della medicina piemontese, ma non propriamente un chimico
praticante, e l'occupazione ventennale della cattedra torinese di chimica bloccò ogni
sviluppo istituzionale degli studi disciplinari. Gli eccellenti risultati di Sobrero furono
ottenuti altrove, nell' ambiente tecnico dell'Arsenale.
Nel
1848,
annus mirabilis
cui è giunto il racconto, Cantù era rettore dell'Università,
e l'ordinamento di quest'ultima subì una profonda trasformazione, con la separazione
formale nel corpo della
R.
Università delle discipline scientifiche da quelle umanisti–
che. I chimici torinesi più qualificati, Abbene e Sobrero, si trovavano in lista (accade–
mica) d'attesa. Nel
1847
era morto Giuseppe Lavini, il titolare della cattedra di chimi–
ca farmaceutica, e Abbene che era preparatore di chimica generale fin dal
1834
aveva
assunto l'incarico dell'insegnamento. Nel
'48
divenne professore straordinario e nel
1850,
non senza polemiche
38 ,
fu nominato titolare della cattedra. La vicenda della cat–
tedra di chimica generale, e di Sobrero, fu affatto diversa. Egli nel
1850
fu il sostituto
di Cantù, ancora rettore, e per il suo ottimo stato di servizio poteva sembrare che
Sobrero dovesse solo attendere il pensionamento dell' altrimenti inamovibile titolare,
ma le cose andarono ben altrimenti.
In quegli anni il calabrese Raffaele Piria
(1815-1865)
era diventato il chimico italia–
no più noto, non solo per aver conseguito fama europea con notevoli lavori su sostan–
ze organiche naturali come la salicilina
39 ,
ma anche in seguito alla sua appassionata
partecipazione alla guerra contro l'Austria. Nel
1841
era stato chiamato all'Università
di Pisa, nell'ambito di una ambiziosa politica culturale che all'inizio degli anni
1840
aveva spinto Leopoldo II a mettere su cattedre scientifiche un poderoso quartetto: il
fisico matematico Ottaviano Fabrizio Mossotti, il geologo Leopoldo Pilla, il fisico e
fisiologo Carlo Matteucci, e, appunto, il chimico Piria. Si deve dubitare che il grandu–
ca si sia reso conto del potenziale scientifico e politico che così immetteva nell'Univer–
sità pisana, però, almeno per il secondo aspetto, gli eventi del
1848
chiarirono la que–
stione. Matteucci seguì la via dell'azione politica in Toscana e all'estero, giungendo
fino a intervenire nell'ottobre al Parlamento di Francoforte. Mossotti, Piria e Pilla si
arruolarono come ufficiali nel battaglione degli studenti pisani. Il battaglione raggiun–
se le truppe regolari piemontesi, partecipando a duri scontri a Curtatone e Montanara.
Pilla morì in combattiment0
40 ,
ma gli altri colleghi-ufficiali tornarono dalla campagna
militare con l'alone (o il marchio) indelebile del patriota.
Tornando sullo scenario della cultura chimica torinese troviamo, con qualche sor–
presa, che la prima importante iniziativa del dopoguerra venne presa proprio nel
segno della forte personalità di Piria. Alla fine del
1851,
per iniziativa di un gruppo di
chimici farmacisti fra cui Abbene, G. B. Schiapparelli, Selmi, Francesco Chiappero
(1820-1879)
e Pietro Borsarelli
(1805-1878),
fu fondata la Società di Farmacia degli
Stati sardi. La Società si riunì prima nel grande anfiteatro di chimica, poi in locali con–
tigui nel solito ex-convento di San Francesco da Paola, e si diede un organo di stampa
destinato a stabilire una notevole tradizione professionale nell' ambito piemontese. Ed
è qui, nell'anteporta del primo volume del «Giornale di Farmacia, di Chimica e di
Scienze affini», che ci imbattiamo in un sorprendente, bellissimo ritratto di Piria. Nel
volume ora rilegato non vi è spiegazione alcuna del motivo di questo ritratto (unico
nella collezione del «Giornale» per uno scienziato vivente), ma i riferimenti entusiasti–
ci a Piria, i contributi suoi e dei suoi allievi trovano ampio spazio nel corso dei primi
anni di vita della Società e del suo organo di stampa. In effetti era iniziata una lunga
campagna per il rinnovamento degli studi chimici nell'Università, possibilmente con
38
Tale nomina fu attaccata perché Abbene <<non
aveva altro titolo accademico che un diploma farmaceuti–
co»:
F.
CHIAPPERO,
Angelo Abbene
ciL, p. 7.
39
Piria aveva iniziato queste ricerche nel lungo sog–
giorno parigino, dal 1836 al 1839, quando aveva lavorato
nel laboratorio di Dumas.
40 F ERDINANDO
A.
PINELLI ,
Storia militare del Pie–
monte in continuazione di quella del Saluzzo, cioè dalla
pace di Aquisgrana sino ai dì nostri,
val. III, dal 183 1 al
1850, Torino, Degiorgis, 1855 , pp. 423-425.
245


















