
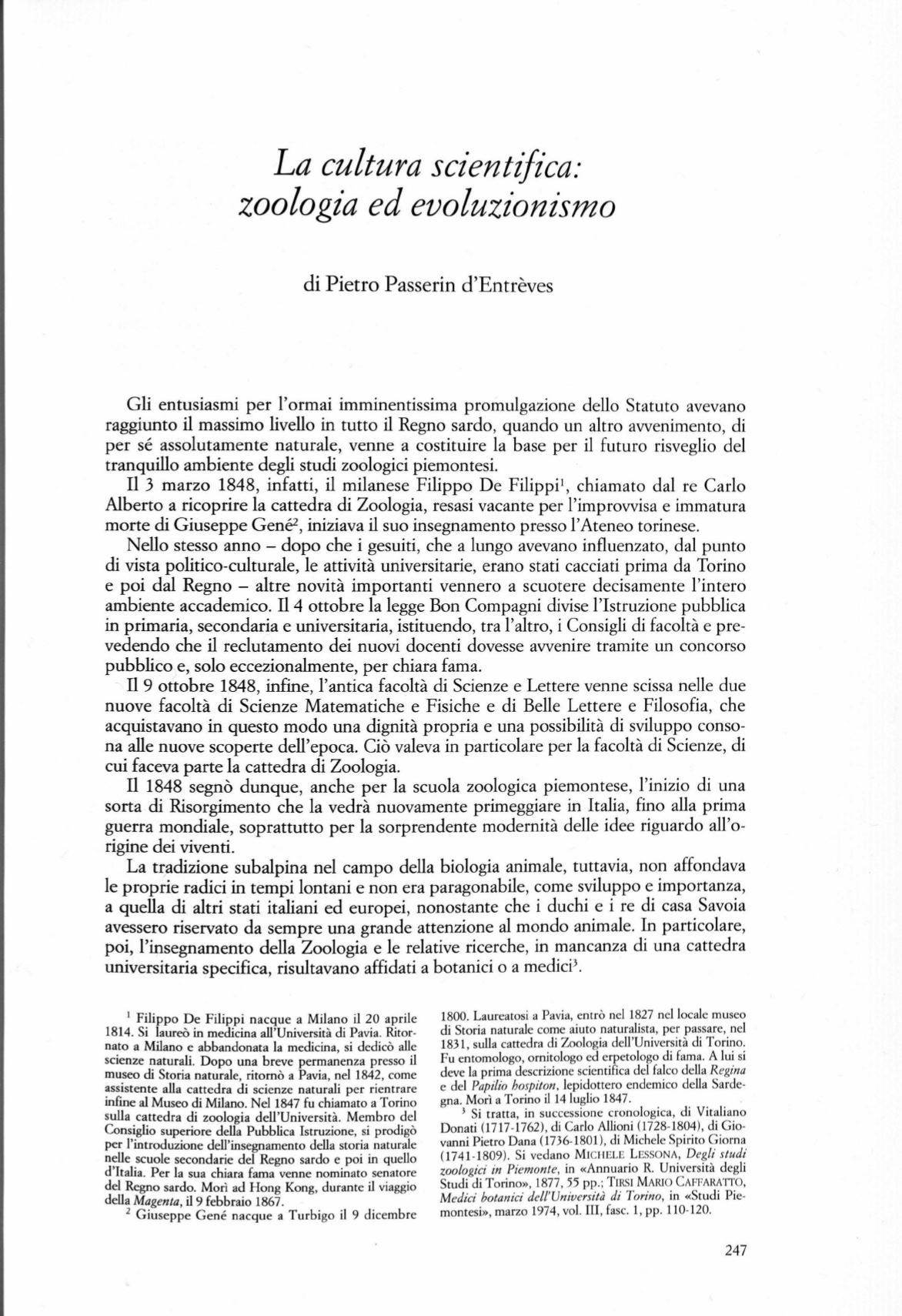
La
cultura scientifica:
zoologia ed evoluzionismo
di Pietro Passerin d'Entrèves
Gli entusiasmi per l'ormai imminentissima promulgazione dello Statuto avevano
raggiunto il massimo livello in tutto il Regno sardo, quando un altro avvenimento, di
per sé assolutamente naturale, venne a costituire la base per
il
futuro risveglio del
tranquillo ambiente degli studi zoologici piemontesi.
Il 3 marzo 1848, infatti, il milanese Filippo De Filippi
l ,
chiamato dal re Carlo
Alberto a ricoprire la cattedra di Zoologia, resasi vacante per l'improvvisa e immatura
morte di Giuseppe Gene, iniziava il suo insegnamento presso l'Ateneo torinese.
Nello stesso anno - dopo che i gesuiti, che a lungo avevano influenzato, dal punto
di vista politico-culturale, le attività universitarie, erano stati cacciati prima da Torino
e poi dal Regno - altre novità importanti vennero a scuotere decisamente l'intero
ambiente accademico. TI 4 ottobre la legge Bon Compagni divise l'Istruzione pubblica
in primaria, secondaria e universitaria, istituendo, tra 1'altro, i Consigli di facoltà e pre–
vedendo che il reclutamento dei nuovi docenti dovesse avvenire tramite un concorso
pubblico e, solo eccezionalmente, per chiara fama.
TI 9 ottobre 1848, infine, l'antica facoltà di Scienze e Lettere venne scissa nelle due
nuove facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e di Belle Lettere e Filosofia, che
acquistavano in questo modo una dignità propria e una possibilità di sviluppo conso–
na alle nuove scoperte dell'epoca. Ciò valeva in particolare per la facoltà di Scienze, di
cui faceva parte la cattedra di Zoologia.
TI 1848 segnò dunque, anche per la scuola zoologica piemontese, l'inizio di una
sorta di Risorgimento che la vedrà nuovamente primeggiare in Italia, fino alla prima
guerra mondiale, soprattutto per la sorprendente modernità delle idee riguardo all'o–
rigine dei viventi.
La tradizione subalpina nel campo della biologia animale, tuttavia, non affondava
le proprie radici in tempi lontani e non era paragonabile, come sviluppo e importanza,
a quella di altri stati italiani ed europei, nonostante che i duchi e i re di casa Savoia
avessero riservato da sempre una grande attenzione al mondo animale. In particolare,
poi, l'insegnamento della Zoologia e le relative ricerche, in mancanza di una cattedra
universitaria specifica, risultavano affidati a botanici o a medici
3
.
l
Filippo De Filippi nacque a Milano il 20 aprile
1814. Si laureò in medicina all'Università di Pavia. Ritor–
nato a Milano e abbandonata la medicina, si dedicò alle
scienze naturali. Dopo una breve permanenza presso il
museo di Storia naturale, ritornò a Pavia, nel 1842, come
assistente alla cattedra di scienze naturali per rientrare
infine al Museo di Milano. Nel 1847
fu
chiamato a Torino
sulla cattedra di zoologia dell'Università. Membro del
Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, si prodigò
per l'introduzione dell'insegnamento della storia naturale
nelle scuole secondarie del Regno sardo e poi in quello
d'Italia. Per la sua chiara fama venne nominato senatore
del Regno sardo. Morì ad Hong Kong, durante
il
viaggio
della
Magenta,
il
9 febbraio 1867.
2
Giuseppe Gené nacque a Turbigo il 9 dicembre
1800. Laureatosi a Pavia, entrò nel 1827 nel locale museo
di Storia naturale come aiuto naturalista, per passare, nel
183 1, sulla cattedra di Zoologia dell'Università di Torino.
Fu entomologo, ornitologo ed erpetologo di fama.
A
lui si
deve la prima descrizione scientifica del falco della
Regina
e del
Papi/io hospiton,
lepidottero endemico della Sarde–
gna. Morì a Torino
il
14 luglio 1847.
.
3
Si tratta, in successione cronologica, di Vitaliano
Donati (1717-1762), di Carlo Allioni (1728-1804), di Gio–
vanni Pietro Dana (1736-1801), di Michele Spirito Giorna
(1741·1809). Si vedano MICHELE LESSONA,
Degli studi
zoologici in Piemonte,
in "Annuario
R.
Università degli
Studi di Torino» , 1877, 55 pp.; TIRSI MAIUO CAFFARATTO,
Medici botanici dell'Università di Torino,
in "Studi Pie–
montesi», marzo 1974, voI. III, fase. l , pp. 110-120.
247


















