
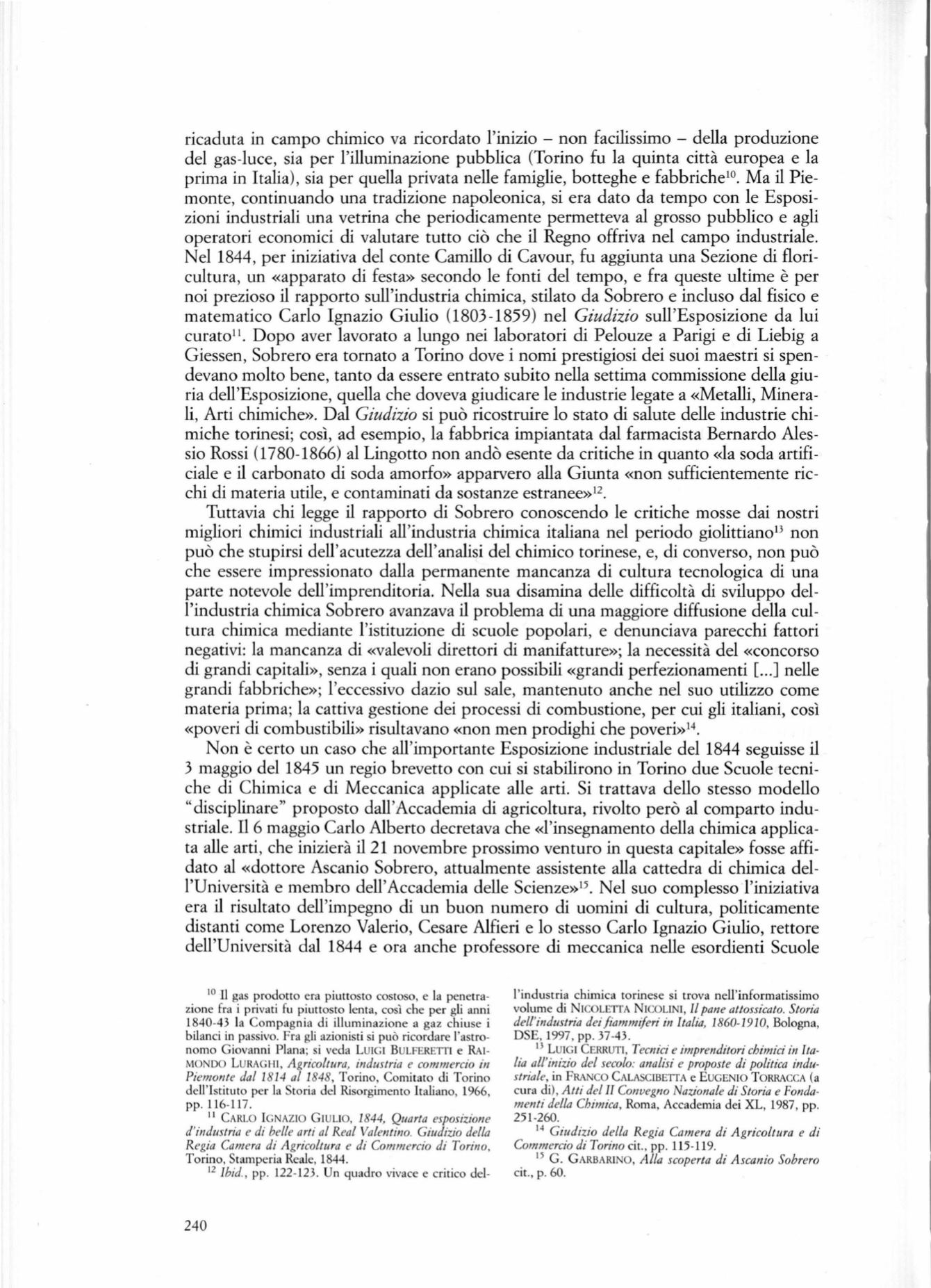
ricaduta in campo chimico va ricordato l'inizio - non facilissimo - della produzione
del gas-luce, sia per l'illuminazione pubblica (Torino fu la quinta città europea e la
prima in Italia) , sia per quella privata nelle famiglie, botteghe e fabbriche 1o . Ma il Pie–
monte, continuando una tradizione napoleonica, si era dato da tempo con le Esposi–
zioni industriali una vetrina che periodicamente permetteva al grosso pubblico e agli
operatori economici di valutare tutto ciò che il Regno offriva nel campo industriale.
Nel 1844 , per iniziativa del conte Camillo di Cavour, fu aggiunta una Sezione di flori–
cultura, un «apparato di festa» secondo le fonti del tempo, e fra queste ultime è per
noi prezioso il rapporto sull'industria chimica, stilato da Sobrero e incluso dal fisico e
matematico Carlo Ignazio Giulio (1803-1859) nel
Giudizio
sull'Esposizione da lui
curatolI. Dopo aver lavorato a lungo nei laboratori di Pelouze a Parigi e di Liebig a
Giessen, Sobrero era tornato a Torino dove i nomi prestigiosi dei suoi maestri si spen–
devano molto bene, tanto da essere entrato subito nella settima commissione della giu–
ria dell'Esposizione, quella che doveva giudicare le industrie legate a «Metalli, Minera–
li, Arti chimiche». Dal
Giudizio
si può ricostruire lo stato di salute delle industrie chi–
miche torinesi; cosÌ, ad esempio, la fabbrica impiantata dal farmacista Bernardo Ales–
sio Rossi (1780-1866) al Lingotto non andò esente da critiche in quanto «la soda artifi–
ciale e
il
carbonato di soda amorfo» apparvero alla Giunta «non sufficientemente ric–
chi di materia utile, e contaminati da sostanze estranee»12.
Tuttavia chi legge
il
rapporto di Sobrero conoscendo le critiche mosse dai nostri
migliori chimici industriali all'industria chimica italiana nel periodo giolittiano
13
non
può che stupirsi dell' acutezza dell' analisi del chimico torinese, e, di converso, non può
che essere impressionato dalla permanente mancanza di cultura tecnologica di una
parte notevole dell'imprenditoria. Nella sua disamina delle difficoltà di sviluppo del–
l'industria chimica Sobrero avanzava il problema di una maggiore diffusione della cul–
tura chimica mediante l'istituzione di scuole popolari, e denunciava parecchi fattori
negativi: la mancanza di «valevoli direttori di manifatture»; la necessità del «concorso
di grandi capitali», senza i quali non erano possibili «grandi perfezionamenti
L.. ]
nelle
grandi fabbriche»; l'eccessivo dazio sul sale, mantenuto anche nel suo utilizzo come
materia prima; la cattiva gestione dei processi di combustione, per cui gli italiani, cosÌ
«poveri di combustibili» risultavano «non men prodighi che poveri»14.
Non è certo un caso che all'importante Esposizione industriale del 1844 seguisse il
3 maggio del 1845 un regio brevetto con cui si stabilirono in Torino due Scuole tecni–
che di Chimica e di Meccanica applicate alle arti. Si trattava dello stesso modello
"disciplinare" proposto dall'Accademia di agricoltura, rivolto però al comparto indu–
striale.
il
6 maggio Carlo Alberto decretava che <d'insegnamento della chimica applica–
ta alle arti, che inizierà il21 novembre prossimo venturo in questa capitale» fosse affi–
dato al «dottore Ascanio Sobrero, attualmente assistente alla cattedra di chimica del–
l'Università e membro dell'Accademia delle Scienze»15. Nel suo complesso l'iniziativa
era il risultato dell'impegno di un buon numero di uomini di cultura, politicamente
distanti come Lorenzo Valerio, Cesare Alfieri e lo stesso Carlo Ignazio Giulio, rettore
dell 'Università dal 1844 e ora anche professore di meccanica nelle esordienti Scuole
IO
li
gas prodotto era piuttosto costoso, e la penetra–
zione fra i privati fu piuttosto lenta, così che per gl.i anni
1840-43
la Compagnia di illuminazione a gaz chiuse i
bilanci in passivo. F ra gl.i azionisti si può ricordare l'astro–
nomo Giovanni P lana; si veda LUIGI BULFERETII e RAI–
MO DO LURAGH I,
Agricoltura, industria e commercio in
Piemonte dal
18 14
al
1848, Torino, Comitato di Torino
dell'Istituto per la Sto ria del Risorgimento Italiano,
1966,
pp.
116-117.
Il
CARLO IGNAZIO GIULIO, 1844,
Quarta esposizione
d'industria e di belle arti al Real Valentino. Giudizio della
Regia Camera di Agricoltura e di Commercio di Torino ,
Torino, Stamperia Reale,
1844.
12
Ibid.,
pp.
122- 123.
Un quadro vivace e critico del-
240
l'i ndustria chimica torinese si trova nell'informatissimo
volume di NICOLETIA N ICOLl
l,
Il pane attossicato. Storia
dell'industria dei fiammiferi in Italia, 1860- 1910,
Bologna,
DSE, 1997,
pp.
37-43.
U
LUIGI CERRUTI,
Tecnici e imprenditori chimici in Ita–
lia all'inizio del secolo: analisi e proposte di politica indu–
striale,
in FRA CO CALASCIBETIA e EUGENIO TORRACCA (a
cura di),
Atti del II Convegno Nazionale di Storia e Fonda–
menti della Chimica,
Roma, Accademia dei
XL,
1987,
pp.
251 -260.
14
Giudizio della Regia Camera di Agricoltura e di
Commercio di Torino
cit., pp.
115-119.
15
G. G ARBARINO,
Alla scoperta di Ascanio Sobrero
cit., p.
60.


















