
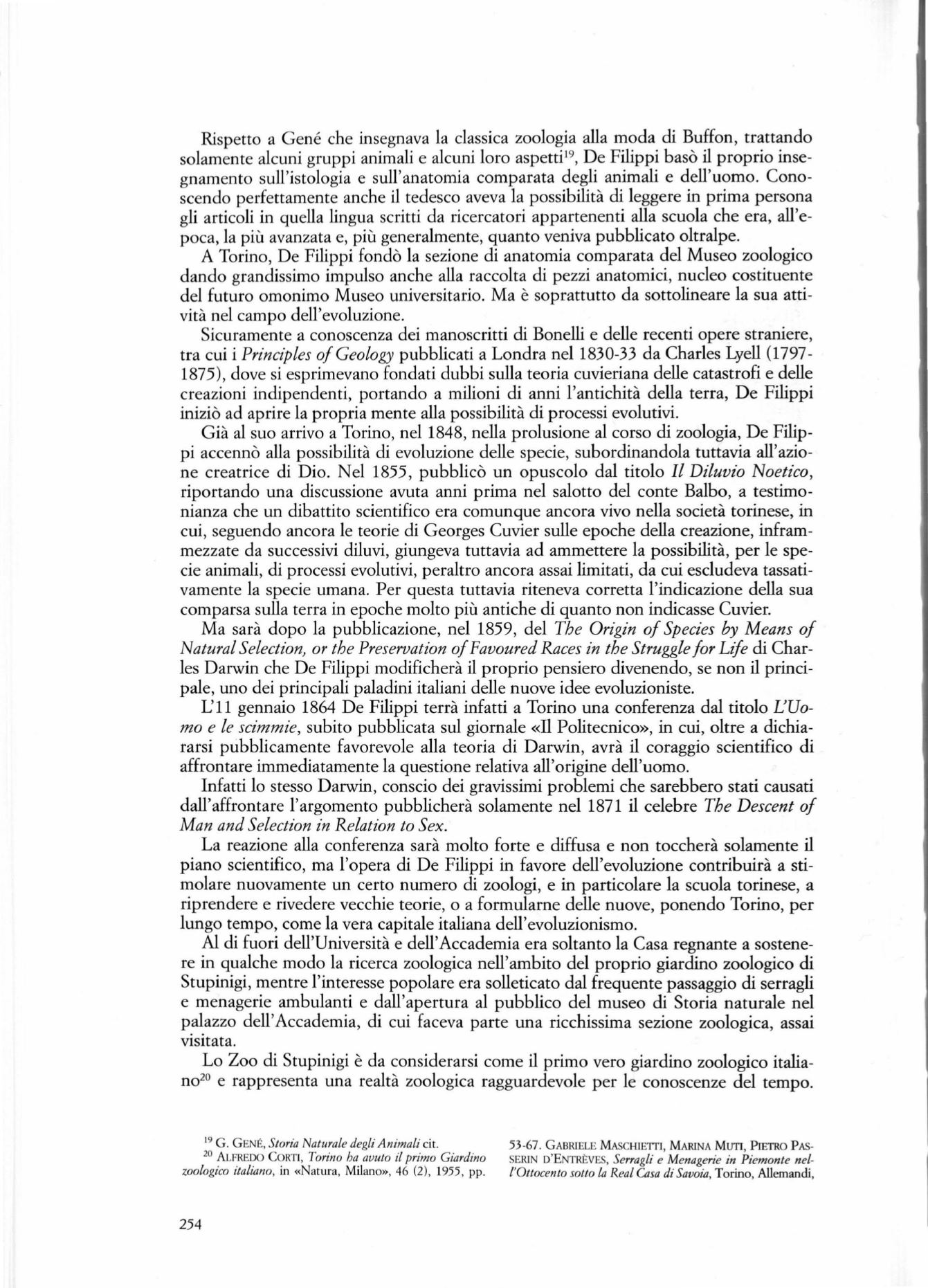
Rispetto a Gené che insegnava la classica zoologia alla moda di Buffon, trattando
solamente alcuni gruppi animali e alcuni loro aspetti
' 9 ,
De Filippi basò il proprio inse–
gnamento sull'istologia e sull'anatomia comparata degli animali e dell'uomo. Cono–
scendo perfettamente anche il tedesco aveva la possibilità di leggere in prima persona
gli articoli in quella lingua scritti da ricercatori appartenenti alla scuola che era, all'e–
poca, la più avanzata e, più generalmente, quanto veniva pubblicato oltralpe.
A Torino, De Filippi fondò la sezione di anatomia comparata del Museo zoologico
dando grandissimo impulso anche alla raccolta di pezzi anatomici, nucleo costituente
del futuro omonimo Museo universitario. Ma è soprattutto da sottolineare la sua atti–
vità nel campo dell'evoluzione.
Sicuramente a conoscenza dei manoscritti di Bonelli e delle recenti opere straniere,
tra cui i
Principles 01 Geology
pubblicati a Londra nel 1830-33 da Charles Lyell (1797-
1875), dove si esprimevano fondati dubbi sulla teoria cuvieriana delle catastrofi e delle
creazioni indipendenti, portando a milioni di anni l'antichità della terra, De Filippi
iniziò ad aprire la propria mente alla possibilità di processi evolutivi.
Già al suo arrivo a Torino, nel 1848, nella prolusione al corso di zoologia, De Filip–
pi accennò alla possibilità di evoluzione delle specie, subordinandola tuttavia all'azio–
ne creatrice di Dio. Nel 1855, pubblicò un opuscolo dal titolo
Il Diluvio
No
etico
,
riportando una discussione avuta anni prima nel salotto del conte Balbo, a testimo–
nianza che un dibattito scientifico era comunque ancora vivo nella società torinese, in
cui, seguendo ancora le teorie di Georges Cuvier sulle epoche della creazione, infram–
mezzate da successivi diluvi, giungeva tuttavia ad ammettere la possibilità, per le spe–
cie animali, di processi evolutivi, peraltro ancora assai limitati, da cui escludeva tassati–
vamente la specie umana. Per questa tuttavia riteneva corretta l'indicazione della sua
comparsa sulla terra in epoche molto più antiche di quanto non indicasse Cuvier.
Ma sarà dopo la pubblicazione, nel 1859, del
The Orlg,in olSpecies
by
Means 01
NaturalSelection, or the Preservation 01Favoured Races in the Struggle lor Llfe
di Char–
les Darwin che De Filippi modificherà il proprio pensiero divenendo, se non il princi–
pale, uno dei principali paladini italiani delle nuove idee evoluzioniste.
L'11 gennaio 1864 De Filippi terrà infatti a Torino una conferenza dal titolo
L'Uo–
mo e le scimmie,
subito pubblicata sul giornale «Il Politecnico», in cui, oltre a dichia–
rarsi pubblicamente favorevole alla teoria di Darwin, avrà il coraggio scientifico di
affrontare immediatamente la questione relativa all'origine dell'uomo.
Infatti lo stesso Darwin, conscio dei gravissimi problemi che sarebbero stati causati
dall'affrontare l'argomento pubblicherà solamente nel 1871 il celebre
The Descent 01
Man and Selection in Relation to Sex.
La reazione alla conferenza sarà molto forte e diffusa e non toccherà solamente il
piano scientifico, ma l'opera di De Filippi in favore dell'evoluzione contribuirà a sti–
molare nuovamente un certo numero
di
zoologi, e in particolare la scuola torinese, a
riprendere e rivedere vecchie teorie, o a formularne delle nuove, ponendo Torino, per
lungo tempo, come la vera capitale italiana dell'evoluzionismo.
Al di fuori dell'Università e dell'Accademia era soltanto la Casa regnante a sostene–
re in qualche modo la ricerca zoologica nell' ambito del proprio giardino zoologico
di
Stupinigi, mentre l'interesse popolare era solleticato dal frequente passaggio di serragli
e menagerie ambulanti e dall' apertura al pubblico del museo di Storia naturale nel
palazzo dell'Accademia,
di
cui faceva parte una ricchissima sezione zoologica, assai
visitata.
Lo Zoo di Stupinigi è da considerarsi come il primo vero giardino zoologico italia–
n0
20
e rappresenta una realtà zoologica ragguardevole per le conoscenze del tempo.
19
G. GENÉ,
Storia Naturale degli Animali
cito
20
ALFREDO
CORTI,
Torino ha avuto il pn'mo Giardino
zoologico italiano,
in «Natura, Milano», 46 (2),
1955,
pp.
254
53-67. GABRIELE MASCHlETTI, MARINA MUTI, PIETRO PAS–
SERIN D'ENTRÈVES,
Serragli e Menagerie in Piemonte nel–
l'Ottocento sotto la Real Casa di Savoia,
Torino, Allemandi,


















