
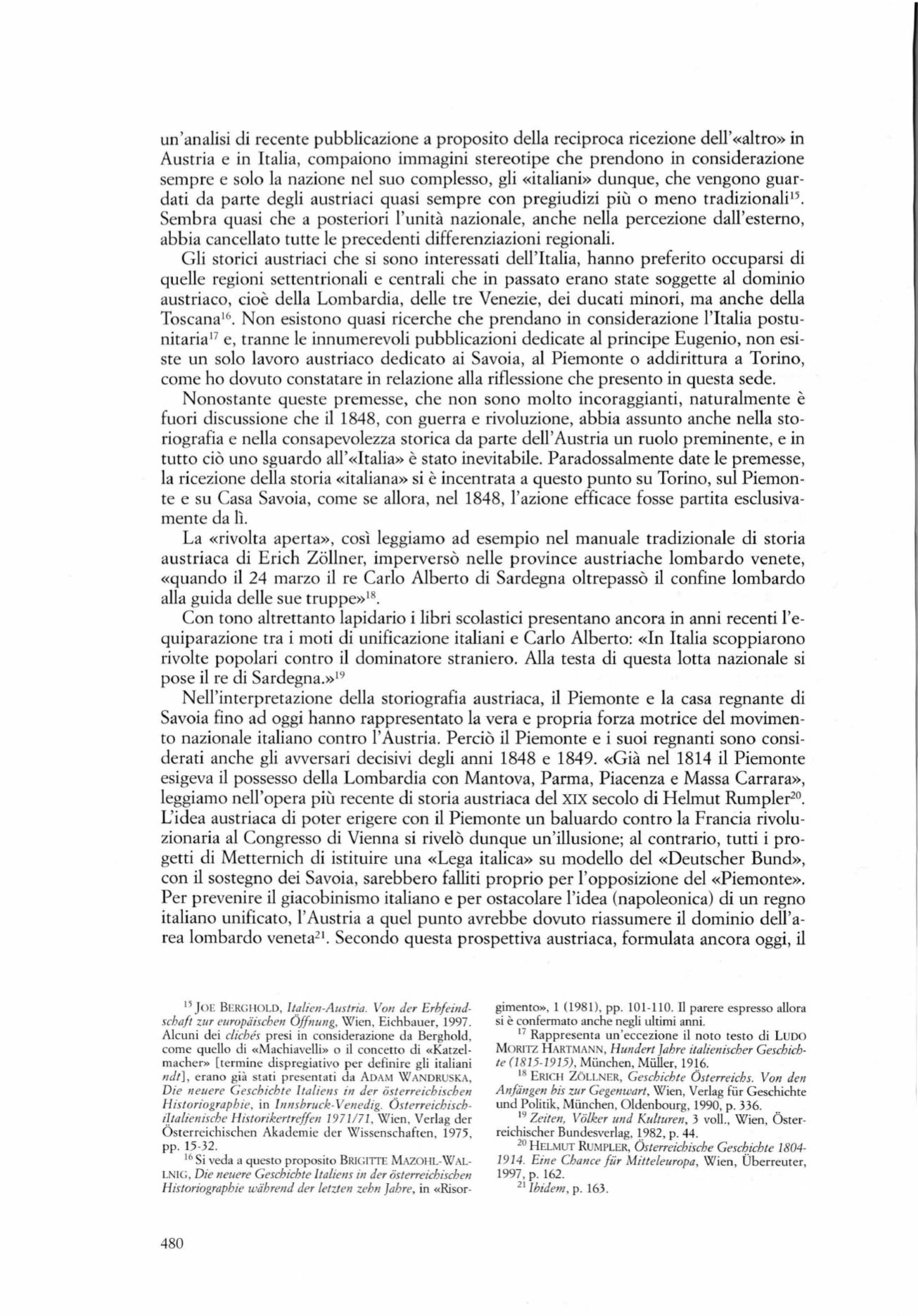
un' analisi di recente pubblicazione a proposito della reciproca ricezione dell'«altro» in
Austria e in Italia, compaiono immagini stereotipe che prendono in considerazione
sempre e solo la nazione nel suo complesso, gli «italiani» dunque, che vengono guar–
dati da parte degli austriaci quasi sempre con pregiudizi più o meno tradizionaliJ
5 .
Sembra quasi che a posteriori l'unità nazionale, anche nella percezione dall'esterno,
abbia cancellato tutte le precedenti differenziazioni regionali.
Gli storici austriaci che si sono interessati dell'Italia, hanno preferito occuparsi di
quelle regioni settentrionali e centrali che in passato erano state soggette al dominio
austriaco, cioè della Lombardia, delle tre Venezie, dei ducati minori, ma anche della
Toscana l
6 .
Non esistono quasi ricerche che prendano in considerazione l'Italia postu–
nitaria l7 e, tranne le innumerevoli pubblicazioni dedicate al principe Eugenio, non esi–
ste un solo lavoro austriaco dedicato ai Savoia, al Piemonte o addirittura a Torino,
come ho dovuto constatare in relazione alla riflessione che presento in questa sede.
Nonostante queste premesse, che non sono molto incoraggianti, naturalmente è
fuori discussione che il
1848,
con guerra e rivoluzione, abbia assunto anche nella sto–
riografia e nella consapevolezza storica da parte dell'Austria un ruolo preminente, e in
tutto ciò uno sguardo all' «Italia» è stato inevitabile. Paradossalmente date le premesse,
la ricezione della storia «italiana» si è incentrata a questo punto su Torino, sul Piemon–
te e su Casa Savoia, come se allora, nel
1848,
l'azione efficace fosse partita esclusiva–
mente da
lì.
La «rivolta aperta», cosÌ leggiamo ad esempio nel manuale tradizionale di storia
austriaca di Erich Zollner, imperversò nelle province austriache lombardo venete,
«quando il
24
marzo
il
re Carlo Alberto di Sardegna oltrepassò il confine lombardo
alla guida delle sue truppe»18.
Con tono altrettanto lapidario i libri scolastici presentano ancora in anni recenti l'e–
quiparazione tra i moti di unificazione italiani e Carlo Alberto: «In Italia scoppiarono
rivolte popolari contro
il
dominatore straniero. Alla testa di questa lotta nazionale si
pose il re di Sardegna.»19
Nell'interpretazione della storiografia austriaca,
il
Piemonte e la casa regnante di
Savoia fino ad oggi hanno rappresentato la vera e propria forza motrice del movimen–
to nazionale italiano contro l'Austria. Perciò
il
Piemonte e i suoi regnanti sono consi–
derati anche gli avversari decisivi degli anni
1848
e
1849.
«Già nel
1814
il Piemonte
esigeva
il
possesso della Lombardia con Mantova, Parma, Piacenza e Massa Carrara»,
leggiamo nell'opera più recente di storia austriaca del
XIX
secolo di Helmut Rumpler 20 .
L'idea austriaca di poter erigere con il Piemonte un baluardo contro la FranèÌa rivolu–
zionaria al Congresso di Vienna si rivelò dunque un'illusione; al contrario, tutti i pro–
getti di Metternich di istituire una «Lega italica» su modello del «Deutscher Bund»,
con
il
sostegno dei Savoia, sarebbero falliti proprio per l'opposizione del «Piemonte».
Per prevenire il giacobinismo italiano e per ostacolare !'idea (napoleonica) di un regno
italiano unificato, l'Austria a quel punto avrebbe dovuto riassumere
il
dominio dell'a–
rea lombardo veneta 21. Secondo questa prospettiva austriaca, formulata ancora oggi,
il
15
] OE BERGI-IOLD,
Italien-Austria. Von der Erbfeind–
schaft zur europiiischen Offnung,
Wien, Eichbauer,
1997.
Alcuni dei
clichés
presi in considerazione da Berghold ,
come quello di «Machiavelli» o il concetto di «Katzel–
macher» [termine dispregiativo per definire gli italiani
ndtl,
erano già stati presentati da ADAM WANDRUSKA,
Die neuere Geschichte Italiens in der osterreichischen
Historiographie,
in
Innsbruck- Venedig. Osterreichisch–
tftalienische Historikertreffen
1971 / 71,
Wien , Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
1975,
pp.
15 -32.
16
Si veda a questo proposito BR1GI1TE MAZOI-lL-WAL–
LN1G,
Die neuere Geschichte Italiem in der osterreichischen
Historiographie wiihrend der letzten zehn Jahre,
in «Risor-
480
gimento»,
1 (1981) ,
pp.
101-110. Il
parere espresso allora
si
è
confermato anche negli ultimi anni.
17
Rappresenta un 'eccezione il noto testo di LUDO
MOR1TZ H ARTMANN,
Hundert Jahre italienischer Geschich–
te (J 815-1915),
Miinchen, Miiller,
1916.
18
ERICH ZOLLNER,
Geschichte Osterreichs. Von den
Anfiingen bis zur Gegenwart,
Wien, Verlag fiir Geschichte
und Politik, Miinchen, Oldenbourg,
1990,
p .
336.
19
Zeiten, Volker und Kulturen,
3 voli. , Wien, Oster–
reichischer Bundesverlag,
1982,
p.
44.
20
H ELMUT RUM PLER,
Osterràchische Geschichte 1804-
19 14. Eine Chance fiir Mitteleuropa,
Wien , Uberreuter,
1997, p. 162.
21
Ibidem,
p. 163.


















