
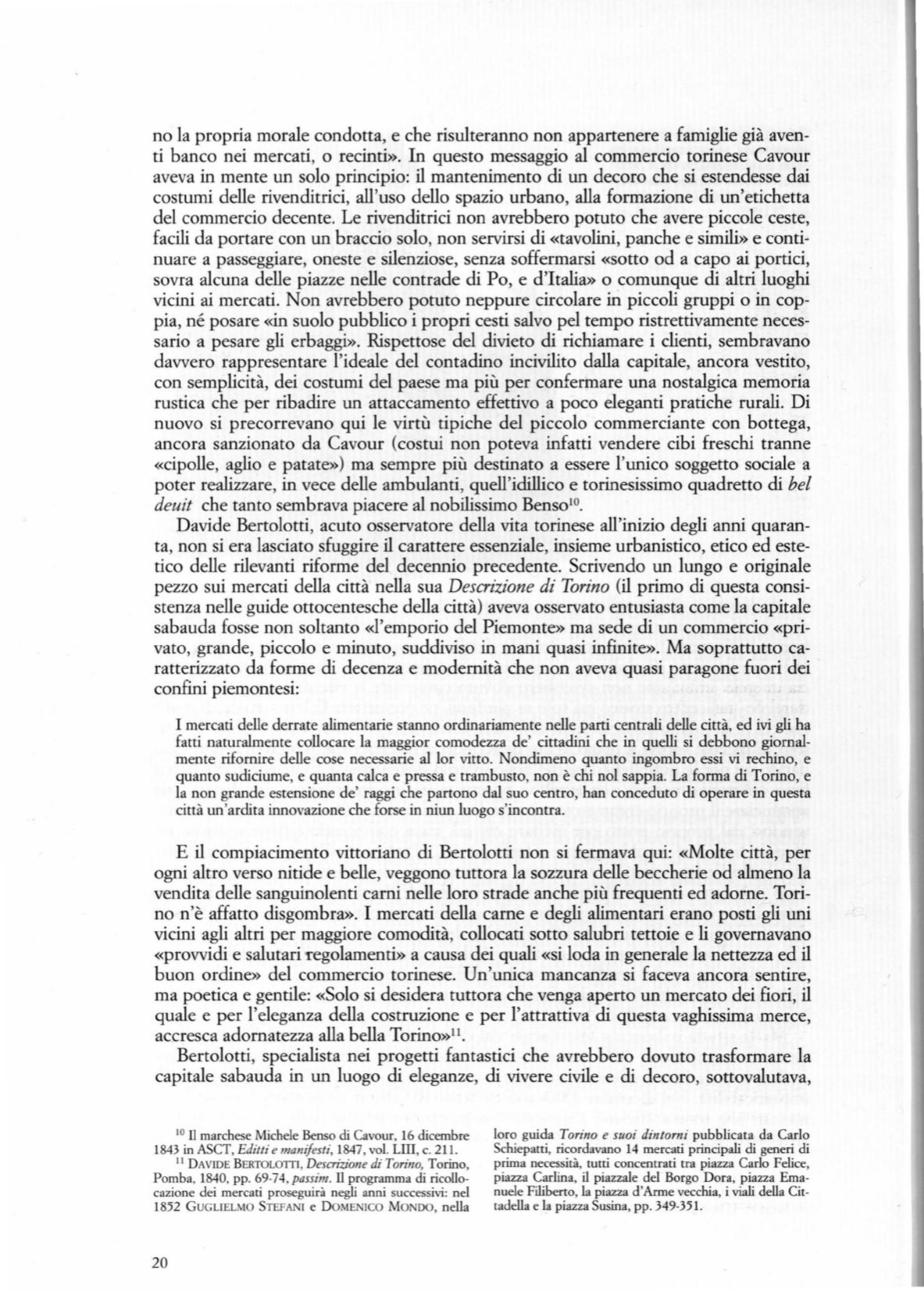
no la propria morale condotta, e che risulteranno non appartenere a famiglie già aven–
ti banco nei mercati, o recinti». In questo messaggio al commercio torinese Cavour
aveva in mente un solo principio: il mantenimento di un decoro che si estendesse dai
costumi delle rivenditrici, all'uso dello spazio urbano, alla formazione di un'etichetta
del commercio decente. Le rivenditrici non avrebbero potuto che avere piccole ceste,
facili da portare con un braccio solo, non servirsi di «tavolini, panche e simili» e conti–
nuare a passeggiare, oneste e silenziose, senza soffermarsi «sotto od a capo ai portici,
sovra alcuna delle piazze nelle contrade di Po, e d'Italia» o comunque di altri luoghi
vicini ai mercati. Non avrebbero potuto neppure circolare in piccoli gruppi o in cop–
pia, né posare «in suolo pubblico i propri cesti salvo pel tempo ristrettivamente neces–
sario a pesare gli erbaggi». Rispettose del divieto di richiamare i clienti, sembravano
davvero rappresentare l'ideale del contadino incivilito dalla capitale, ancora vestito,
con semplicità, dei costumi del paese ma più per confermare una nostalgica memoria
rustica che per ribadire un attaccamento effettivo a poco eleganti pratiche rurali. Di
nuovo si precorrevano qui le virtù tipiche del piccolo commerciante con bottega,
ancora sanzionato da Cavour (costui non poteva infatti vendere cibi freschi tranne
«cipolle, aglio e patate») ma sempre più destinato a essere l'unico soggetto sociale a
poter realizzare, in vece delle ambulanti, quell'idillico e torinesissimo quadretto di
bel
deuit
che tanto sembrava piacere al nobilissimo Benso
lO•
Davide Bertolotti, acuto osservatore della vita torinese all'inizio degli anni quaran–
ta, non si era lasciato sfuggire il carattere essenziale, insieme urbanistico, etico ed este–
tico delle rilevanti riforme del decennio precedente. Scrivendo un lungo e originale
pezzo sui mercati della città nella sua
Descrizione di Torino
(il primo di questa consi–
stenza nelle guide ottocentesche della città) aveva osservato entusiasta come la capitale
sabauda fosse non soltanto «l'emporio del Piemonte» ma sede di un commercio «pri–
vato, grande, piccolo e minuto, suddiviso in mani quasi infinite». Ma soprattutto ca–
ratterizzato da forme di decenza e modernità che non aveva quasi paragone fuori dei
confini piemontesi:
I
mercati delle derrate alimentarie stanno ordinariamente nelle parti centrali delle città, ed ivi gli ha
fatti naturalmente collocare la maggior comodezza de' cittadini che in quelli si debbono giornal–
mente rifornire delle cose necessarie al lor vitto. Nondimeno quanto ingombro essi vi rechino, e
quanto sudiciume, e quanta calca e pressa e trambusto, non è chi noI sappia. La forma
di
Torino, e
la non grande estensione de' raggi che partono dal suo centro, han conceduto di operare in questa
città un'ardita innovazione che forse in niun luogo s'incontra.
E il compiacimento vittoriano di Bertolotti non si fermava qui: «Molte città, per
ogni altro verso nitide e belle, veggono tuttora la sozzura delle beccherie od almeno la
vendita delle sanguinolenti carni nelle loro strade anche più frequenti ed adorne. Tori–
no n'è affatto disgombra». I mercati della carne e degli alimentari erano posti gli uni
vicini agli altri per maggiore comodità, collocati sotto salubri tettoie e li governavano
«provvidi e salutari r egolamenti» a causa dei quali «si loda in generale la nettezza ed il
buon ordine» del commercio torinese. Un'unica mancanza si faceva ancora sentire,
ma poetica e gentile: «Solo si desidera tuttora che venga aperto un mercato dei fiori, il
quale e per l'eleganza della costruzione e per l'attrattiva
di
questa vaghissima merce,
accresca adornatezza alla bella Torino»ll .
Bertolotti, specialista nei progetti fantastici che avrebbero dovuto trasformare la
capitale sabauda in un luogo
di
eleganze,
di
vivere civile e
di
decoro, sottovalutava,
lO
TI marchese Michele Benso
di
Cavour, 16 dicembre
1843
in
ASCT,
Editti e mamf esti,
1847, voI. LIII, c. 211.
loro guida
Torino e suoi dintorni
pubblicata da Carlo
Schiepatti, ricordavano 14 mercati principali di generi di
prima necessità, tutti concentrati tra piazza Carlo Felice,
piazza Carlina,
il
piazzale del Borgo Dora, piazza Ema–
nuele Filiberto, la piazza d 'Arme vecchia, i viali della Cit–
tadella e la piazza Susina, pp. 349-351.
Il
DAVIDE BERTOLOIT1,
Descrizione di Torino,
Torino,
Pomba, 1840, pp. 69-74,
passim.
TI programma
di
ricollo–
cazione dei mercati proseguirà negli anni successivi: nel
1852 GUGLIELMO STEFANI e DOMENICO MONDO, nella
20


















