
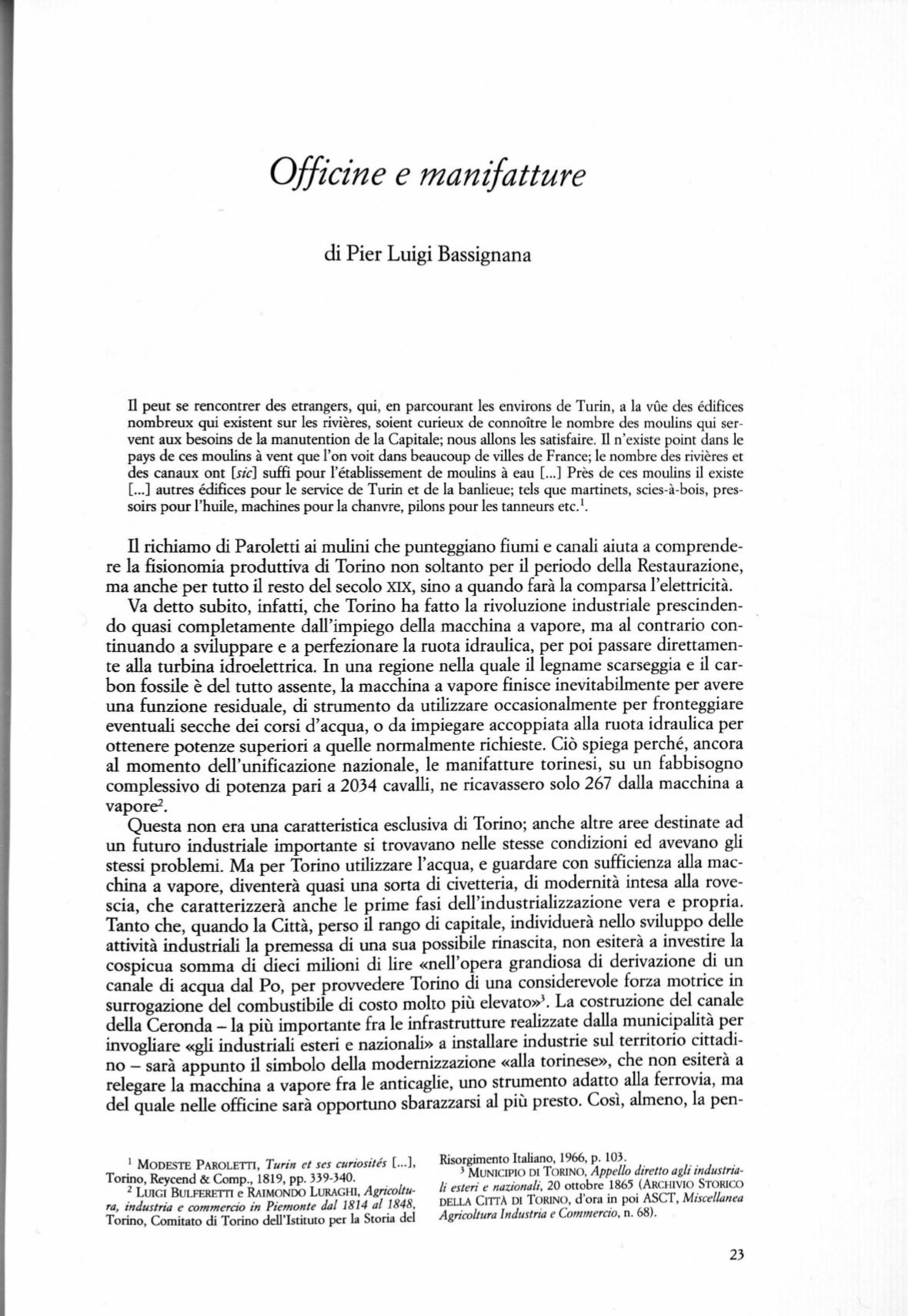
Officine e manzfatture
di Pier Luigi Bassignana
TI peut se rencontrer des etrangers, qui, en parcourant les environs de Turin, a la vue des édifices
nombreux qui existent sur les rivières, soient curieux de connoltre le nombre des moulins qui ser–
vent aux besoins de la manutention de la Capitale; nous allons les satisfaire. TI n'existe point dans le
pays de ces moulins
à
vent que l'on voit dans beaucoup de villes de France; le nombre des rivières et
des canaux ont
[sic]
suffi pour l'établissement de moulins à eau [. ..] Près de ces moulins il existe
[...] autres édifices pour le service de Turin et de la banlieue; tels que martinets, scies-à-bois, pres–
soirs pour l'huile, machines pour la chanvre, pilons pour les tanneurs etc.
l .
TI richiamo di Paroletti ai mulini che punteggiano fiumi e canali aiuta a comprende–
re la fisionomia produttiva di Torino non soltanto per il periodo della Restaurazione,
ma anche per tutto il resto del secolo
XIX,
sino a quando farà la comparsa l'elettricità.
Va detto subito, infatti, che Torino ha fatto la rivoluzione industriale prescinden–
do quasi completamente dall'impiego della macchina a vapore, ma al contrario con–
tinuando a sviluppare e a perfezionare la ruota idraulica, per poi passare direttamen–
te alla turbina idroelettrica. In una regione nella quale il legname scarseggia e il car–
bon fossile
è
del tutto assente, la macchina a vapore finisce inevitabilmente per avere
una funzione residuale, di strumento da utilizzare occasionalmente per fronteggiare
eventuali secche dei corsi d'acqua, o da impiegare accoppiata alla ruota idraulica per
ottenere potenze superiori a quelle normalmente richieste. Ciò spiega perché, ancora
al momento dell'unificazione nazionale, le manifatture torinesi, su un fabbisogno
complessivo di potenza pari a
2034
cavalli, ne ricavassero solo 267 dalla macchina a
vapore2.
Questa non era una caratteristica esclusiva di Torino; anche altre aree destinate ad
un futuro industriale importante si trovavano nelle stesse condizioni ed avevano gli
stessi problemi. Ma per Torino utilizzare l'acqua, e guardare con sufficienza alla mac–
china a vapore, diventerà quasi una sorta di civetteria, di modernità intesa alla rove–
scia, che caratterizzerà anche le prime fasi dell'industrializzazione vera e propria.
Tanto che, quando la Città, perso il rango di capitale, individuerà nello sviluppo delle
attività industriali la premessa di una sua possibile rinascita, non esiterà a investire la
cospicua somma di dieci milioni di lire «nell'opera grandiosa di derivazione di un
canale di acqua dal Po, per provvedere Torino di una considerevole forza motrice in
surrogazione del combustibile di costo molto più elevato»3. La costruzione del canale
della Ceronda -la più importante fra le infrastrutture realizzate dalla municipalità per
invogliare «gli industriali esteri e nazionali» a installare industrie sul territorio cittadi–
no - sarà appunto il simbolo della modernizzazione «alla torinese», che non esiterà a
relegare la macchina a vapore fra le anticaglie, uno strumento adatto alla ferrovia , ma
del quale nelle officine sarà opportuno sbarazzarsi al più presto. Così, almeno, la pen-
l
MODESTE PAROLETII,
Turin et ses curiosités
[...
l,
Torino, Reycend
&
Comp., 1819, pp. 339-340.
2
LUIGI
BULFERETTI e
RAIMONDO LURAGH1,
Agricoltu–
ra, industria e commercio in Piemonte dal
1814
al 1848,
Torino, Comitato
di
Torino dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, 1966, p. 103.
J
MUNICIPIO
DI
TORINO,
Appello diretto agli industria–
li esteri e nazionali,
20
ottobre 1865 (ARCHIVIO STORICO
DELLA CITTA
DI
TORINO, d'ora in poi ASCT,
Miscellanea
Agricoltura Industria e Commercio,
n.
68).
23


















