
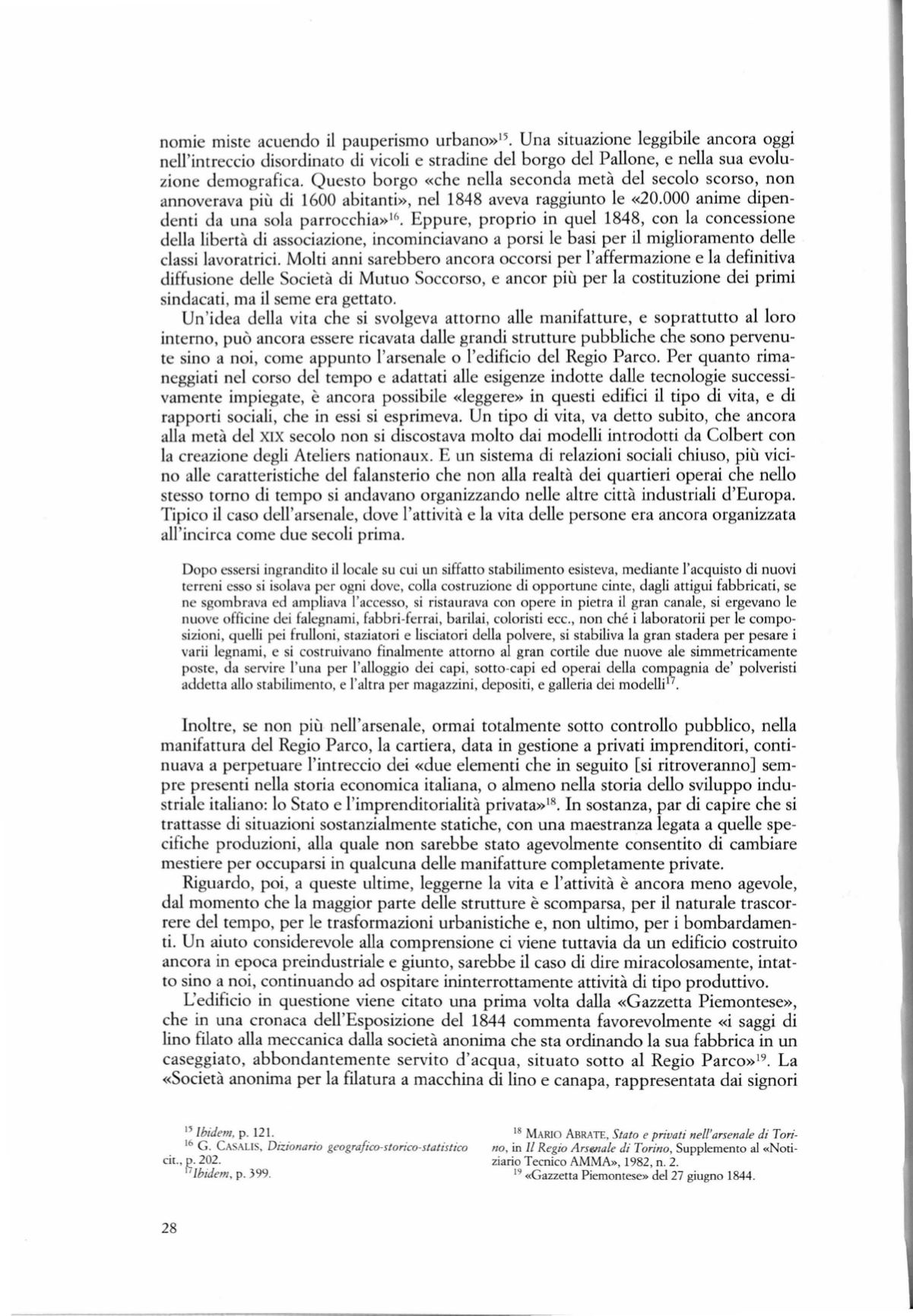
nomie miste acuendo il pauperismo urbano»1 5. Una situazione leggibile ancora oggi
nell 'intreccio disordinato di vicoli e stradine del borgo del Pallone, e nella sua evolu–
zione demografica. Questo borgo «che nella seconda metà del secolo scorso, non
annoverava più di 1600 abitanti», nel 1848 aveva raggiunto le «20.000 anime dipen–
denti da una sola parrocchia»16. Eppure, proprio in quel 1848, con la concessione
della libertà di associazione, incominciavano a porsi le basi per il miglioramento delle
classi lavoratrici. Molti anni sarebbero ancora occorsi per l'affermazione e la definitiva
diffusione delle Società di Mutuo Soccorso, e ancor più per la costituzione dei primi
sindacati, ma il seme era gettato.
Un 'idea della vita che si svolgeva attorno alle manifatture, e soprattutto alloro
interno, può ancora essere ricavata dalle grandi strutture pubbliche che sono pervenu–
te sino a noi, come appunto l'arsenale o l'edificio del Regio Parco. Per quanto rima–
neggiati nel corso del tempo e adattati alle esigenze indotte dalle tecnologie successi–
vamente impiegate,
è
ancora possibile «leggere» in questi edifici il tipo di vita, e di
rapporti sociali, che in essi si esprimeva. Un tipo di vita, va detto subito, che ancora
alla metà del
XIX
secolo non si discostava molto dai modelli introdotti da Colbert con
la creazione degli Ateliers nationaux. E un sistema di relazioni sociali chiuso, più vici–
no alle caratteristiche del falansterio che non alla realtà dei quartieri operai che nello
stesso torno di tempo si andavano organizzando nelle altre città industriali d'Europa.
Tipico il caso dell' arsenale, dove l'attività e la vita delle persone era ancora organizzata
all 'incirca come due secoli prima.
Dopo e sersi ingrandito
il
locale su cui un siffatto stabilimento esisteva, mediante l'acquisto di nuovi
terreni esso si isolava per ogni dove, colla costruzione
di
opportune cinte, dagli attigui fabbricati, se
ne sgombrava ed ampliava l'accesso, si ristaurava con opere in pietra
il
gran canale, si ergevano le
nuove officine dei falegnami, fabbri-ferrai, barilai, coloristi ecc., non ché i laboratorii per le compo–
sizioni , quelli pei frulloni, staziatori e lisciatori della polvere, si stabiliva la gran stadera per pesare i
varii legnami, e si costruivano finalmente attorno al gran cortile due nuove ale simmetricamente
poste, da servire l' una per l'alloggio dei capi, sotto-capi ed operai della compagnia de' polveristi
addetta allo stabilimento, e l'altra per magazzini, depositi, e galleria dei modelli
l7 .
Inoltre, se non più nell'arsenale, ormai totalmente sotto controllo pubblico, nella
manifattura del Regio Parco, la cartiera, data in gestione a privati imprenditori, conti–
nuava a perpetuare l'intreccio dei «due elementi che in seguito [si ritroveranno] sem–
pre presenti nella storia economica italiana, o almeno nella storia dello sviluppo indu–
striale italiano: lo Stato e l'imprenditorialità privata»18. In sostanza, par di capire che si
trattasse di situazioni sostanzialmente statiche, con una maestranza legata a quelle spe–
cifiche produzioni, alla quale non sarebbe stato agevolmente consentito di cambiare
mestiere per occuparsi in qualcuna delle manifatture completamente private.
Riguardo, poi, a queste ultime, leggerne la vita e l'attività
è
ancora meno agevole,
dal momento che la maggior parte delle strutture
è
scomparsa, per il naturale trascor–
rere del tempo, per le trasformazioni urbanistiche e, non ultimo, per i bombardamen–
ti. Un aiuto considerevole alla comprensione ci viene tuttavia da un edificio costruito
ancora in epoca preindustriale e giunto, sarebbe il caso di dire miracolosamente, intat–
to sino a noi, continuando ad ospitare ininterrottamente attività di tipo produttivo.
L'edificio in questione viene citato una prima volta dalla «Gazzetta Piemontese»,
che in una cronaca dell'Esposizione del 1844 commenta favorevolmente «i saggi di
lino filato alla meccanica dalla società anonima che sta ordinando la sua fabbrica in un
caseggiato , abbondantemente servito d 'acqua, situato sotto al Regio Parco»19. La
«Società anonima per la filatura a macchina di lino e canapa, rappresentata dai signori
I)
Ibidem,
p.
121.
16
G.
CASALIS,
Dizionario geografico-storico-statistico
cit.,
g.
202 .
Ibidem,
p.
399.
18
MARIo
AERATE,
Stato e privati nell'arsenale di Tori-
110,
in
Il Regio
Ars~nale
di Torino,
Supplemento
al
«Noti–
ziario Tecnico AMMA", 1982, n. 2.
19
«Gazzetta Piemontese» del 27 giugno 1844.
28


















