
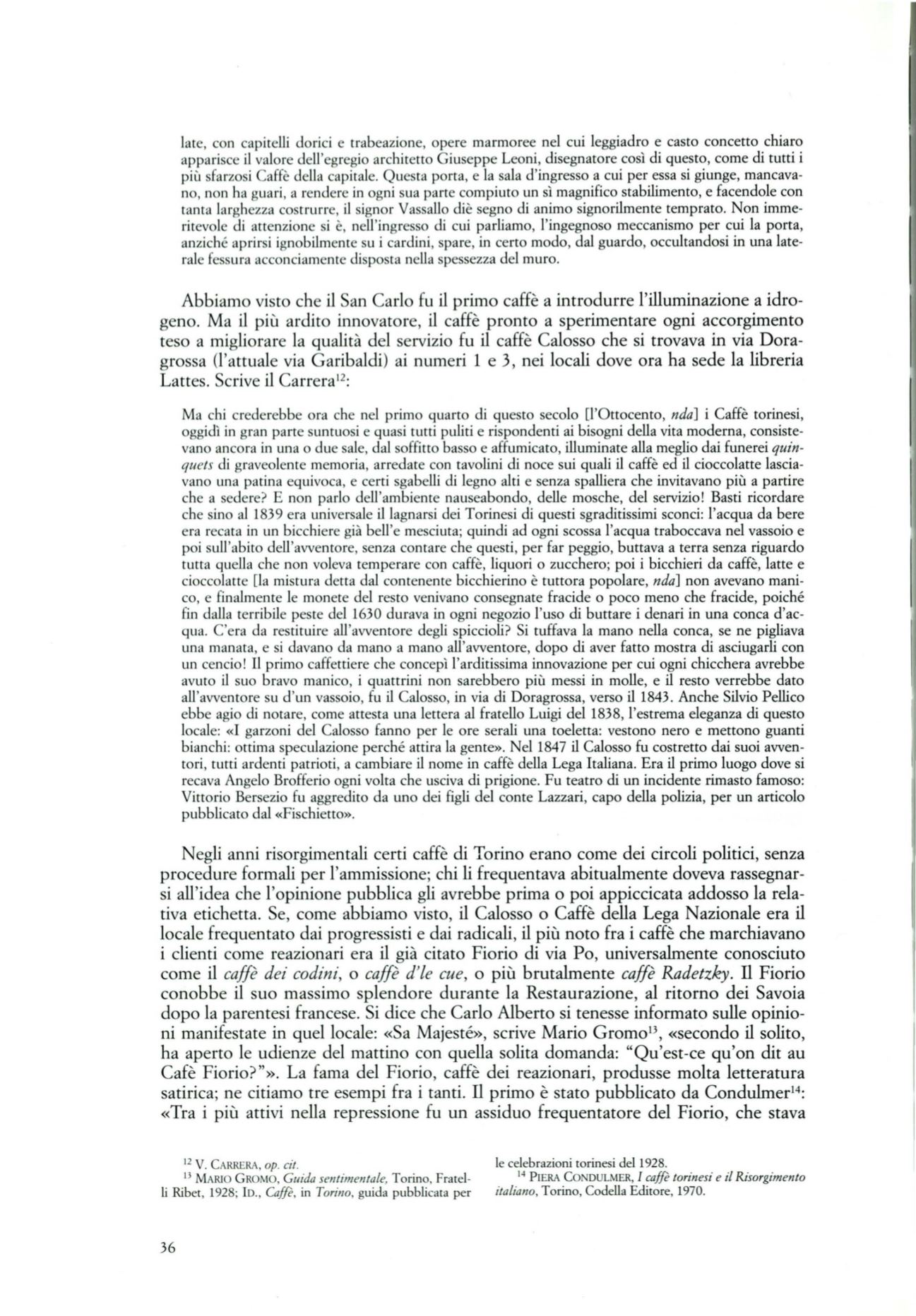
late, con cap itelli dorici e trabeazione, opere marmoree nel cui leggiadro e casto concetto chiaro
apparisce il valore deU'egregio architetto Giuseppe Leoni, disegnatore così di questo, come di tutti i
più sfarzosi Caffè della capitale. Q uesta porta, e la sala d'ingresso a cui per essa si giunge, mancava–
no, non ha guari , a rendere in ogni sua parte compiuto un sì magnifico stabilimento, e facendole con
tanta larghezza costrurre, il signor Vassallo diè segno di animo signorilmente temprato. Non imme–
ritevole di attenzione si è, nell 'ingresso di cui parliamo, l'ingegnoso meccanismo per cui la porta,
anziché aprirsi ignobilmente su i ca rdini, spare, in certo modo, dal guardo, occultandosi in una late–
rale fess ura acconciamente disposta neUa spessezza del muro.
Abbiamo visto che
il
San Carlo fu
il
primo caffè a introdurre l'illuminazione a idro–
geno. Ma
il
più ardito innovatore,
il
caffè pronto a sperimentare ogni accorgimento
teso a migliorare la qualità del servizio fu
il
caffè Calosso che si trovava in via Dora–
grossa
O'
attuale via Garibaldi) ai numeri
1
e 3, nei locali dove ora ha sede la libreria
Lattes. Scrive
il
Carrera
J2 :
Ma chi crederebbe ora che nel primo quarto di questo secolo [l'Ottocento,
nda]
i Caffè torinesi,
oggidì in gran pa rte suntuosi e quasi tutti puliti e rispondenti ai bisogni della vita moderna, consiste–
vano ancora in una o due sale, dal soffitto basso e affumicato, illuminate alla meglio dai funerei
quin–
quets
di graveolente memoria, arredate con tavolini di noce sui quali il caffè ed il cioccolatte lascia–
vano una patina equivoca, e certi sgabelli di legno alti e senza spalliera che invitavano più a partire
che a sedere? E non pa rlo dell 'ambiente nauseabondo, delle mosche, del servizio! Basti ricordare
che si no al 1839 era universale il lagnarsi dei Torinesi di questi sgraditissimi sconci: l'acqua da bere
era recata in un bicchiere già bell'e mesciuta; quindi ad ogni scossa l'acqua traboccava nel vassoio e
poi sull 'abito dell 'awentore, senza contare che questi, per far peggio, buttava a terra senza riguardo
tutta quella che non voleva temperare con caffè, liquori o zucchero; poi i bicchieri da caffè, latte e
cioccolatte [la mistura detta dal contenente bicchierino è tuttora popolare,
nda]
non avevano mani–
co, e fi nalmente le monete del resto venivano consegnate fracide o poco meno che fracide , poiché
fin dalla terribile peste del 1630 durava in ogni negozio l'uso di buttare i denari in una conca d'ac–
qua. C'era da restituire all'awentore degli spiccioli ? Si tuffava la mano nella conca, se ne pigliava
una manata, e si davano da mano a mano all'awentore, dopo di aver fatto mostra di asciugarli con
un cencio! Il primo caffettiere che concepì l'arditissima innovazione per cui ogni chicchera avrebbe
avuto il suo bravo manico, i quattrini non sarebbero più messi in molle, e il resto verrebbe dato
all'awentore su d'un vassoio, fu il Calosso, in via di Doragrossa, verso il 1843 . Anche Silvio Pellico
ebbe agio di notare, come attesta una lettera al fratello Luigi del 1838, l'estrema eleganza di questo
locale: «I garzoni del Calosso fanno per le ore serali una toeletta: vestono nero e mettono guanti
bianchi: ottima speculazione perché attira la gente». Nel 1847 il Calosso fu costretto dai suoi aw en–
tori, tutti ardenti patrioti , a cambiare il nome in caffè della Lega Italiana. Era il primo luogo dove si
recava Angelo Brofferio ogni volta che usciva di prigione. Fu teatro di un incidente rimasto famoso:
Vittorio Bersezio fu aggredito da uno dei figli del conte Lazzari, capo della polizia, per un articolo
pubblicato dal «Fischietto».
Negli anni risorgimentali certi caffè di Torino erano come dei circoli politici, senza
procedure formali per l'ammissione; chi li frequentava abitualmente doveva rassegnar–
si all'idea che l'opinione pubblica gli avrebbe prima o poi appiccicata addosso la rela–
tiva etichetta. Se, come abbiamo visto,
il
Calosso o Caffè della Lega Nazionale era
il
locale frequentato dai progressisti e dai radicali,
il
più noto fra i caffè che marchiavano
i clienti come reazionari era
il
già citato Fiorio di via Po, universalmente conosciuto
come
il
caffè dei codini,
o
caffè d'le cue,
o più brutalmente
caffè Radetzky.
li
Fiorio
conobbe
il
suo massimo splendore durante la Restaurazione , al ritorno dei Savoia
dopo la parentesi francese. Si dice che Carlo Alberto si tenesse informato sulle opinio–
ni manifestate in quel locale: «Sa Majesté», scrive Mario Gromo
13 ,
«secondo
il
solito,
ha aperto le udienze del mattino con quella solita domanda: "Qu'est-ce qu'on dit au
Cafè Fiorio?"». La fama del Fiorio, caffè dei reazionari, produsse molta letteratura
satirica; ne citiamo tre esempi fra i tanti.
li
primo è stato pubblicato da Condulmer
l4 :
«Tra i più attivi nella repressione fu un assiduo frequentatore del Fiorio, che stava
12
V.
CARRERA,
op.
cit.
l}
M ARIO GROMO,
Guida sentimentale,
Torino, Fratel–
li Ribet, 1928; ID. ,
Caffè,
in
Torino,
guida pubblicata per
36
le celebrazioni torinesi del 1928.
14
PIERA
Co
DULMER,
I caffè torinesi e il Risorgimento
italiano,
Torino, Codella Editore, 1970.


















