
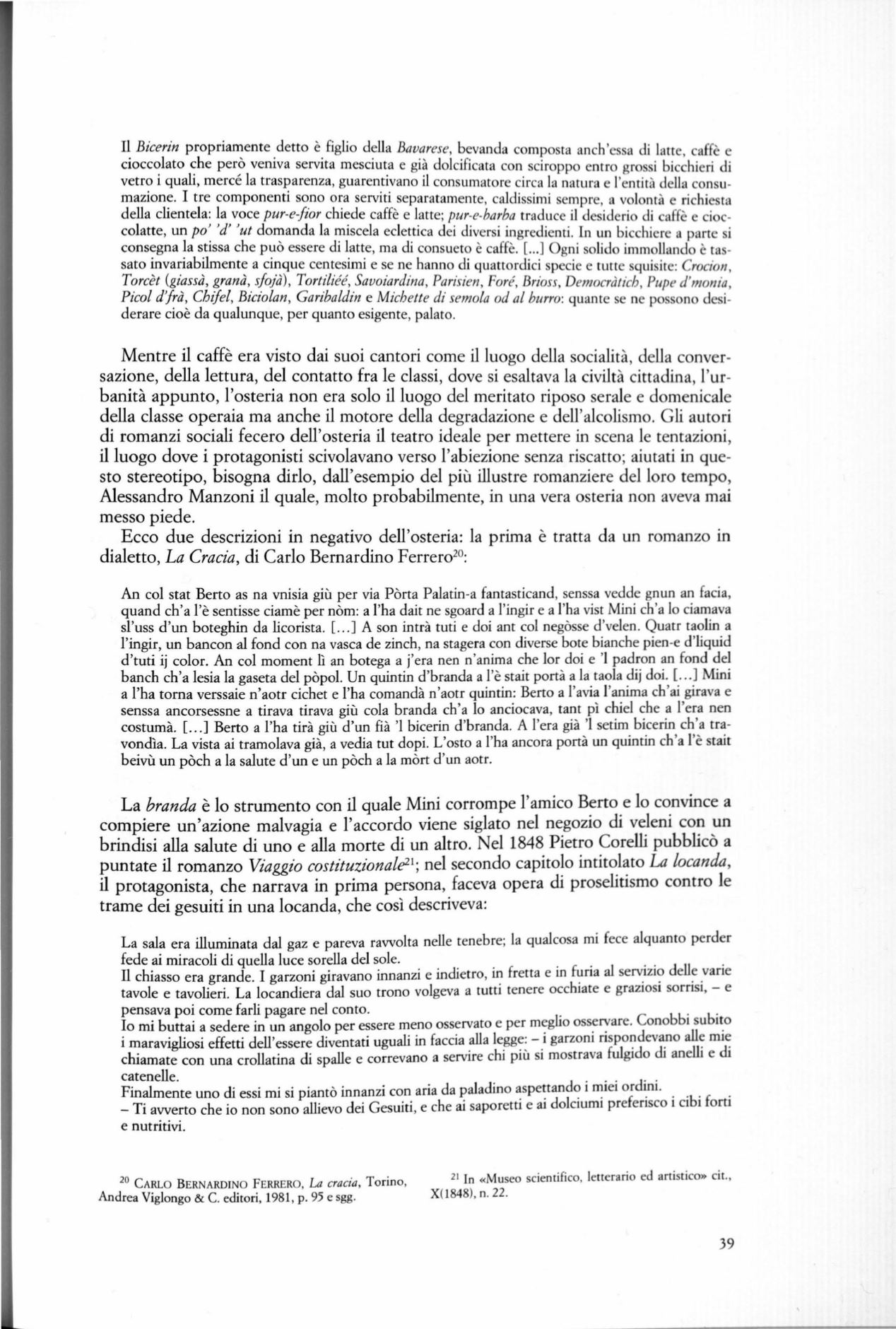
li
Bicerin
propriamente detto è figlio della
Bavarese,
bevanda composta anch'e a di latte, caffè e
cioccolato che però veniva servita mesciuta e già dolcificata con sciroppo entro gr si bicchieri di
vetro i quali, mercé la trasparenza, guarentivano
il
consumatore circa la natura e l' ntità della c n u–
mazione. I tre componenti sono ora serviti separatamente, caldis imi sempre, a volontà e richi ta
della clientela: la voce
pur-e-/ior
chiede caffè e latte;
pur-e-barba
traduce
il
desiderio di caffè cioc–
colatte, un
po' 'd' 'ut
domanda la miscela eclettica dei diversi ingredienti. In un bicchiere a parte i
consegna la stissa che può essere di latte, ma di consueto è caffè. [. ..] Ogni olido immoUand ' ta –
sato invariabilmente a cinque centesimi e se ne hanno di quattordici pecie e tutte squi it :
rocion ,
Torcèt (giassà, granà, s/ojà), Tortiliéé, Savoiardina, Parisien, Foré, Brioss, Democràtich, Pupe d'monia,
Picol d'frà, Chzfel, Biciolan, Garibaldin
e
Michette di semola od al burro:
quante se ne po n desi –
derare cioè da qualunque, per quanto esigente, palato.
Mentre
il
caffè era visto dai suoi cantori come il luogo della socialità, della conv r–
sazione, della lettura, del contatto fra le classi, dove si esaltava la civiltà cittadina, l'ur–
banità appunto, l'osteria non era solo il luogo del meritato riposo serale e domenicale
della classe operaia ma anche il motore della degradazione e dell'alcolismo. li autori
di romanzi sociali fecero dell'osteria il teatro ideale per mettere in scena le tentazioni,
il luogo dove i protagonisti scivolavano verso l'abiezione senza riscatto; aiutati in que–
sto stereotipo, bisogna dirlo, dall'esempio del più illustre romanziere del loro tempo,
Alessandro Manzoni il quale, molto probabilmente, in una vera osteria non aveva mai
messo piede.
Ecco due descrizioni in negativo dell'osteria: la prima è tratta da un romanzo in
dialetto,
La Cracia,
di Carlo Bernardino Ferrer0
20 :
An
col stat Berto as na vnisia giù per via Pòrta Palatin·a fantasticand, senssa vedde gnun an facia ,
quand ch'a l'è sentisse ciamè per nòm: a l'ha dait ne sgoard a l'ingir e a l'ha vist Mini ch'a lo ciamava
sl'uss d'un boteghin da licorista. [. ..] A son intrà tuti e doi ant col negòsse d'velen. Quatr taolin a
l'ingir, un bancon al fond con na vasca de zinch, na stagera con diverse bote bianche pien-e d'liquid
d'tuti ij color.
An
col moment
n
an botega a j'era nen n'anima che lor doi e
'I
padron an fond del
banch ch'a lesia la gaseta del pòpol. Un quintin d'branda a l'è stait portà a la taola dij doi. [... ] Mini
a l'ha torna verssaie n'aotr cichet e l'ha comandà n'aotr quintin: Berto a l'avia l'anima ch'ai girava e
senssa ancorsessne a tirava tirava giù cola branda ch'a lo anciocava, tant pì chie! che a l'era nen
costumà. [. ..] Berto a l'ha tirà giù d'un fià
'I
bicerin d'branda. A l'era già
'I
setim bicerin ch'a tra–
vondìa. La vista ai tramolava già, a vedia tut dopi. L'osto a l'ha ancora portà un quintin ch'a l'è stait
beivù un pòch a la salute d'un e un pòch a la mòrt d'un aotr.
La
branda
è lo strumento con il quale Mini corrompe l'amico Berto e lo convince a
compiere un' azione malvagia e l'accordo viene siglato nel negozio di veleni con un
brindisi alla salute di uno e alla morte di un altro. Nel 1848 Pietro Corelli pubblicò a
puntate il romanzo
Viaggio costituzionale2
l ;
nel secondo capitolo intitolato
La
locanda,
il protagonista, che narrava in prima persona, faceva opera di proselitismo contro le
trame dei gesuiti in una locanda, che cosÌ descriveva:
La sala era illuminata dal gaz e pareva ravvolta nelle tenebre; la qualcosa mi fece alquanto perder
fede ai miracoli di quella luce sorella del sole.
.
.
. .
.
li
chiasso era grande. I garzoni giravano innanzi e indietro,
~
fretta e m
f~na
al serv.lZ1?
dell~
.vane
tavole e tavolieri. La locandiera dal suo trono volgeva a
tutti
tenere occhIate e grazIosI sornSI, - e
pensava poi come farli pagare ne! conto.
.
.
.
lo mi buttai a sedere in un angolo per essere meno osservato e per m:glio
oss~~are.
ConobbI
subl~o
i maravigliosi effetti dell'essere diventati uguali in faccia .alla
le.gg:~
-.1
garzoni
nspo
~deva.noall:
rru~
chiamate con una crollatina
di
spalle e correvano a servIre chI plU SI mostrava fulgIdo dI anelli e dI
catenelle.
Finalmente uno di essi mi si piantò innanzi con aria da paladino
~spe~tand~
i
n:
iei
or~i .
. . .
.
_ Ti avverto che io non sono allievo dei Gesuiti, e che ai saporetu e al dolcIumI prefensco I CIbI fortI
e nutritivi.
20 CARLO BERNARDINO FERRERa,
La
cracia,
Torino,
Andrea Viglongo
&
C.
editori, 1981 , p. 95 e sgg.
21
In «Museo scientifico, letterario ed artistico» cit.,
X(l848) , n. 22.
39


















