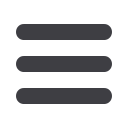
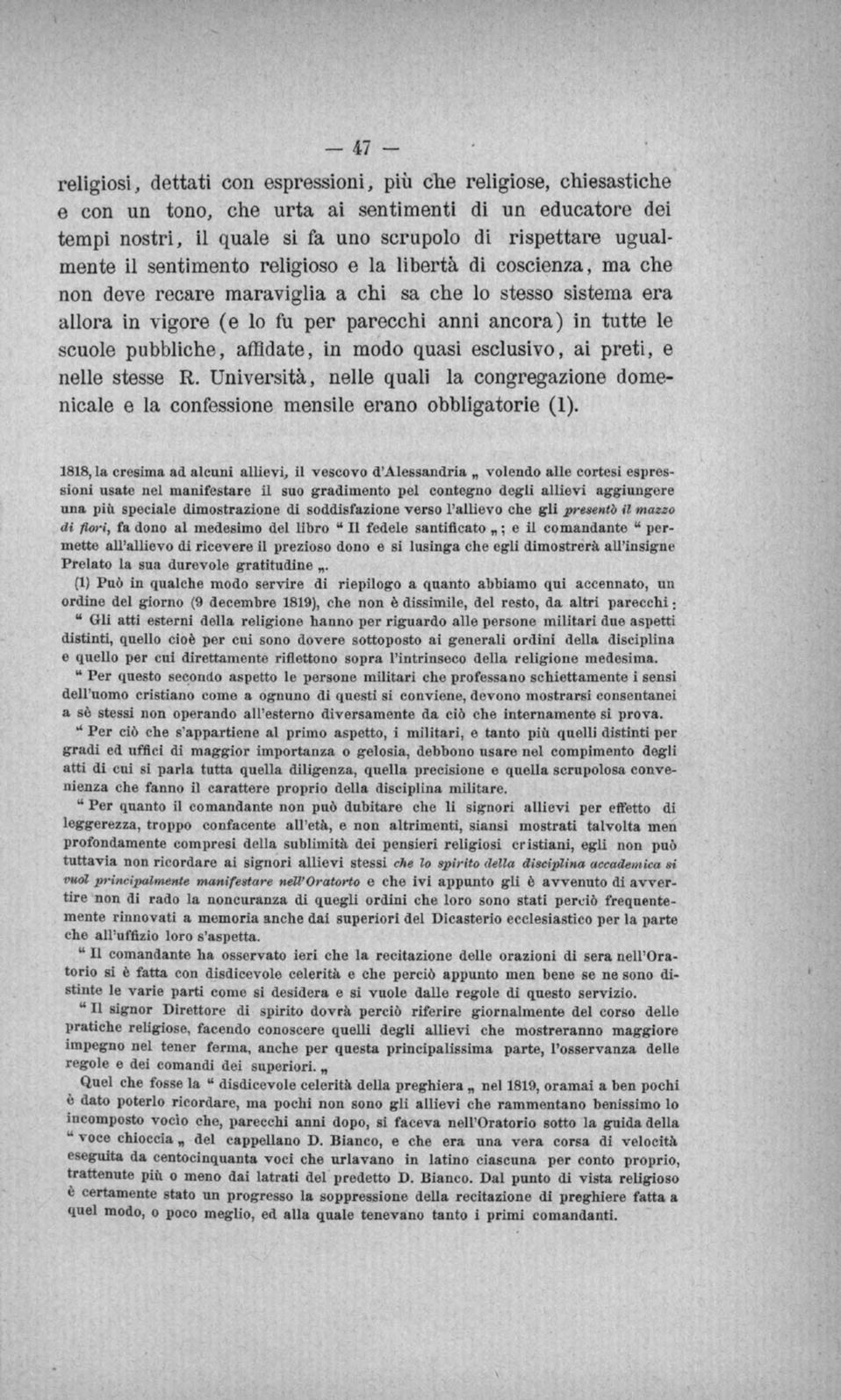
- 47
r eligiosi, dettati con espressioni , più che religiose, chiesastiche
e con un tono, che urta ai sentimenti di un educatore dei
tempi nostri , il quale si fa uno scrupo lo di rispettare ugual–
mente il sentimento religioso e la libertà di coscienza, ma che
non deve recare maraviglia a chi sa che lo stesso sistema era
allora in vigore (e lo fu per parecchi anni ancora) in tutte le
scuole pubbliche, affidate, in modo quasi esclusivo , ai preti, e
nelle stesse R. Università, nelle quali la congregazione dome–
nicale e la confessione mensile erano obbligatorie (l).
1818, la cresi ma ad al cuni allievi,
il
v escovo d'Alessandria" volendo alle cortesi espres–
sioni usat e nel manifestare
il
suo gradimento pel contegno degli allievi aggiunger e
una più speciale dimostrazione di soddisfazione v er so l'alli evo che gli
presentò
il
mazzo
di fiori,
fa dono al medesimo del libro " Il fedele saut ificato " ; e
il
coma ndante" per –
mette all 'allievo di ri cev er e
il
pr ezioso dono e si lusinga che egli dimo strer à all'insign e
Prelat o la sua durev ole gratìtudìne
ç.
(1) Pu ò in qualche modo ser vire di ri epilogo a quanto abbiamo qui accennato, un
ordine del giorno (9 decembre 1819), che non
è
dissimile, del resto, da altri parecchi:
" Gli atti esterni della religi one hanno per riguardo all e person e militari due as petti
distinti, quello cioè per cni sono dov er e sottoposto ai gen erali ordini della disciplina
e quello per cui direttament e riflettono sopr a l'intrinseco della religion e medesima.
" Per questo secondo aspetto le persone militari che pro fessano sch iettament e i sensi
dell'uomo
cristian~
come a ognuno di questi si conviene, devono mostrarsi consentanei
a
s è
stessi non operando all'esterno div ersamente da ciò che internament e si prova.
" Per ciò che s'ap partiene al pr imo aspetto, i militari, e tanto più qu elli distinti per
gradi ed uffici di maggior importanza o gelosia, debbono usare nel compimento degli
atti di cui si parla tutta quella diligenza, quella pr ecision e e quella scrupolosa conve–
nienza che fanno
il
carattere proprio della disciplina militar e.
" Per quanto
il
comandante non può dubitare che li signori allievi per effetto di
legger ezza, troppo confacente all'età, e non altrimenti, siansi mostrati tal volta men
profonda mente compres i della sublimità dei pensieri religiosi crìstìanì, egli non può
tuttav ia non ricordare ai signori all iev i stess i
che lo spirito <Iella disciplina accademica si
vuol
principalmente
manifestare nell'Oratorto
e che ivi appunto gli è avvenuto di
avver–
tire non di l'ad o la non curanza di quegli ordini che loro sono sta ti
perci ò
frequent e–
mente rin novati a memori a anche dai superiori del Dieasteri o ecclesiastico per la part e
che all 'uffizio loro s'aspetta.
" Il comandante ha osservato ieri che la recitazione dell e ora zioni di sera nell'Ora–
to rio si è fatta con disdi cevol e celerità e che perciò appunto men bene se ne sono di–
stinte le va rie parti com e si desidera e si vuole dalle r egol e di qu esto serv izio.
" Il signor Direttore di spirito dovrà per ciò riferire giornalment e del corso delle
pra tiche religiose, facendo conosce re quelli degli allievi che mostreranno maggiore
impegno nel tener ferma, anche per questa principalissima parte, l'o sservanza dell e
regole e dei coma ndi dei superiori. "
Quel che fosse la " disdi cevole celerità della pr eghiera " nel 1819, oramai a ben poch i
il
dato poterl o ricord are, ma pochi non sono gli allievi che rammentano beni ssimo lo
inco mposto voc io che, parecchi anni dopo, si fa ceva nell'Oratorio sotto la guida della
" voce chioccia" del cappellano D. Bi an co, e ch e era una v era corsa di v elocità
eseguita da centocinquanta vo ci che urlavano in latino ciascuna per conto proprio,
trattenute
più
o meno dai latrati del" pr edetto D. Bian co. Dal punto di vista religioso
il
certamente stato un progresso la soppress ione della re citazione di preghier e fatta a
que l modo, o poco meglio, ed alla quale tenevano tanto i primi comandanti.


















