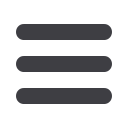
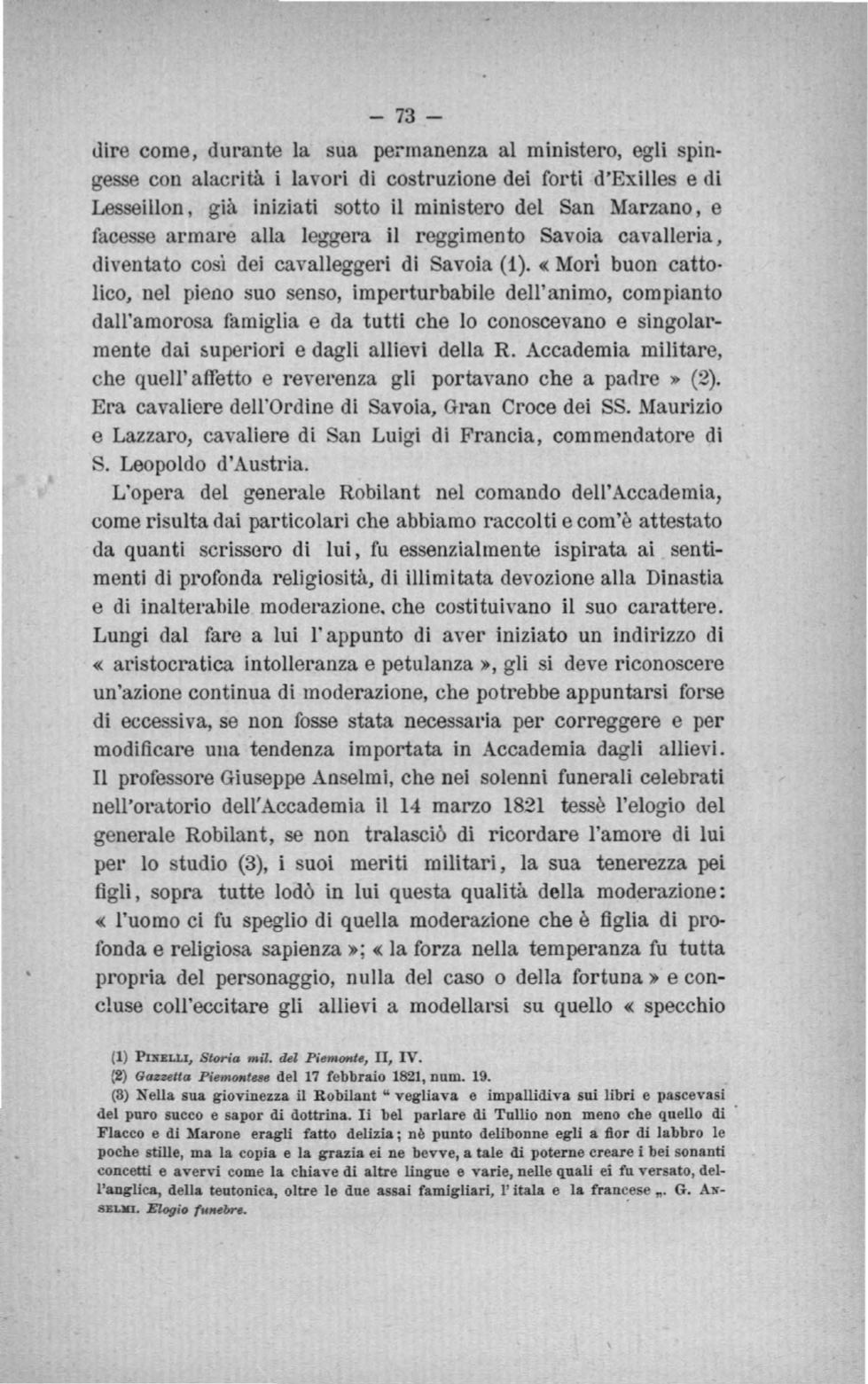
- 73 -
dire come , durante la sua permanenza al min istero, egli spin–
gesse con alacrità i lavori di costruzione dei forti d'Exilles e di
Lesseillon , già iniziati sotto il min istero del San Marzano, e
facesse armare alla leggera
il
r eggimento Savoia cavalleria ,
diventato così dei cavalleggeri di Savoia (1). «Mori buon catto–
lico, nel pieno suo senso, impe rturbabile dell'animo, compianto
dall'amorosa famiglia e da tutti che lo conoscevano e singolar–
mente dai superìorì e dagli allievi della R. Accademia militare,
che quell' affetto e reverenza gli portavano che a padre
»
(2).
Era cavaliere dell'Ordine di Savoia, Gra n Croce dei SS. Maurizio
e Lazzaro, cavaliere di San Luigi di Francia, commendatore di
S. Leopoldo d'Austria.
L'opera del generale Robilant nel comando dell'Accademia,
come r isulta dai particolari che abbiamo raccolti e com' è attestato
da quanti scrissero di lui , fu essenzialmente ispirata ai senti–
menti di profonda religioslt à, di illimitata devozione alla Dinastia
e di inalterabile mode razione. che costitu ivano
il
suo ca rattere.
Lungi dal fare a lui l' appunto di aver iniziato un indiri zzo di
«
aristocratica intolleranza e petulanza
»,
gli si deve riconoscere
un'azione continua di moderazione, che potrebbe appuntarsi forse
di eccessiva, se non fosse stata necessaria per correggere e per
modificare una tendenza importata in Accademia dagli alli evi.
Il professore Giuseppe Anselml , che nei solenni funerali celebrati
nell'oratorio dell'Accademia il 14 marzo 1821 tessè l'elogio del
generale Robilant, se non tralasciò di ricordare l'amore di lui
per lo studio (3), i suoi meriti militari, la sua tenerezza pei
figli , sopr a tutte lodò in lui questa qualità della moderazione:
«
l'uomo ci fu speglio di quella moderazione che è figlia di
PI'O–
fonda e religiosa sapienza »;
«
la forza nella temperanza fu tutta
propria del personaggio, nulla del caso o della fortuna » e con–
cluse coll' ecc itare gli allievi a modellarsi su quello
«
specchio
(1)
PISELLI,
Storia mito det Piemonte,
II, IV .
(2) Gazzetta Piemontese
del 17 febbraio 1821, num . 19.
(3) Nella sua giovinezza il R obilant "vegliava e imp allidiva sui libri e pasceva si
del puro succo e saper di dollrina. Ii bel parlare di Tullio non meno che qu ello di
FIacco e di :Marone eragli fallo delizia; nè punto delibonne egli a tlor di labbro le
poch e still e, ma la copia e la grazia ei ne bevve, a tale di poterne cr eare i bei sonanti
concetti e a vervi come la chiave di altre lingue e varie, nelle quali ei fu versato, del–
l'anglica, della teutonìca, oltre le due assai famigliari, l'itala e la francese
n'
G.
AN-
BELlI l .
Elogio funebre.
.


















