
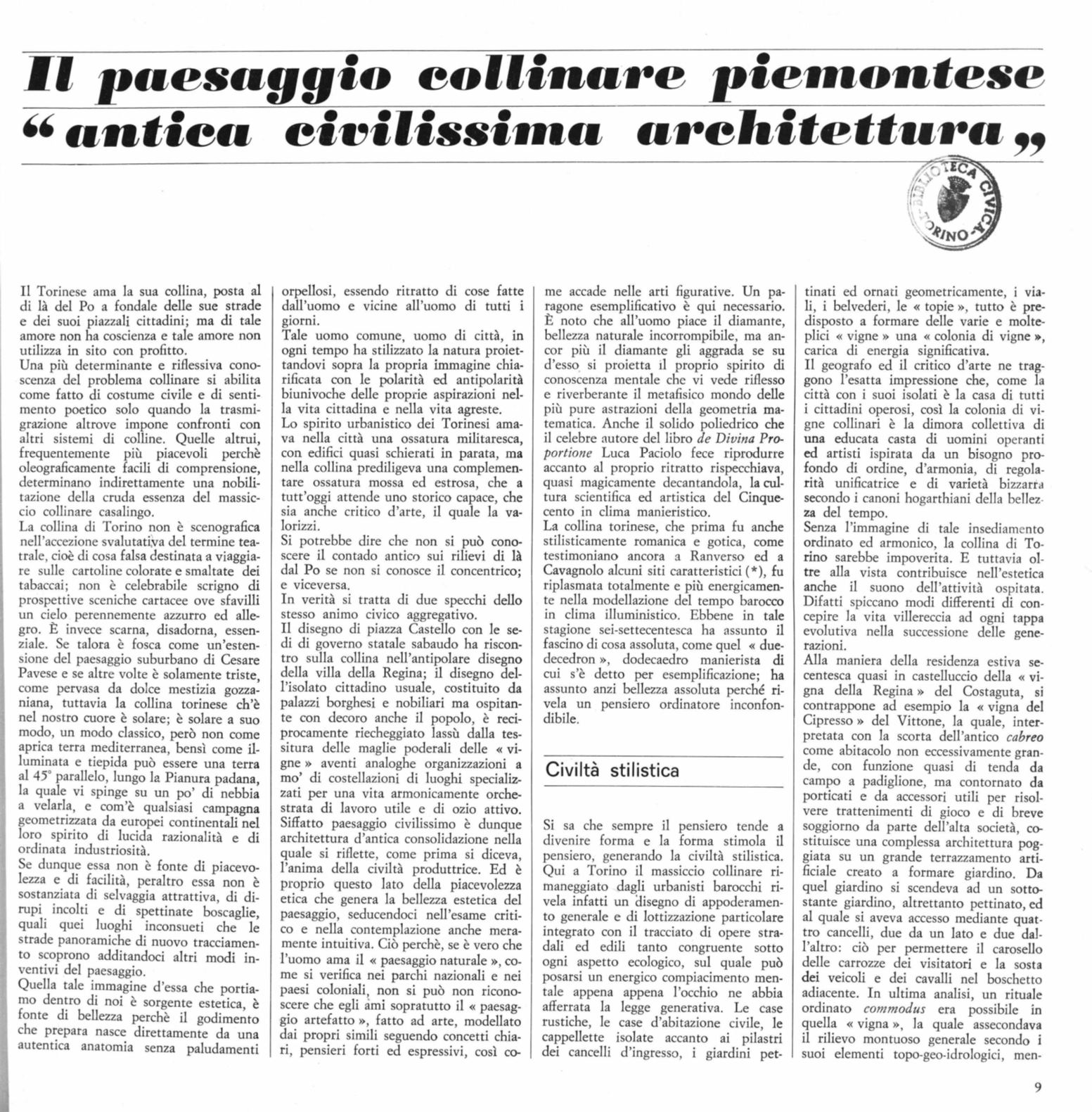
Il paesaggio collinare
pleDlontese
"antica cl",lllsslDla architettura
"
Il Torinese ama la sua collina, posta al
di là del Po a fondale delle sue strade
e dei suoi piazzali cittadini; ma di tale
amore non ha coscienza e tale amore non
utilizza in sito con profitto.
Una più determinante e riflessiva cono–
scenza del problema collinare si abilita
come fatto di costume civile e di senti–
mento poetico solo quando la trasmi–
grazione altrove impone confronti con
altri sistemi di colline. Quelle altrui,
frequentemente più piacevoli perchè
oleograficamente facili di comprensione,
determinano indirettamente una nobili–
tazione della cruda essenza del massic–
cio collinare casalingo.
La collina di Torino non è scenografica
nell'accezione svalutati,Va del termine tea–
trale, cioè di cosa falsa destinata a viaggia–
re sulle cartoline colorate e smaltate dei
tabaccai; non è celebrabile scrigno di
prospettive sceniche cartacee ove sfavilli
un cielo perennemente azzurro ed alle–
gro.
È
invece scarna, disadorna, essen–
ziale. Se talora è fosca come un'esten–
sione del paesaggio suburbano di Cesare
Pavese e se altre volte è solamente triste
come pervasa da dolce mestizia
gozza~
niana, tuttavia la collina torinese ch 'è
nel nostro cuore è solare; è solare a suo
modo, un modo classico, però non come
aprica terra mediterranea, bensÌ come
il–
luminata e tiepida può essere una terra
al 45" parallelo, lungo la Pianura padana,
la quale vi spinge su un po' di nebbia
a
velarl~,
e com'è qualsiasi campagna
geometrlzzata da europei continentali nel
loro spirito di lucida razionalità e di
ordinata industriosità.
Se dunque essa non è fonte di piacevo–
lezza e di facilità, peraltro essa non è
sostanziata di selvaggia attrattiva, di di–
rupi .
incol~i
e di spettinate boscaglie,
qual! quel luoghi inconsueti che le
strade panoramiche di nuovo tracciamen–
to scoprono additandoci altri modi in–
ventivi del paesaggio.
Quella tale immagine d'essa che portia–
mo dentro di noi è sorgente estetica è
fonte di bellezza perchè il
godime~to
che prepara nasce direttamente da una
autentica anatomia senza paludamenti
orpellosi, essendo ritratto di cose fatte
dall'uomo e vicine all'uomo di tutti i
giorni.
Tale uomo comune, uomo di città, in
ogni tempo ha stilizzato la natura proiet–
tandovi sopra la propria immagine chia–
rificata con le polarità ed antipolarità
biunivoche delle proprie aspirazioni nel–
la vita cittadina e nella vita agreste.
Lo spirito urbanistico dei Torinesi ama–
va nella città una ossatura militaresca,
con edifici quasi schierati in parata, ma
nella collina prediligeva una complemen–
tare ossatura mossa ed estrosa, che a
tutt'oggi attende uno storico capace, che
sia anche critico d'arte, il quale la va–
lorizzi.
Si potrebbe dire che non si può cono–
scere
il
contado antico sui rilievi di là
dal Po se non si conosce
il
concentrico;
e viceversa.
In verità si tratta di due specchi dello
stesso animo civico aggregativo.
Il disegno di piazza Castello con le se–
di di governo statale sabaudo ha riscon–
tro sulla collina nell'antipolare disegno
della villa della Regina;
il
disegno del–
l'isolato cittadino usuale, costituito da
palazzi borghesi e nobiliari ma ospitan–
te con decoro anche il popolo, è reci–
procamente riecheggiato lassù dalla tes–
situra delle maglie poderali delle «vi–
gne» aventi analoghe organizzazioni a
mo' di costellazioni di luoghi specializ–
zati per una vita armonicamente orche–
strata di lavoro utile e di ozio attivo.
Siffatto paesaggio civilissimo è dunque
architettura d'antica consolidazione nella
quale si riflette, come prima si diceva,
l'anima della civiltà produttrice. Ed è
proprio questo lato della piacevolezza
etica che genera la bellezza estetica del
paesaggio, seducendoci nell'esame criti–
co e nella contemplazione anche mera–
mente intuitiva. Ciò perchè, se è vero che
l'uomo ama
il
« paesaggio naturale », co–
me si verifica nei parchi nazionali e nei
paesi coloniali, non si può non ricono–
scere che egli àmi sopratutto
il
« paesag–
gio artefatto », fatto ad arte, modellato
dai propri simili seguendo concetti chia–
ri, pensieri forti ed espressivi, così co-
me accade nelle arti figurative. Un pa–
ragone esemplificativo
è
qui necessario.
È
noto che all'uomo piace
il
diamante,
bellezza naturale incorrompibile, ma an–
cor più il diamante gli aggrada se su
d'esso si proietta il proprio spirito di
conoscenza mentale che vi vede riflesso
e riverberante il metafisico mondo delle
più pure astrazioni della geometria ma–
tematica. Anche il solido poliedrico che
il celebre autore del libro
de Divina Pro–
portione
Luca Paciolo fece riprodurre
accanto al proprio ritratto rispecchiava,
quasi magicamente decantandola, la
cul–
tura scientifica ed artistica del Cinque–
cento in clima manieristico.
La collina torinese, che prima fu anche
stilisticamente romanica e gotica, come
testimoniano ancora a Ranverso ed a
Cavagnolo alcuni siti caratteristici (*), fu
riplasmata totalmente e più energicamen–
te nella modellazione del tempo barocco
in clima illuministico. Ebbene in tale
stagione sei-settecentesca ha assunto
il
fascino di cosa assoluta, come quel «due–
decedron », dodecaedro manierista di
cui s'è detto per esemplificazione; ha
assunto anzi bellezza assoluta perché ri–
vela un pensiero ordinatore inconfon–
dibile.
Civiltà stilistica
Si sa che sempre il pensiero tende a
divenire forma e la forma stimola
il
pensiero, generando la civiltà stilistica.
Qui a Torino il massiccio collinare ri–
maneggiato dagli urbanisti barocchi ri–
vela infatti un disegno di appoderamen–
to generale e di lottizzazione particolare
integrato con il tracciato di opere stra–
dali ed edili tanto congruente sotto
ogni aspetto ecologico, sul quale può
posarsi un energico compiacimento men–
tale appena appena l'occhio ne abbia
afferrata la legge generativa. Le case
rustiche, le case d'abitazione civile, le
cappellette isolate accanto ai pilastri
dei cancelli d'ingresso, i giardini pet-
tinati ed ornati geometricamente, i via–
li,
i belvederi, le « topie », tutto è pre–
disposto a formare delle varie e molte–
plici « vigne» una « colonia di vigne »,
carica di energia significativa.
Il geografo ed
il
critico d'arte ne trag–
gono l'esatta impressione che, come la
città con i suoi isolati è la casa di tu tti
i cittadini operosi, così la colonia di vi–
gne collinari
è
la dimora collettiva di
una educata casta di uomini operanti
ed artisti ispirata da un bisogno pro–
fondo di ordine, d'armonia, di regola–
rità unificatrice e di varietà bizzarra
secondo i canoni hogarthiani della bellez–
za del tempo.
Senza l'immagine di tale insediamento
ordinato ed armonico, la collina di To–
rino sarebbe impoverita. E tuttavia ol–
tre alla vista contribuisce nell'estetica
anche il suono dell'attività ospitata.
Difatti spiccano modi differenti di con–
cepire la vita villereccia ad ogni tappa
evolutiva nella successione delle gene–
razioni.
Alla maniera della residenza estiva se–
centesca quasi in castelluccio della « vi–
gna della Regina» del Costaguta, si
contrappone ad esempio la «vigna del
Cipresso» del Vittone, la quale, inter–
pretata con la scorta dell'antico
cabreo
come abitacolo non eccessivamente gran–
de, con funzione quasi di tenda da
campo a padiglione, ma contornato da
porticati e da accessori utili per risol–
vere trattenimenti di gioco e di breve
soggiorno da parte dell'alta società, co–
stituisce una complessa architettura pog–
giata su un grande terrazzamento arti–
ficiale creato a formare giardino. Da
quel giardino si scendeva ad un sotto–
stante giardino, altrettanto pettinato, ed
al quale si aveva accesso mediante quat–
tro cancelli, due da un lato e due dal–
l'altro: ciò per permettere il carosello
delle carrozze dei visitatori e la sosta
dei veicoli e dei cavalli nel boschetto
adiacente. In ultima analisi, un rituale
ordinato
commodus
era possibile in
quella «vigna », la quale assecondava
il rilievo montuoso generale secondo i
suoi elementi topo-geo-idrologici, men-
9


















