
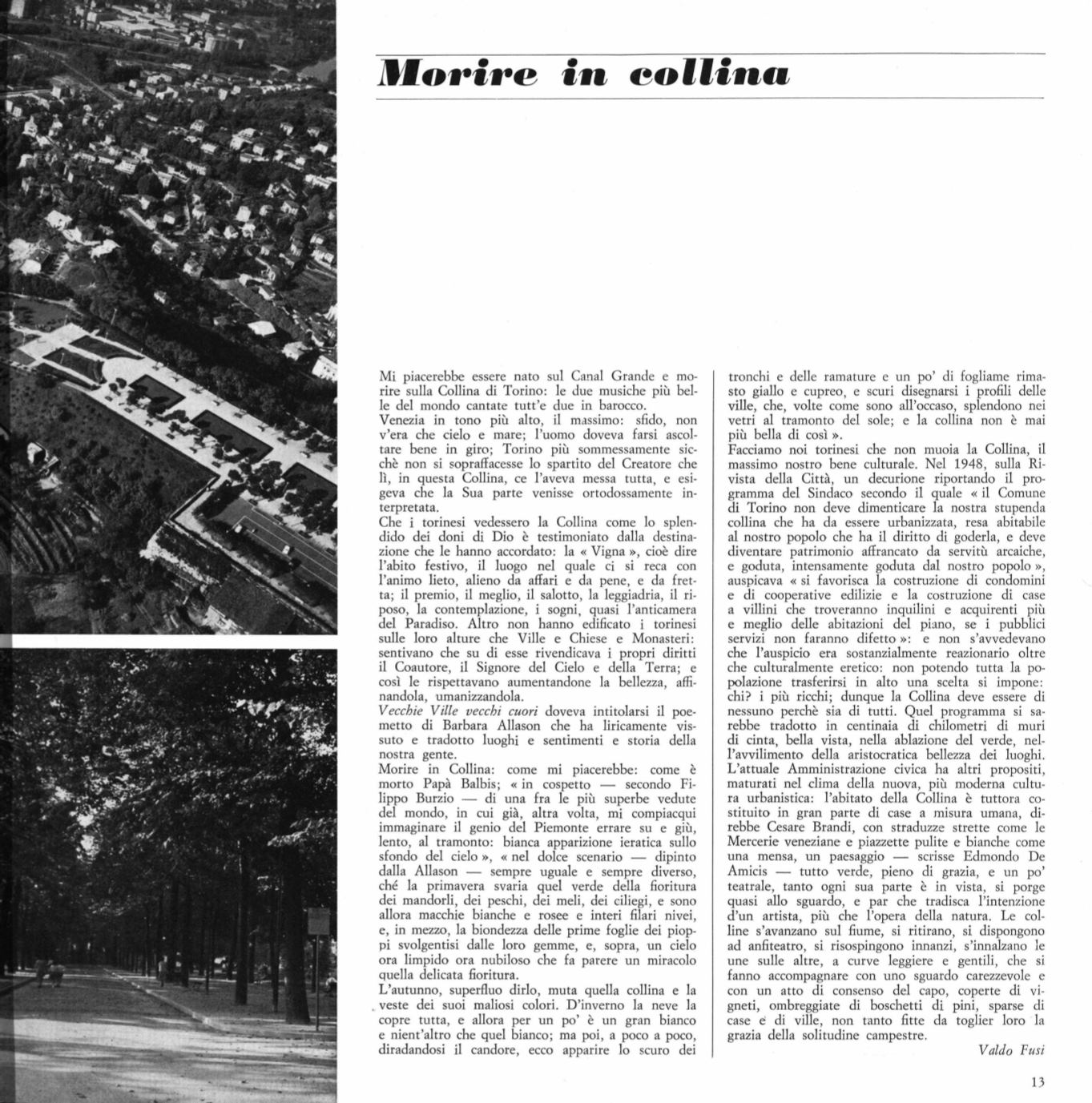
Morire
•
'IO
eollioo
Mi piacerebbe essere nato sul Canal Grande e mo–
rire sulla Collina di Torino: le due musiche più bel–
le del mondo cantate tutt'e due in barocco.
Venezia in tono più alto,
il
massimo: sfido, non
v'era che cielo e mare; l'uomo doveva farsi ascol–
tare bene in giro; Torino più sommessamente sic–
chè non si sopraffacesse lo spartito del Creatore che
lì,
in questa Collina, ce l'aveva messa tutta, e esi–
geva che la Sua parte venisse ortodossamente in–
terpretata.
Che i torinesi vedessero la Collina come lo splen–
dido dei doni di Dio è testimoniato dalla destina–
zione che le hanno accordato: la « Vigna
»,
cioè dire
l'abito festivo, il luogo nel quale ci si reca con
l'animo lieto, alieno da affari e da pene, e da fret–
ta;
il
premio, il meglio,
il
salotto, la leggiadria, il ri–
poso, la contemplazione, i sogni, quasi l'anticamera
del Paradiso. Altro non hanno edificato i torinesi
sulle loro alture che Ville e Chiese e Monasteri:
sentivano che su di esse rivendicava i propri diritti
il Coautore,
il
Signore del Cielo e della Terra; e
così le rispettavano aumentandone la bellezza, affi–
nandola, umanizzandola.
Vecchie Ville vecchi cuori
doveva intitolarsi
il
poe–
metto di Barbara Allason che ha liricamente vis–
suto e tradotto luoghi e sentimenti e storia della
nostra gente.
Morire in Collina: come mi piacerebbe: come è
morto Papà Balbis; «in cospetto - secondo Fi–
lippo Burzio - di una fra le più superbe vedute
del mondo, in cui già, altra volta, mi compiacqui
immaginare il genio del Piemonte errare su e giù,
lento, al tramonto: bianca apparizione ieratica sullo
sfondo del cielo
»,
«nel dolce scenario - dipinto
dalla Allason - sempre uguale e sempre diverso,
ché la primavera svaria quel verde della fioritura
dei mandorli, dei peschi, dei meli, dei ciliegi, e sono
allora macchie bianche e rosee e interi filari nivei,
e, in mezzo, la biondezza delle prime foglie dei piop–
pi svolgentisi dalle loro gemme, e, sopra, un cielo
ora limpido ora nubiloso che fa parere un miracolo
quella delicata fioritura.
L'autunno, superfluo dirlo, muta quella collina e la
• veste dei suoi maliosi colori. D'inverno la neve la
copre tutta, e allora per un po' è un gran bianco
e nient'altro che quel bianco; ma poi, a poco a poco,
diradandosi il candore, ecco apparire lo scuro dei
tronchi e delle ramature e un po' di fogliame rima–
sto giallo e cupreo, e scuri disegnarsi i profili delle
ville, che, volte come sono all'occaso, splendono nei
vetri al tramonto del sole; e la collina non è mai
più bella di così
».
Facciamo noi torinesi che non muoia la Collina,
il
massimo nostro bene culturale. Nel 1948, sulla Ri–
vista della Città, un decurione riportando
il
pro–
gramma del Sindaco secondo il quale «il Comune
di Torino non deve dimenticare la nostra stupenda
collina che ha da essere urbanizzata, resa abitabile
al nostro popolo che ha
il
diritto di goderla, e deve
diventare patrimonio affrancato da servitù arcaiche,
e goduta, intensamente goduta dal nostro popolo
»,
auspicava «si favorisca la costruzione di condomini
e di cooperative edilizie e la costruzione di case
a villini che troveranno inquilini e acquirenti più
e meglio delle abitazioni del piano, se i pubblici
servizi non faranno difetto
»:
e non s'avvedevano
che l'auspicio era sostanzialmente reazionario oltre
che culturalmente eretico: non potendo tutta la po–
polazione trasferirsi in alto una scelta si impone :
chi? i più ricchi; dunque la Collina deve essere di
nessuno perchè sia di tutti. Quel programma si sa–
rebbe tradotto in centinaia di chilometri di muri
di cinta, bella vista, nella ablazione del verde, nel–
l'avvilimento della aristocratica bellezza dei luoghi.
L'attuale Amministrazione civica ha altri propositi,
maturati nel clima della nuova, più moderna cultu–
ra urbanistica: l'abitato della Collina è tuttora co–
stituito in gran parte di case a misura umana, di–
rebbe Cesare Brandi, con straduzze strette come le
Mercerie veneziane e piazzette pulite e bianche come
una mensa, un paesaggio - scrisse Edmondo De
Amicis - tutto verde, pieno di grazia, e un po'
teatrale, tanto ogni sua parte è in vista, si porge
quasi allo sguardo, e par che tradisca l'intenzione
d'un artista, più che l'opera della natura. Le col–
line s'avanzano sul fiume, si ritirano, si dispongono
ad anfiteatro, si risospingono innanzi, s'innalzano le
une sulle altre, a curve leggiere e gentili, che si
fanno accompagnare con uno sguardo carezzevole e
con un atto di consenso del capo, coperte di vi–
gneti, ombreggiate di boschetti di pini, sparse di
case
e
di ville, non tanto fitte da toglier loro la
grazia della solitudine campestre.
Valda Fusi
13


















